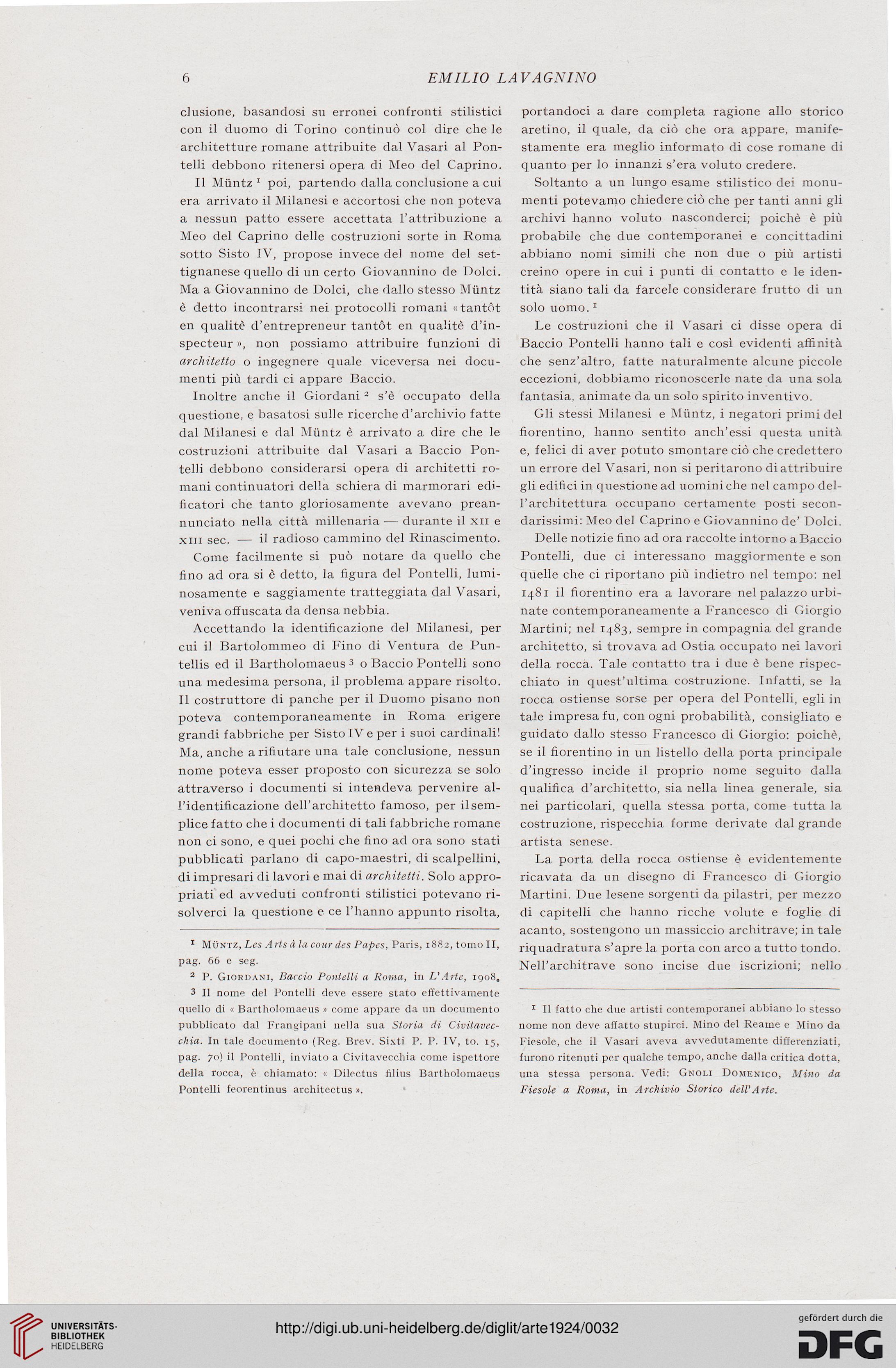6
EMILIO LA VAGNINO
clusione, basandosi su erronei confronti stilistici
con il duomo di Torino continuò col dire che le
architetture romane attribuite dal Vasari al Pon-
telli debbono ritenersi opera di Meo del Caprino.
Il Muntz 1 poi, partendo dalla conclusione a cui
era arrivato il Milanesi e accortosi che non poteva
a nessun patto essere accettata l'attribuzione a
Meo del Caprino delle costruzioni sorte in Roma
sotto Sisto IV, propose invece del nome del set-
tignanese quello di un certo Giovannino de Dolci.
Ma a Giovannino de Dolci, che dallo stesso Muntz
è detto incontrarsi nei protocolli romani « tantòt
en qualitè d'entrepreneur tantòt en qualitè d'in-
specteur », non possiamo attribuire funzioni di
architetto o ingegnere quale viceversa nei docu-
menti più tardi ci appare Baccio.
Inoltre anche il Giordani 2 s'è occupato della
questione, e basatosi sulle ricerche d'archivio fatte
dal Milanesi e dal Muntz è arrivato a dire che le
costruzioni attribuite dal Vasari a Baccio Pon-
telli debbono considerarsi opera di architetti ro-
mani continuatori della schiera di marmorari edi-
ficatori che tanto gloriosamente avevano prean-
nunciato nella città millenaria — durante il xn e
xiii sec. — il radioso cammino del Rinascimento.
Come facilmente si può notare da quello che
fino ad ora si è detto, la figura del Pontelli, lumi-
nosamente e saggiamente tratteggiata dal Vasari,
veniva offuscata da densa nebbia.
Accettando la identificazione del Milanesi, per
cui il Bartolommeo di Fino di Ventura de Pun-
tellis ed il Bartholomaeus 3 o Baccio Pontelli sono
una medesima persona, il problema appare risolto.
Il costruttore di panche per il Duomo pisano non
poteva contemporaneamente in Roma erigere
grandi fabbriche per Sisto IV e per i suoi cardinali!
Ma, anche a rifiutare una tale conclusione, nessun
nome poteva esser proposto con sicurezza se solo
attraverso i documenti si intendeva pervenire al-
l'identificazione dell'architetto famoso, per il sem-
plice fatto che i documenti di tali fabbriche romane
non ci sono, e quei pochi che fino ad ora sono stati
pubblicati parlano di capo-maestri, di scalpellini,
di impresari di lavori e mai di architetti. Solo appro-
priati ed avveduti confronti stilistici potevano ri-
solverci la questione e ce l'hanno appunto risolta,
1 Muntz, Lcs Aris à la cour des Papes, Paris, 1882, tomo II,
pag. 66 e scg.
2 P. Giordani, Baccio Pontelli a Roma, in L'Arte, 1908.
3 II nome del Pontelli deve essere stato effettivamente
quello di « Bartholomaeus » come appare da un documento
pubblicato dal Frangipani nella sua Storia di Civitavec-
chia. In tale documento (Reg. Brev. Sixti P. P. IV, to. 15,
pag. 70) il Pontelli, inviato a Civitavecchia come ispettore
della rocca, è chiamato: « Dilectus lilius Bartholomaeus
Pontelli feorentinus architectus ».
portandoci a dare completa ragione allo storico
aretino, il quale, da ciò che ora appare, manife-
stamente era meglio informato di cose romane di
quanto per lo innanzi s'era voluto credere.
Soltanto a un lungo esame stilistico dei monu-
menti potevamo chiedere ciò che per tanti anni gli
archivi hanno voluto nasconderci; poiché è più
probabile che due contemporanei e concittadini
abbiano nomi simili che non due o più artisti
creino opere in cui i punti di contatto e le iden-
tità siano tali da farcele considerare frutto di un
solo uomo.1
Le costruzioni che il Vasari ci disse opera di
Baccio Pontelli hanno tali e così evidenti affinità
che senz'altro, fatte naturalmente alcune piccole
eccezioni, dobbiamo riconoscerle nate da una sola
fantasia, animate da un solo spirito inventivo.
Gli stessi Milanesi e Muntz, i negatori primi del
fiorentino, hanno sentito anch'essi questa unità
e, felici di aver potuto smontare ciò che credettero
un errore del Vasari, non si peritarono di attribuire
gli edifici in questione ad uomini che nel campo del-
l'architettura occupano certamente posti secon-
darissimi: Meo del Caprino e Giovannino de' Dolci.
Delle notizie fino ad ora raccolte intorno a Baccio
Pontelli, due ci interessano maggiormente e son
quelle che ci riportano più indietro nel tempo: nel
1481 il fiorentino era a lavorare nel palazzo urbi-
nate contemporaneamente a Francesco di Giorgio
Martini; nel 1483, sempre in compagnia del grande
architetto, si trovava ad Ostia occupato nei lavori
della rocca. Tale contatto tra i due è bene rispec-
chiato in quest'ultima costruzione. Infatti, se la
rocca ostiense sorse per opera del Pontelli, egli in
tale impresa fu, con ogni probabilità, consigliato e
guidato dallo stesso Francesco di Giorgio: poiché,
se il fiorentino in un listello della porta principale
d'ingresso incide il proprio nome seguito dalla
qualifica d'architetto, sia nella linea generale, sia
nei particolari, quella stessa porta, come tutta la
costruzione, rispecchia forme derivate dal grande
artista senese.
La porta della rocca ostiense è evidentemente
ricavata da un disegno di Francesco di Giorgio
Martini. Due lesene sorgenti da pilastri, per mezzo
di capitelli che hanno ricche volute e foglie di
acanto, sostengono un massiccio architrave; in tale
riquadratura s'apre la porta con arco a tutto tondo.
Nell'architrave sono incise due iscrizioni; nello
1 II fatto che due artisti contemporanei abbiano lo stesso
nome non deve affatto stupirci. Mino del Reame e Mino da
Fiesole, che il Vasari aveva avvedutamente differenziati,
furono ritenuti per qualche tempo, anche dalla critica dotta,
una stessa persona. Vedi: Gnoli Domenico, Mino da
Fiesole a Roma, in Archivio Storico dell'Arte.
EMILIO LA VAGNINO
clusione, basandosi su erronei confronti stilistici
con il duomo di Torino continuò col dire che le
architetture romane attribuite dal Vasari al Pon-
telli debbono ritenersi opera di Meo del Caprino.
Il Muntz 1 poi, partendo dalla conclusione a cui
era arrivato il Milanesi e accortosi che non poteva
a nessun patto essere accettata l'attribuzione a
Meo del Caprino delle costruzioni sorte in Roma
sotto Sisto IV, propose invece del nome del set-
tignanese quello di un certo Giovannino de Dolci.
Ma a Giovannino de Dolci, che dallo stesso Muntz
è detto incontrarsi nei protocolli romani « tantòt
en qualitè d'entrepreneur tantòt en qualitè d'in-
specteur », non possiamo attribuire funzioni di
architetto o ingegnere quale viceversa nei docu-
menti più tardi ci appare Baccio.
Inoltre anche il Giordani 2 s'è occupato della
questione, e basatosi sulle ricerche d'archivio fatte
dal Milanesi e dal Muntz è arrivato a dire che le
costruzioni attribuite dal Vasari a Baccio Pon-
telli debbono considerarsi opera di architetti ro-
mani continuatori della schiera di marmorari edi-
ficatori che tanto gloriosamente avevano prean-
nunciato nella città millenaria — durante il xn e
xiii sec. — il radioso cammino del Rinascimento.
Come facilmente si può notare da quello che
fino ad ora si è detto, la figura del Pontelli, lumi-
nosamente e saggiamente tratteggiata dal Vasari,
veniva offuscata da densa nebbia.
Accettando la identificazione del Milanesi, per
cui il Bartolommeo di Fino di Ventura de Pun-
tellis ed il Bartholomaeus 3 o Baccio Pontelli sono
una medesima persona, il problema appare risolto.
Il costruttore di panche per il Duomo pisano non
poteva contemporaneamente in Roma erigere
grandi fabbriche per Sisto IV e per i suoi cardinali!
Ma, anche a rifiutare una tale conclusione, nessun
nome poteva esser proposto con sicurezza se solo
attraverso i documenti si intendeva pervenire al-
l'identificazione dell'architetto famoso, per il sem-
plice fatto che i documenti di tali fabbriche romane
non ci sono, e quei pochi che fino ad ora sono stati
pubblicati parlano di capo-maestri, di scalpellini,
di impresari di lavori e mai di architetti. Solo appro-
priati ed avveduti confronti stilistici potevano ri-
solverci la questione e ce l'hanno appunto risolta,
1 Muntz, Lcs Aris à la cour des Papes, Paris, 1882, tomo II,
pag. 66 e scg.
2 P. Giordani, Baccio Pontelli a Roma, in L'Arte, 1908.
3 II nome del Pontelli deve essere stato effettivamente
quello di « Bartholomaeus » come appare da un documento
pubblicato dal Frangipani nella sua Storia di Civitavec-
chia. In tale documento (Reg. Brev. Sixti P. P. IV, to. 15,
pag. 70) il Pontelli, inviato a Civitavecchia come ispettore
della rocca, è chiamato: « Dilectus lilius Bartholomaeus
Pontelli feorentinus architectus ».
portandoci a dare completa ragione allo storico
aretino, il quale, da ciò che ora appare, manife-
stamente era meglio informato di cose romane di
quanto per lo innanzi s'era voluto credere.
Soltanto a un lungo esame stilistico dei monu-
menti potevamo chiedere ciò che per tanti anni gli
archivi hanno voluto nasconderci; poiché è più
probabile che due contemporanei e concittadini
abbiano nomi simili che non due o più artisti
creino opere in cui i punti di contatto e le iden-
tità siano tali da farcele considerare frutto di un
solo uomo.1
Le costruzioni che il Vasari ci disse opera di
Baccio Pontelli hanno tali e così evidenti affinità
che senz'altro, fatte naturalmente alcune piccole
eccezioni, dobbiamo riconoscerle nate da una sola
fantasia, animate da un solo spirito inventivo.
Gli stessi Milanesi e Muntz, i negatori primi del
fiorentino, hanno sentito anch'essi questa unità
e, felici di aver potuto smontare ciò che credettero
un errore del Vasari, non si peritarono di attribuire
gli edifici in questione ad uomini che nel campo del-
l'architettura occupano certamente posti secon-
darissimi: Meo del Caprino e Giovannino de' Dolci.
Delle notizie fino ad ora raccolte intorno a Baccio
Pontelli, due ci interessano maggiormente e son
quelle che ci riportano più indietro nel tempo: nel
1481 il fiorentino era a lavorare nel palazzo urbi-
nate contemporaneamente a Francesco di Giorgio
Martini; nel 1483, sempre in compagnia del grande
architetto, si trovava ad Ostia occupato nei lavori
della rocca. Tale contatto tra i due è bene rispec-
chiato in quest'ultima costruzione. Infatti, se la
rocca ostiense sorse per opera del Pontelli, egli in
tale impresa fu, con ogni probabilità, consigliato e
guidato dallo stesso Francesco di Giorgio: poiché,
se il fiorentino in un listello della porta principale
d'ingresso incide il proprio nome seguito dalla
qualifica d'architetto, sia nella linea generale, sia
nei particolari, quella stessa porta, come tutta la
costruzione, rispecchia forme derivate dal grande
artista senese.
La porta della rocca ostiense è evidentemente
ricavata da un disegno di Francesco di Giorgio
Martini. Due lesene sorgenti da pilastri, per mezzo
di capitelli che hanno ricche volute e foglie di
acanto, sostengono un massiccio architrave; in tale
riquadratura s'apre la porta con arco a tutto tondo.
Nell'architrave sono incise due iscrizioni; nello
1 II fatto che due artisti contemporanei abbiano lo stesso
nome non deve affatto stupirci. Mino del Reame e Mino da
Fiesole, che il Vasari aveva avvedutamente differenziati,
furono ritenuti per qualche tempo, anche dalla critica dotta,
una stessa persona. Vedi: Gnoli Domenico, Mino da
Fiesole a Roma, in Archivio Storico dell'Arte.