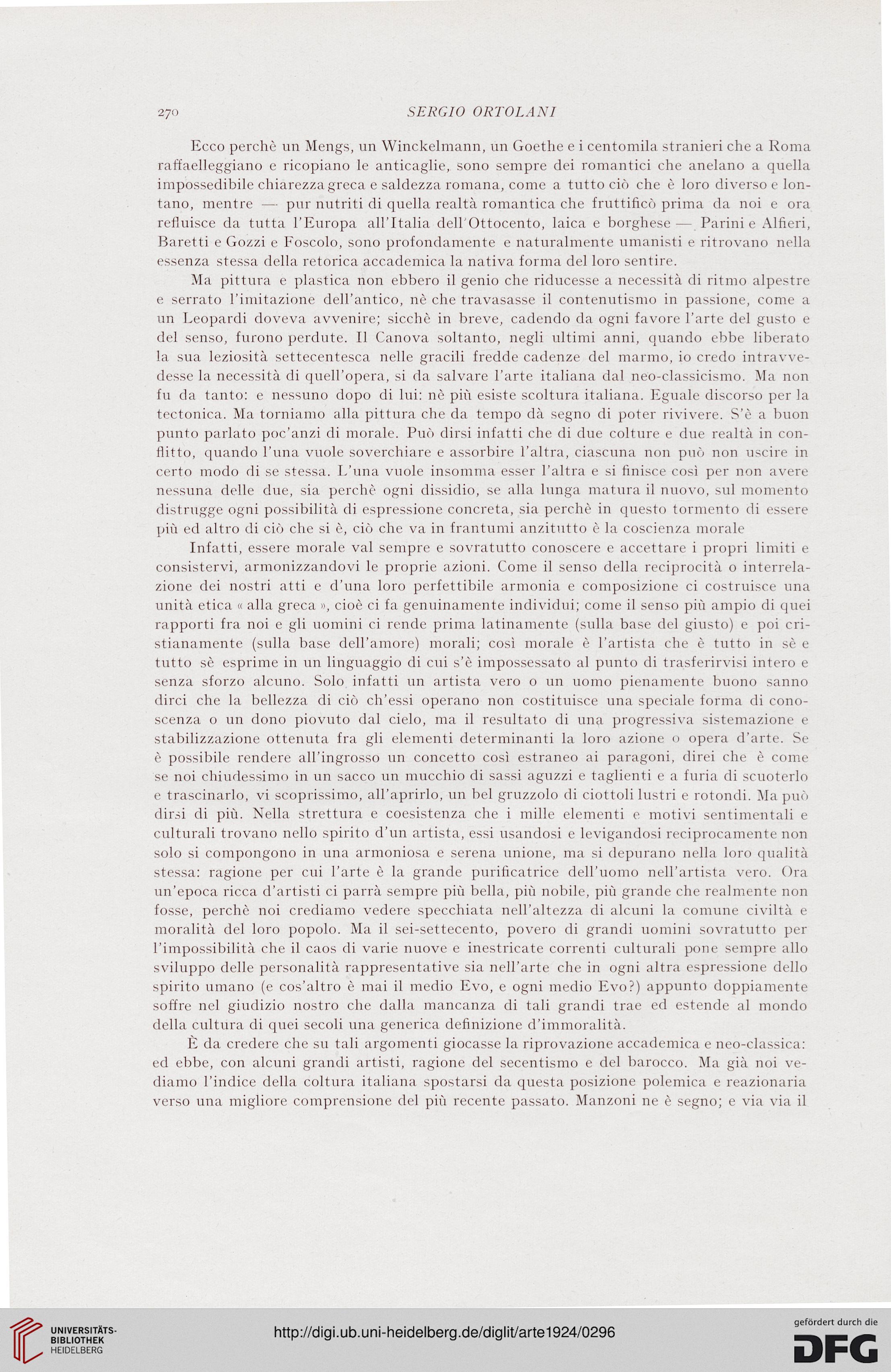270
SERGIO ORTOLANI
Ecco perchè un Mengs, un Winckelmann, un Goethe e i centomila stranieri che a Roma
raffaelleggiano e ricopiano le anticaglie, sono sempre dei romantici che anelano a quella
impossedibile chiarezza greca e saldezza romana, come a tutto ciò che è loro diverso e lon-
tano, mentre — pur nutriti di quella realtà romantica che fruttificò prima da noi e ora
refluisce da tutta l'Europa all'Italia dell'Ottocento, laica e borghese— Parini e Alfieri,
Baretti e Gozzi e Foscolo, sono profondamente e naturalmente umanisti e ritrovano nella
essenza stessa della retorica accademica la nativa forma del loro sentire.
Ma pittura e plastica non ebbero il genio che riducesse a necessità di ritmo alpestre
e serrato l'imitazione dell'antico, nè che travasasse il contenutismo in passione, come a
un Leopardi doveva avvenire; sicché in breve, cadendo da ogni favore l'arte del gusto e
del senso, furono perdute. Il Canova soltanto, negli ultimi anni, (piando ebbe liberato
la sua leziosità settecentesca nelle gracili fredde cadenze del marmo, io credo intrave-
desse la necessità di quell'opera, si da salvare l'arte italiana dal neo-classicismo. Ma non
fu da tanto: e nessuno dopo di lui: nè più esiste scoltura italiana. Eguale discorso per la
tectonica. Ma torniamo alla pittura che da tempo dà segno di poter rivivere. S'è a buon
punto parlato poc'anzi di morale. Può dirsi infatti che di due colture e due realtà in con-
flitto, quando l'una vuole soverchiare e assorbire l'altra, ciascuna non può non uscire in
certo modo di se stessa. L'una vuole insomma esser l'altra e si finisce così per non avere
nessuna delle due, sia perchè ogni dissidio, se alla lunga matura il nuovo, sul momento
distrugge ogni possibilità di espressione concreta, sia perchè in questo tormento di essere
più ed altro di ciò che si è, ciò che va in frantumi anzitutto è la coscienza morale
Infatti, essere morale vai sempre e sovratutto conoscere e accettare i propri limiti e
consistervi, armonizzandovi le proprie azioni. Come il senso della reciprocità o interrela-
zione dei nostri atti e d'una loro perfettibile armonia e composizione ci costruisce una
unità etica « alla greca », cioè ci fa genuinamente individui; come il senso più ampio di quei
rapporti fra noi e gli uomini ci rende prima latinamente (sulla base del giusto) e poi cri-
stianamente (sulla base dell'amore) morali; così morale è l'artista che è tutto in sè e
tutto sè esprime in un linguaggio di cui s'è impossessato al punto di trasferirvisi intero e
senza sforzo alcuno. Solo infatti un artista vero o un uomo pienamente buono sanno
dirci che la bellezza di ciò ch'essi operano non costituisce una speciale forma di cono-
scenza o un dono piovuto dal cielo, ma il resultato di una progressiva sistemazione e
stabilizzazione ottenuta fra gli elementi determinanti la loro azione o opera d'arte. Se
è possibile rendere all'ingrosso un concetto così estraneo ai paragoni, direi che è come
se noi chiudessimo in un sacco un mucchio di sassi aguzzi e taglienti e a furia di scuoterlo
e trascinarlo, vi scoprissimo, all'aprirlo, un bel gruzzolo di ciottoli lustri e rotondi. Ma può
dirsi di più. Nella strettura e coesistenza che i mille elementi e motivi sentimentali e
culturali trovano nello spirito d'un artista, essi usandosi e levigandosi reciprocamente non
solo si compongono in una armoniosa e serena unione, ma si depurano nella loro qualità
stessa: ragione per cui l'arte è la grande purificatrice dell'uomo nell'artista vero. Ora
un'epoca ricca d'artisti ci parrà sempre più bella, più nobile, più grande che realmente non
fosse, perchè noi crediamo vedere specchiata nell'altezza di alcuni la comune civiltà e
moralità del loro popolo. Ma il sei-settecento, povero di grandi uomini sovratutto per
l'impossibilità che il caos di varie nuove e inestricate correnti culturali pone sempre allo
sviluppo delle personalità rappresentative sia nell'arte che in ogni altra espressione dello
spirito umano (e cos'altro è mai il medio Evo, e ogni medio Evo?) appunto doppiamente
soffre nel giudizio nostro che dalla mancanza di tali grandi trae ed estende al mondo
della cultura di quei secoli una generica definizione d'immoralità.
E da credere che su tali argomenti giocasse la riprovazione accademica e neo-classica:
ed ebbe, con alcuni grandi artisti, ragione del secentismo e del barocco. Ma già noi ve-
diamo l'indice della coltura italiana spostarsi da questa posizione polemica e reazionaria
verso una migliore comprensione del più recente passato. Manzoni ne è segno; e via via il
SERGIO ORTOLANI
Ecco perchè un Mengs, un Winckelmann, un Goethe e i centomila stranieri che a Roma
raffaelleggiano e ricopiano le anticaglie, sono sempre dei romantici che anelano a quella
impossedibile chiarezza greca e saldezza romana, come a tutto ciò che è loro diverso e lon-
tano, mentre — pur nutriti di quella realtà romantica che fruttificò prima da noi e ora
refluisce da tutta l'Europa all'Italia dell'Ottocento, laica e borghese— Parini e Alfieri,
Baretti e Gozzi e Foscolo, sono profondamente e naturalmente umanisti e ritrovano nella
essenza stessa della retorica accademica la nativa forma del loro sentire.
Ma pittura e plastica non ebbero il genio che riducesse a necessità di ritmo alpestre
e serrato l'imitazione dell'antico, nè che travasasse il contenutismo in passione, come a
un Leopardi doveva avvenire; sicché in breve, cadendo da ogni favore l'arte del gusto e
del senso, furono perdute. Il Canova soltanto, negli ultimi anni, (piando ebbe liberato
la sua leziosità settecentesca nelle gracili fredde cadenze del marmo, io credo intrave-
desse la necessità di quell'opera, si da salvare l'arte italiana dal neo-classicismo. Ma non
fu da tanto: e nessuno dopo di lui: nè più esiste scoltura italiana. Eguale discorso per la
tectonica. Ma torniamo alla pittura che da tempo dà segno di poter rivivere. S'è a buon
punto parlato poc'anzi di morale. Può dirsi infatti che di due colture e due realtà in con-
flitto, quando l'una vuole soverchiare e assorbire l'altra, ciascuna non può non uscire in
certo modo di se stessa. L'una vuole insomma esser l'altra e si finisce così per non avere
nessuna delle due, sia perchè ogni dissidio, se alla lunga matura il nuovo, sul momento
distrugge ogni possibilità di espressione concreta, sia perchè in questo tormento di essere
più ed altro di ciò che si è, ciò che va in frantumi anzitutto è la coscienza morale
Infatti, essere morale vai sempre e sovratutto conoscere e accettare i propri limiti e
consistervi, armonizzandovi le proprie azioni. Come il senso della reciprocità o interrela-
zione dei nostri atti e d'una loro perfettibile armonia e composizione ci costruisce una
unità etica « alla greca », cioè ci fa genuinamente individui; come il senso più ampio di quei
rapporti fra noi e gli uomini ci rende prima latinamente (sulla base del giusto) e poi cri-
stianamente (sulla base dell'amore) morali; così morale è l'artista che è tutto in sè e
tutto sè esprime in un linguaggio di cui s'è impossessato al punto di trasferirvisi intero e
senza sforzo alcuno. Solo infatti un artista vero o un uomo pienamente buono sanno
dirci che la bellezza di ciò ch'essi operano non costituisce una speciale forma di cono-
scenza o un dono piovuto dal cielo, ma il resultato di una progressiva sistemazione e
stabilizzazione ottenuta fra gli elementi determinanti la loro azione o opera d'arte. Se
è possibile rendere all'ingrosso un concetto così estraneo ai paragoni, direi che è come
se noi chiudessimo in un sacco un mucchio di sassi aguzzi e taglienti e a furia di scuoterlo
e trascinarlo, vi scoprissimo, all'aprirlo, un bel gruzzolo di ciottoli lustri e rotondi. Ma può
dirsi di più. Nella strettura e coesistenza che i mille elementi e motivi sentimentali e
culturali trovano nello spirito d'un artista, essi usandosi e levigandosi reciprocamente non
solo si compongono in una armoniosa e serena unione, ma si depurano nella loro qualità
stessa: ragione per cui l'arte è la grande purificatrice dell'uomo nell'artista vero. Ora
un'epoca ricca d'artisti ci parrà sempre più bella, più nobile, più grande che realmente non
fosse, perchè noi crediamo vedere specchiata nell'altezza di alcuni la comune civiltà e
moralità del loro popolo. Ma il sei-settecento, povero di grandi uomini sovratutto per
l'impossibilità che il caos di varie nuove e inestricate correnti culturali pone sempre allo
sviluppo delle personalità rappresentative sia nell'arte che in ogni altra espressione dello
spirito umano (e cos'altro è mai il medio Evo, e ogni medio Evo?) appunto doppiamente
soffre nel giudizio nostro che dalla mancanza di tali grandi trae ed estende al mondo
della cultura di quei secoli una generica definizione d'immoralità.
E da credere che su tali argomenti giocasse la riprovazione accademica e neo-classica:
ed ebbe, con alcuni grandi artisti, ragione del secentismo e del barocco. Ma già noi ve-
diamo l'indice della coltura italiana spostarsi da questa posizione polemica e reazionaria
verso una migliore comprensione del più recente passato. Manzoni ne è segno; e via via il