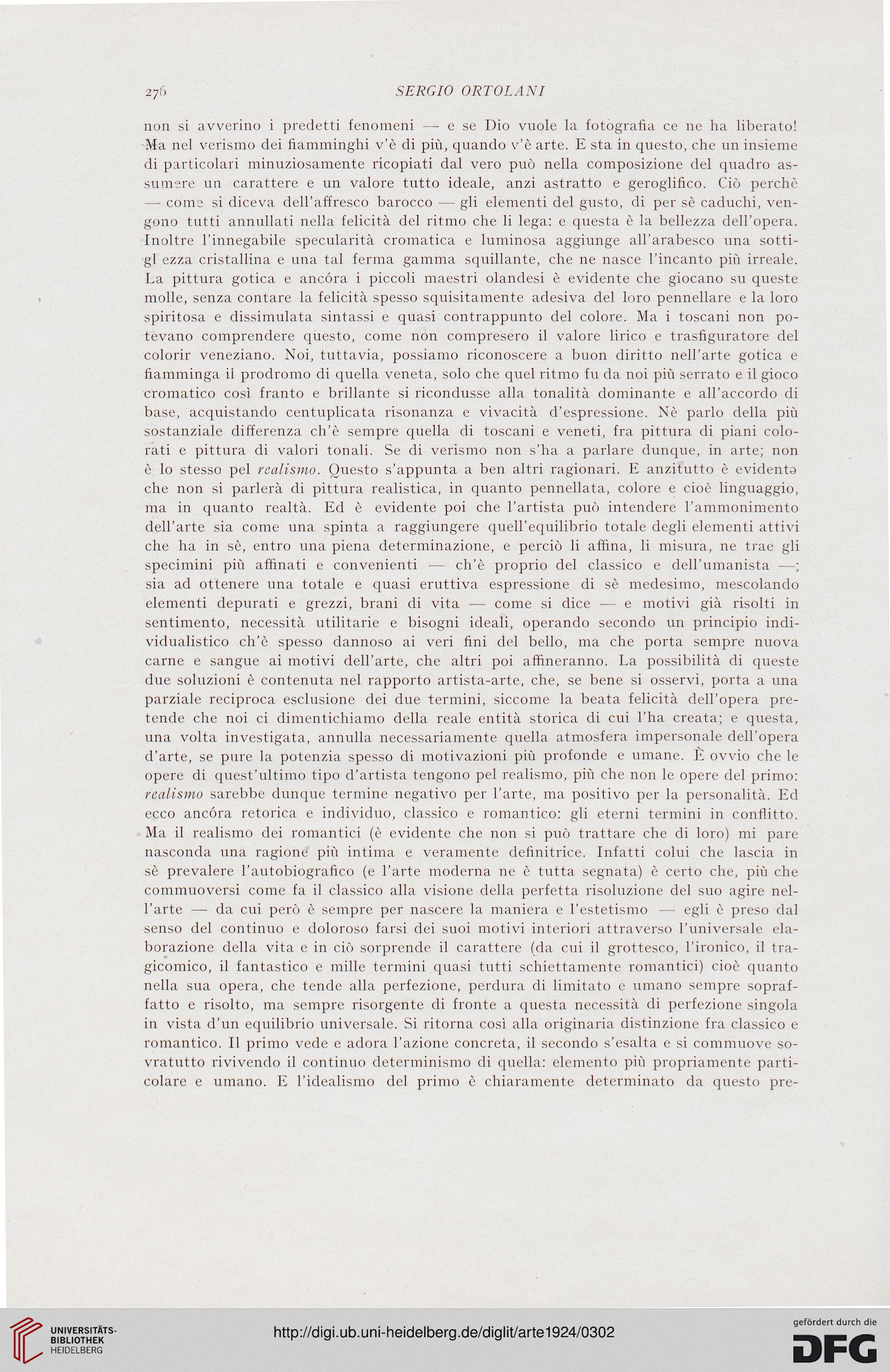276
SERGIO ORTOLANI
non si avverino i predetti fenomeni — e se Dio vuole la fotografia ce ne ha liberato!
Ma nel verismo dei fiamminghi v'è di più, quando v'è arte. E sta in questo, che un insieme
di particolari minuziosamente ricopiati dal vero può nella composizione del quadro as-
sumere un carattere e un valore tutto ideale, anzi astratto e geroglifico. Ciò perchè
— coma si diceva dell'affresco barocco — gli elementi del gusto, di per sè caduchi, ven-
gono tutti annullati nella felicità del ritmo che li lega: e questa è la bellezza dell'opera.
Inoltre l'innegabile specularità cromatica e luminosa aggiunge all'arabesco una sotti-
li ezza cristallina e una tal ferma gamma squillante, che ne nasce l'incanto più irreale.
La pittura gotica e ancóra i piccoli maestri olandesi è evidente che giocano su queste
molle, senza contare la felicità spesso squisitamente adesiva del loro pennellare e la loro
spiritosa e dissimulata sintassi e quasi contrappunto del colore. Ma i toscani non po-
tevano comprendere questo, come non compresero il valore lirico e trasfiguratore del
colorir veneziano. Noi, tuttavia, possiamo riconoscere a buon diritto nell'arte gotica e
fiamminga il prodromo di quella veneta, solo che quel ritmo fu da noi più serrato e il gioco
cromatico così franto e brillante si ricondusse alla tonalità dominante e all'accordo di
base, acquistando centuplicata risonanza e vivacità d'espressione. Nè parlo della più
sostanziale differenza ch'è sempre quella di toscani e veneti, fra pittura di piani colo-
rati e pittura di valori tonali. Se di verismo non s'ha a parlare dunque, in arte; non
è lo stesso pel realismo. Questo s'appunta a ben altri ragionari. E anzitutto è evidenta
che non si parlerà di pittura realistica, in quanto pennellata, colore e cioè linguaggio,
ma in quanto realtà. Ed è evidente poi che l'artista può intendere l'ammonimento
dell'arte sia come una spinta a raggiungere quell'equilibrio totale degli elementi attivi
che ha in sè, entro una piena determinazione, e perciò li affina, li misura, ne trae gli
specimini più affinati e convenienti • ch'è proprio del classico e dell'umanista —;
sia ad ottenere una totale e quasi eruttiva espressione di sè medesimo, mescolando
elementi depurati e grezzi, brani di vita — come si dice — e motivi già risolti in
sentimento, necessità utilitarie e bisogni ideali, operando secondo un principio indi-
vidualistico ch'è spesso dannoso ai veri fini del bello, ma che porta sempre nuova
carne e sangue ai motivi dell'arte, che altri poi affineranno. La possibilità di queste
due soluzioni è contenuta nel rapporto artista-arte, che, se bene si osservi, porta a una
parziale reciproca esclusione dei due termini, siccome la beata felicità dell'opera pre-
tende che noi ci dimentichiamo della reale entità storica di cui l'ha creata; e questa,
una volta investigata, annulla necessariamente quella atmosfera impersonale dell'opera
d'arte, se pure la potenzia spesso di motivazioni più profonde e umane. È ovvio che le
opere di quest'ultimo tipo d'artista tengono pel realismo, più che non le opere del primo:
realismo sarebbe dunque termine negativo per l'arte, ma positivo per la personalità. Ed
ecco ancóra retorica e individuo, classico e romantico: gli eterni termini in conflitto.
Ma il realismo dei romantici (è evidente che non si può trattare che di loro) mi pare
nasconda una ragione più intima e veramente definitrice. Infatti colui che lascia in
sè prevalere l'autobiografico (e l'arte moderna ne è tutta segnata) è certo che, più che
commuoversi come fa il classico alla visione della perfetta risoluzione del suo agire nel-
l'arte — da cui però è sempre per nascere la maniera e l'estetismo — egli è preso dal
senso del continuo e doloroso farsi dei suoi motivi interiori attraverso l'universale ela-
borazione della vita e in ciò sorprende il carattere (da cui il grottesco, l'ironico, il tra-
gicomico, il fantastico e mille termini quasi tutti schiettamente romantici) cioè quanto
nella sua opera, che tende alla perfezione, perdura di limitato e umano sempre sopraf-
fatto e risolto, ma sempre risorgente di fronte a questa necessità di perfezione singola
in vista d'un equilibrio universale. Si ritorna così alla originaria distinzione fra classico e
romantico. Il primo vede e adora l'azione concreta, il secondo s'esalta e si commuove so-
vratutto rivivendo il continuo determinismo di quella: elemento più propriamente parti-
colare e umano. lì l'idealismo del primo è chiaramente determinato da questo pre-
SERGIO ORTOLANI
non si avverino i predetti fenomeni — e se Dio vuole la fotografia ce ne ha liberato!
Ma nel verismo dei fiamminghi v'è di più, quando v'è arte. E sta in questo, che un insieme
di particolari minuziosamente ricopiati dal vero può nella composizione del quadro as-
sumere un carattere e un valore tutto ideale, anzi astratto e geroglifico. Ciò perchè
— coma si diceva dell'affresco barocco — gli elementi del gusto, di per sè caduchi, ven-
gono tutti annullati nella felicità del ritmo che li lega: e questa è la bellezza dell'opera.
Inoltre l'innegabile specularità cromatica e luminosa aggiunge all'arabesco una sotti-
li ezza cristallina e una tal ferma gamma squillante, che ne nasce l'incanto più irreale.
La pittura gotica e ancóra i piccoli maestri olandesi è evidente che giocano su queste
molle, senza contare la felicità spesso squisitamente adesiva del loro pennellare e la loro
spiritosa e dissimulata sintassi e quasi contrappunto del colore. Ma i toscani non po-
tevano comprendere questo, come non compresero il valore lirico e trasfiguratore del
colorir veneziano. Noi, tuttavia, possiamo riconoscere a buon diritto nell'arte gotica e
fiamminga il prodromo di quella veneta, solo che quel ritmo fu da noi più serrato e il gioco
cromatico così franto e brillante si ricondusse alla tonalità dominante e all'accordo di
base, acquistando centuplicata risonanza e vivacità d'espressione. Nè parlo della più
sostanziale differenza ch'è sempre quella di toscani e veneti, fra pittura di piani colo-
rati e pittura di valori tonali. Se di verismo non s'ha a parlare dunque, in arte; non
è lo stesso pel realismo. Questo s'appunta a ben altri ragionari. E anzitutto è evidenta
che non si parlerà di pittura realistica, in quanto pennellata, colore e cioè linguaggio,
ma in quanto realtà. Ed è evidente poi che l'artista può intendere l'ammonimento
dell'arte sia come una spinta a raggiungere quell'equilibrio totale degli elementi attivi
che ha in sè, entro una piena determinazione, e perciò li affina, li misura, ne trae gli
specimini più affinati e convenienti • ch'è proprio del classico e dell'umanista —;
sia ad ottenere una totale e quasi eruttiva espressione di sè medesimo, mescolando
elementi depurati e grezzi, brani di vita — come si dice — e motivi già risolti in
sentimento, necessità utilitarie e bisogni ideali, operando secondo un principio indi-
vidualistico ch'è spesso dannoso ai veri fini del bello, ma che porta sempre nuova
carne e sangue ai motivi dell'arte, che altri poi affineranno. La possibilità di queste
due soluzioni è contenuta nel rapporto artista-arte, che, se bene si osservi, porta a una
parziale reciproca esclusione dei due termini, siccome la beata felicità dell'opera pre-
tende che noi ci dimentichiamo della reale entità storica di cui l'ha creata; e questa,
una volta investigata, annulla necessariamente quella atmosfera impersonale dell'opera
d'arte, se pure la potenzia spesso di motivazioni più profonde e umane. È ovvio che le
opere di quest'ultimo tipo d'artista tengono pel realismo, più che non le opere del primo:
realismo sarebbe dunque termine negativo per l'arte, ma positivo per la personalità. Ed
ecco ancóra retorica e individuo, classico e romantico: gli eterni termini in conflitto.
Ma il realismo dei romantici (è evidente che non si può trattare che di loro) mi pare
nasconda una ragione più intima e veramente definitrice. Infatti colui che lascia in
sè prevalere l'autobiografico (e l'arte moderna ne è tutta segnata) è certo che, più che
commuoversi come fa il classico alla visione della perfetta risoluzione del suo agire nel-
l'arte — da cui però è sempre per nascere la maniera e l'estetismo — egli è preso dal
senso del continuo e doloroso farsi dei suoi motivi interiori attraverso l'universale ela-
borazione della vita e in ciò sorprende il carattere (da cui il grottesco, l'ironico, il tra-
gicomico, il fantastico e mille termini quasi tutti schiettamente romantici) cioè quanto
nella sua opera, che tende alla perfezione, perdura di limitato e umano sempre sopraf-
fatto e risolto, ma sempre risorgente di fronte a questa necessità di perfezione singola
in vista d'un equilibrio universale. Si ritorna così alla originaria distinzione fra classico e
romantico. Il primo vede e adora l'azione concreta, il secondo s'esalta e si commuove so-
vratutto rivivendo il continuo determinismo di quella: elemento più propriamente parti-
colare e umano. lì l'idealismo del primo è chiaramente determinato da questo pre-