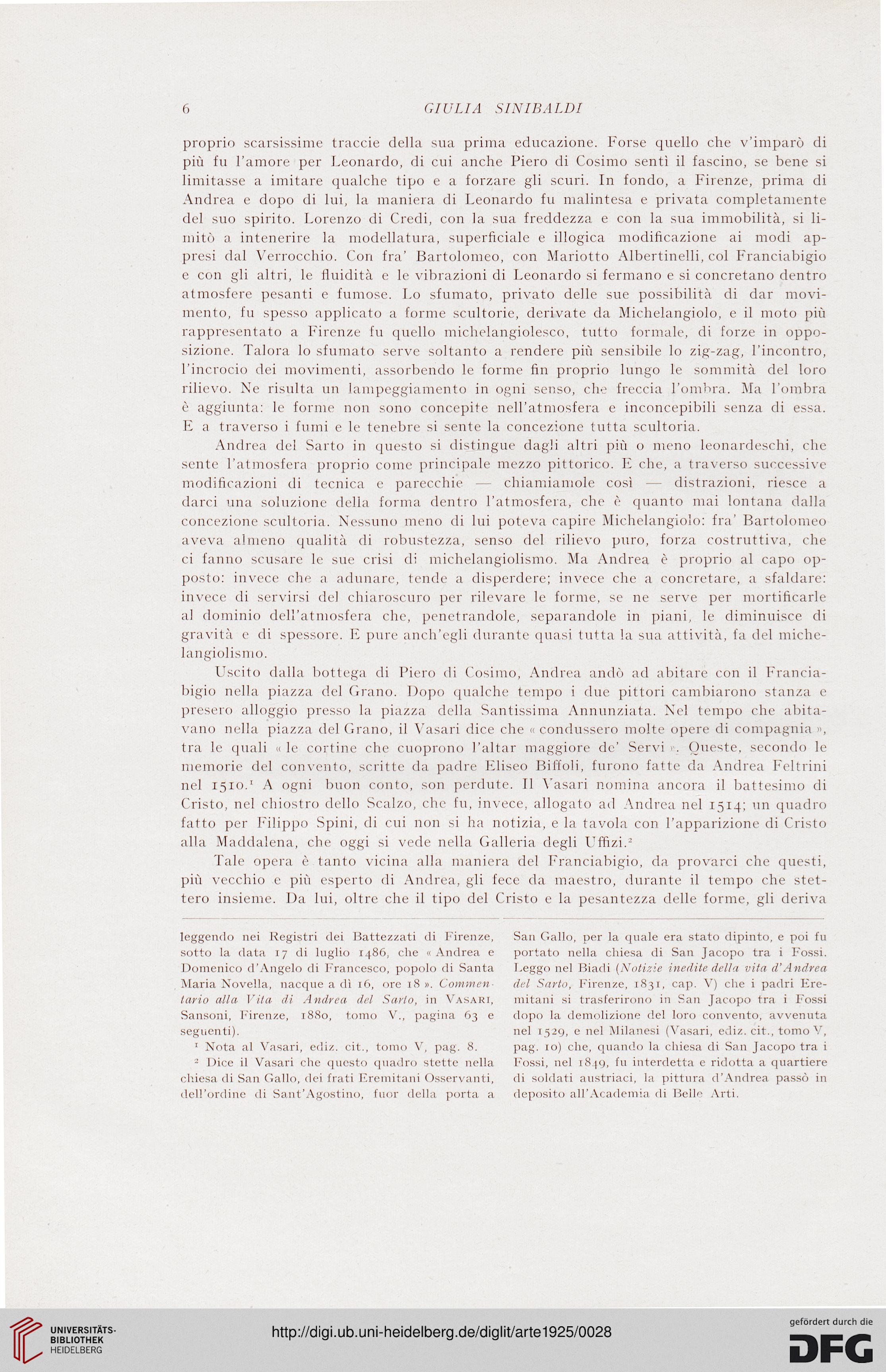6 CI ['LIA SIN IB ALDI
proprio scarsissime traccie della sua prima educazione. Forse quello che v'imparò di
più fu l'amore per Leonardo, di cui anche Piero di Cosimo sentì il fascino, se bene si
limitasse a imitare qualche tipo e a forzare gli scuri. In fondo, a Firenze, prima di
Andrea e dopo di lui, la maniera di Leonardo fu malintesa e privata completamente
del suo spirito. Lorenzo di Credi, con la sua freddezza e con la sua immobilità, si li-
mitò a intenerire la modellatura, superficiale e illogica modificazione ai modi ap-
presi dal Verrocchio. Con fra' Bartolomeo, con Mariotto Albertinelli, col Franciabigio
e con gli altri, le fluidità e le vibrazioni di Leonardo si fermano e si concretano dentro
atmosfere pesanti e fumose. Lo sfumato, privato delle sue possibilità di dar movi-
mento, fu spesso applicato a forme scultorie, derivate da Michelangiolo, e il moto più
rappresentato a Firenze fu quello michelangiolesco, tutto formale, di forze in oppo-
sizione. Talora lo sfumato serve soltanto a rendere piti sensibile lo zig-zag, l'incontro,
l'incrocio dei movimenti, assorbendo le forme fin proprio lungo le sommità del loro
rilievo. Ne risulta un lampeggiamento in ogni senso, eh'- freccia l'ombra. Ma l'ombra
è aggiunta: le forme non sono concepite nell'atmosfera e inconcepibili senza di essa.
F a traverso i fumi e le tenebre si sente la concezione tutta scultoria.
Andrea del Sarto in questo si distingue dagli altri più o meno leonardeschi, che
sente l'atmosfera proprio come principale mezzo pittorico. lì che, a traverso successive
modificazioni di tecnica e parecchie chiamiamole così distrazioni, riesce a
darci una soluzione della forma dentro l'atmosfera, che è (pianto mai lontana dalla
concezione scultoria. Nessuno meno di lui poteva capire Michelangiolo: fra' Bartolomeo
aveva almeno qualità di robustezza, senso del rilievo puro, forza costruttiva, che
ci fanno scusare le sue crisi di michelangiolismo. Ma Andrea è proprio al capo op-
posto: invece che a adunare, tende a disperdere; invece che a concretare, a sfaldare:
invece di servirsi del chiaroscuro per rilevare le forme, se ne serve per mortificarle
al dominio dell'atmosfera che, penetrandole, separandole in piani, le diminuisce di
gravità e di spessore. F pure anch'egli durante quasi tutta la sua attività, fa del miche-
langiolismo.
Uscito dalla bottega di Piero di Cosimo, Andrea andò ad abitare con il Francia-
bigio nella piazza del Ciano. Dopo qualche tempo i due pittori cambiarono stanza e
presero alloggio presso la piazza della Santissima Annunziata. Nel tempo che abita-
vano nella piazza del Grano, il Vasari dice che « condussero molte opere di compagnia »,
tra le (piali « le cortine che cuoprono l'aitar maggiore de' Servi > . Cjm,stc' secondo le
memorie del convento, scritte da padre Eliseo Biffoli, furono fatte da Andrea Feltrini
nel 1510.1 A ogni buon conto, son perdute. Il Vasari nomina ancora il battesimo di
Cristo, nel chiostro dello Scalzo, che fu, invece, allogato ad Andrea nel 1514; un quadro
fatto per Filippo Spini, di cui non si ha notizia, e la tavola con l'apparizione di Cristo
alla Maddalena, che oggi si vede nella Galleria degli Uffizi.3
Tale opera è tanto vicina alla maniera del Franciabigio, da provarci che questi,
più vecchio e più esperto di Andrea, gli fece da maestro, durante il tempo che stet-
tero insieme. Da lui, oltre che il tipo del Cristo e la pesantezza delle forme, gli deriva
leggendo nei Registri dei Battezzati di Firenze,
sotto la data 17 di luglio i486, che «Andrea e
Domenico d'Angelo di Francesco, popolo di Santa
Maria Novella, nacque a dì 16, ore 18 ». Commen-
tario alla Vita di Andrea del Sarto, in Vasari,
Sansoni, Firenze, 1880, tomo V., pagina 63 e
seguenti).
1 Nota al Vasari, ediz. cit., tomo V, pag. 8.
J Dice il Vasari che questo quadro stette nella
chiesa di San Gallo, dei frati Eremitani Osservanti,
dell'ordine di Sant'Agostino, fuor della porta a
San Gallo, per la quale era stato dipinto, e poi fu
portato nella chiesa di San Jacopo tra i Fossi.
Leggo nel Biadi (Notizie inedite della vita d'Andrea
del Sarto, Firenze, 1831, cap. V) che i padri Ere-
mitani si trasferirono in San Jacopo tra i Fossi
dopo la demolizione del loro convento, avvenuta
nel 1529, e nel Milanesi (Vasari, ediz. cit., tomo V,
pag. 10) che, quando la chiesa di San Jacopo tra i
Fossi, nel 1849, fu interdetta e ridotta a quartiere
di soldati austriaci, la pittura d'Andrea passò in
deposito all'Academia di Belle Arti.
proprio scarsissime traccie della sua prima educazione. Forse quello che v'imparò di
più fu l'amore per Leonardo, di cui anche Piero di Cosimo sentì il fascino, se bene si
limitasse a imitare qualche tipo e a forzare gli scuri. In fondo, a Firenze, prima di
Andrea e dopo di lui, la maniera di Leonardo fu malintesa e privata completamente
del suo spirito. Lorenzo di Credi, con la sua freddezza e con la sua immobilità, si li-
mitò a intenerire la modellatura, superficiale e illogica modificazione ai modi ap-
presi dal Verrocchio. Con fra' Bartolomeo, con Mariotto Albertinelli, col Franciabigio
e con gli altri, le fluidità e le vibrazioni di Leonardo si fermano e si concretano dentro
atmosfere pesanti e fumose. Lo sfumato, privato delle sue possibilità di dar movi-
mento, fu spesso applicato a forme scultorie, derivate da Michelangiolo, e il moto più
rappresentato a Firenze fu quello michelangiolesco, tutto formale, di forze in oppo-
sizione. Talora lo sfumato serve soltanto a rendere piti sensibile lo zig-zag, l'incontro,
l'incrocio dei movimenti, assorbendo le forme fin proprio lungo le sommità del loro
rilievo. Ne risulta un lampeggiamento in ogni senso, eh'- freccia l'ombra. Ma l'ombra
è aggiunta: le forme non sono concepite nell'atmosfera e inconcepibili senza di essa.
F a traverso i fumi e le tenebre si sente la concezione tutta scultoria.
Andrea del Sarto in questo si distingue dagli altri più o meno leonardeschi, che
sente l'atmosfera proprio come principale mezzo pittorico. lì che, a traverso successive
modificazioni di tecnica e parecchie chiamiamole così distrazioni, riesce a
darci una soluzione della forma dentro l'atmosfera, che è (pianto mai lontana dalla
concezione scultoria. Nessuno meno di lui poteva capire Michelangiolo: fra' Bartolomeo
aveva almeno qualità di robustezza, senso del rilievo puro, forza costruttiva, che
ci fanno scusare le sue crisi di michelangiolismo. Ma Andrea è proprio al capo op-
posto: invece che a adunare, tende a disperdere; invece che a concretare, a sfaldare:
invece di servirsi del chiaroscuro per rilevare le forme, se ne serve per mortificarle
al dominio dell'atmosfera che, penetrandole, separandole in piani, le diminuisce di
gravità e di spessore. F pure anch'egli durante quasi tutta la sua attività, fa del miche-
langiolismo.
Uscito dalla bottega di Piero di Cosimo, Andrea andò ad abitare con il Francia-
bigio nella piazza del Ciano. Dopo qualche tempo i due pittori cambiarono stanza e
presero alloggio presso la piazza della Santissima Annunziata. Nel tempo che abita-
vano nella piazza del Grano, il Vasari dice che « condussero molte opere di compagnia »,
tra le (piali « le cortine che cuoprono l'aitar maggiore de' Servi > . Cjm,stc' secondo le
memorie del convento, scritte da padre Eliseo Biffoli, furono fatte da Andrea Feltrini
nel 1510.1 A ogni buon conto, son perdute. Il Vasari nomina ancora il battesimo di
Cristo, nel chiostro dello Scalzo, che fu, invece, allogato ad Andrea nel 1514; un quadro
fatto per Filippo Spini, di cui non si ha notizia, e la tavola con l'apparizione di Cristo
alla Maddalena, che oggi si vede nella Galleria degli Uffizi.3
Tale opera è tanto vicina alla maniera del Franciabigio, da provarci che questi,
più vecchio e più esperto di Andrea, gli fece da maestro, durante il tempo che stet-
tero insieme. Da lui, oltre che il tipo del Cristo e la pesantezza delle forme, gli deriva
leggendo nei Registri dei Battezzati di Firenze,
sotto la data 17 di luglio i486, che «Andrea e
Domenico d'Angelo di Francesco, popolo di Santa
Maria Novella, nacque a dì 16, ore 18 ». Commen-
tario alla Vita di Andrea del Sarto, in Vasari,
Sansoni, Firenze, 1880, tomo V., pagina 63 e
seguenti).
1 Nota al Vasari, ediz. cit., tomo V, pag. 8.
J Dice il Vasari che questo quadro stette nella
chiesa di San Gallo, dei frati Eremitani Osservanti,
dell'ordine di Sant'Agostino, fuor della porta a
San Gallo, per la quale era stato dipinto, e poi fu
portato nella chiesa di San Jacopo tra i Fossi.
Leggo nel Biadi (Notizie inedite della vita d'Andrea
del Sarto, Firenze, 1831, cap. V) che i padri Ere-
mitani si trasferirono in San Jacopo tra i Fossi
dopo la demolizione del loro convento, avvenuta
nel 1529, e nel Milanesi (Vasari, ediz. cit., tomo V,
pag. 10) che, quando la chiesa di San Jacopo tra i
Fossi, nel 1849, fu interdetta e ridotta a quartiere
di soldati austriaci, la pittura d'Andrea passò in
deposito all'Academia di Belle Arti.