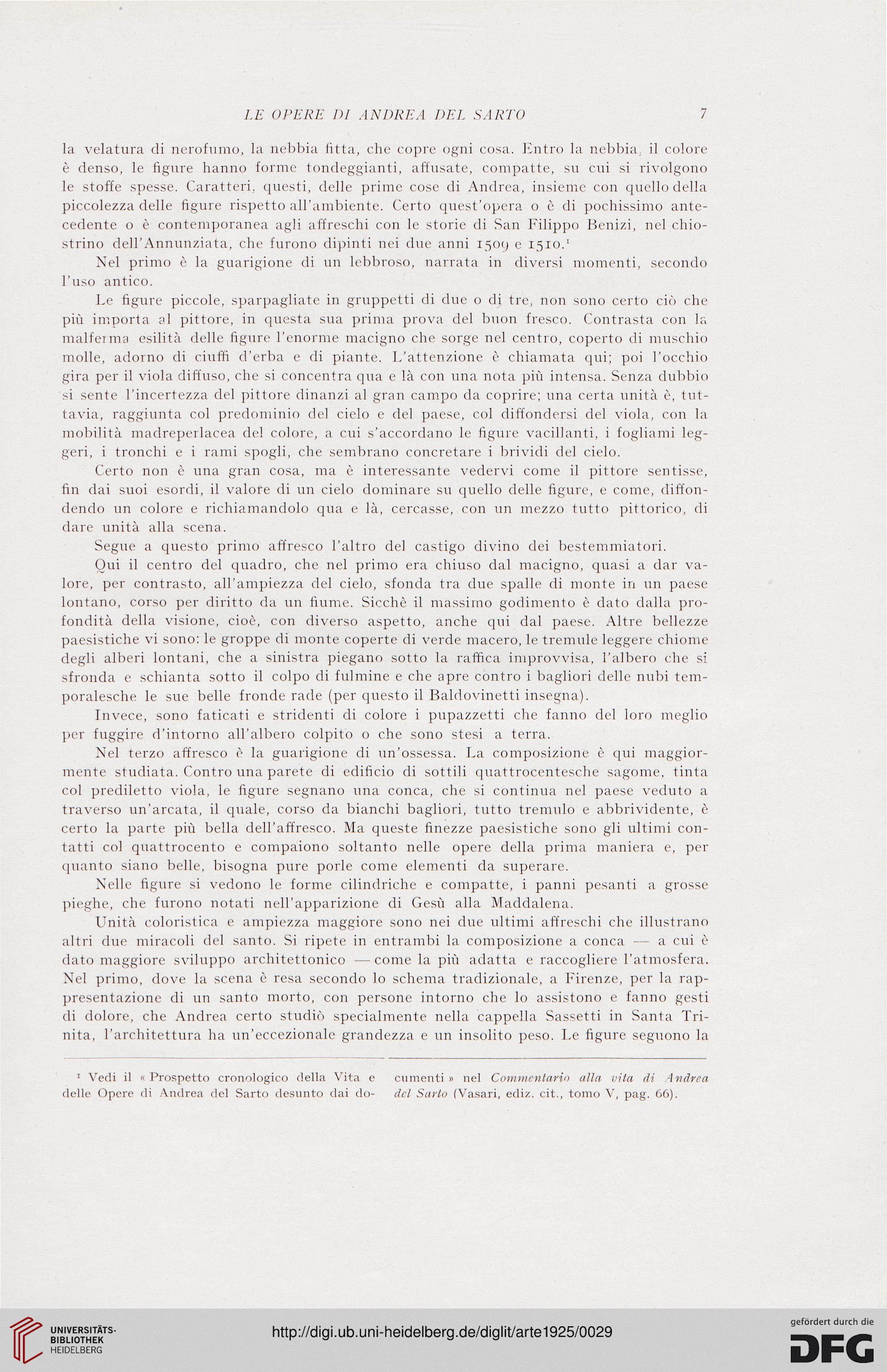LE OPERE DI ANDREA DEI. SARTO
7
la velatura di nerofumo, la nebbia fìtta, clic copre ogni cosa. Entro la nebbia il eolore
è denso, le figure hanno forme tondeggianti, affusate, compatte, su cui si rivolgono
le stoffe spesse. Caratteri, questi, delle prime cose di Andrea, insieme con quello della
piccolezza delle figure rispetto all'ambiente. Certo quest'opera o è di pochissimo ante-
cedente o è contemporanea agli affreschi con le storie di San Filippo Benizi, nel chio-
strino dell'Annunziata, che furono dipinti nei due anni 1509 e 1510.1
Nel primo è la guarigione di un lebbroso, narrata in diversi momenti, secondo
L'uso antico.
Le figure piccole, sparpagliate in gruppetti ciì due o di tre, non sono certo ciò che
più importa al pittore, in questa sua prima prova del buon fresco. Contrasta con la
malferma esilità delle figure l'enorme macigno che sorge nel centro, coperto ili muschio
molle, adorno di ciuffi d'erba e di piante. L'attenzione è chiamata qui; poi l'occhio
gira per il viola diffuso, che si concentra qua e là con una nota più intensa. Senza dubbio
si sente l'incertezza del pittore dinanzi al gran campo da coprire; una certa unità è, tut-
tavia, raggiunta col predominio del cielo e del paese, col diffondersi del viola, con la
mobilità madreperlacea de! colore, a cui s'accordano le figure vacillanti, i fogliami leg-
geri, i tronchi e i rami spogli, che sembrano concretare i brividi del cielo.
Certo non è una gran cosa, ma è interessante vedervi come il pittore sentisse,
fin dai suoi esordi, il valore di un cielo dominare su quello delle figure, e come, diffon-
dendo un colore e richiamandolo qua e là, cercasse, con un mezzo tutto pittorico, di
dare unità alla scena.
Segue a questo primo affresco l'altro del castigo divino dei bestemmiatori.
Qui il centro del quadro, che nel primo era chiuso dal macigno, quasi a dar va-
lore, per contrasto, all'ampiezza del cielo, sfonda tra due spalle di monte in un paese
lontano, corso per diritto da un fiume. Sicché il massimo godimento è dato dalla pro-
fondità della visione, cioè, con diverso aspetto, anche qui dal paese. Altre bellezze
paesistiche vi sono: le groppe di monte coperte di verde macero, le tremule leggere chiome
degli alberi lontani, che a sinistra piegano sotto la raffica improvvisa, l'albero che si
sfronda e schianta sotto il colpo di fulmine e che apre contro i bagliori delle nubi tem-
poralesche le sue belle fronde rade (per questo il Kaldovinetti insegna).
Invece, sono faticati e stridenti di colore i pupazzetti che fanno del loro meglio
per fuggire d'intorno all'albero colpito o che sono stesi a terra.
Nel terzo affresco è la guarigione di un'ossessa. La composizione è qui maggior-
mente studiata. Contro una parete di edificio di sottili quattrocentesche sagome, tinta
col prediletto viola, le figure segnano una conca, che si continua nel paese veduto a
traverso un'arcata, il quale, corso da bianchi bagliori, ttitto tremulo e abbrividente, è
certo la parte più bella dell'affresco. Ma queste finezze paesistiche sono gli ultimi con-
tatti col eptattrocento e compaiono soltanto nelle opere della prima maniera e, per
(pianto siano belle, bisogna pure porle come elementi da superare.
Nelle figure si vedono le forme cilindriche e compatte, i panni pesanti a grosse
pieghe, che furono notati nell'apparizione di Gesù alla Maddalena.
Lenità coloristica e ampiezza maggiore sono nei due ultimi affreschi che illustrano
altri due miracoli del santo. Si ripete in entrambi la composizione a conca - a cui è
dato maggiore sviluppo architettonico —come la più adatta e raccogliere l'atmosfera.
Nel primo, dove la scena è resa secondo lo schema tradizionale, a Firenze, per la rap-
presentazione di un santo morto, con persone intorno che lo assistono e fanno gesti
di dolore, che Andrea certo studiò specialmente nella cappella Sassetti in Santa Tri-
nità, l'architettura ha un'eccezionale grandezza e un insolito peso. Le figure seguono la
1 Vedi il «Prospetto cronologico della Vita e cumenti » nel Commentario alla vita di Andrea
delle Opere di Andrea del Sarto desunto dai do- del Sarto (Vasari, ediz. cit., tomo V, pag. 66).
7
la velatura di nerofumo, la nebbia fìtta, clic copre ogni cosa. Entro la nebbia il eolore
è denso, le figure hanno forme tondeggianti, affusate, compatte, su cui si rivolgono
le stoffe spesse. Caratteri, questi, delle prime cose di Andrea, insieme con quello della
piccolezza delle figure rispetto all'ambiente. Certo quest'opera o è di pochissimo ante-
cedente o è contemporanea agli affreschi con le storie di San Filippo Benizi, nel chio-
strino dell'Annunziata, che furono dipinti nei due anni 1509 e 1510.1
Nel primo è la guarigione di un lebbroso, narrata in diversi momenti, secondo
L'uso antico.
Le figure piccole, sparpagliate in gruppetti ciì due o di tre, non sono certo ciò che
più importa al pittore, in questa sua prima prova del buon fresco. Contrasta con la
malferma esilità delle figure l'enorme macigno che sorge nel centro, coperto ili muschio
molle, adorno di ciuffi d'erba e di piante. L'attenzione è chiamata qui; poi l'occhio
gira per il viola diffuso, che si concentra qua e là con una nota più intensa. Senza dubbio
si sente l'incertezza del pittore dinanzi al gran campo da coprire; una certa unità è, tut-
tavia, raggiunta col predominio del cielo e del paese, col diffondersi del viola, con la
mobilità madreperlacea de! colore, a cui s'accordano le figure vacillanti, i fogliami leg-
geri, i tronchi e i rami spogli, che sembrano concretare i brividi del cielo.
Certo non è una gran cosa, ma è interessante vedervi come il pittore sentisse,
fin dai suoi esordi, il valore di un cielo dominare su quello delle figure, e come, diffon-
dendo un colore e richiamandolo qua e là, cercasse, con un mezzo tutto pittorico, di
dare unità alla scena.
Segue a questo primo affresco l'altro del castigo divino dei bestemmiatori.
Qui il centro del quadro, che nel primo era chiuso dal macigno, quasi a dar va-
lore, per contrasto, all'ampiezza del cielo, sfonda tra due spalle di monte in un paese
lontano, corso per diritto da un fiume. Sicché il massimo godimento è dato dalla pro-
fondità della visione, cioè, con diverso aspetto, anche qui dal paese. Altre bellezze
paesistiche vi sono: le groppe di monte coperte di verde macero, le tremule leggere chiome
degli alberi lontani, che a sinistra piegano sotto la raffica improvvisa, l'albero che si
sfronda e schianta sotto il colpo di fulmine e che apre contro i bagliori delle nubi tem-
poralesche le sue belle fronde rade (per questo il Kaldovinetti insegna).
Invece, sono faticati e stridenti di colore i pupazzetti che fanno del loro meglio
per fuggire d'intorno all'albero colpito o che sono stesi a terra.
Nel terzo affresco è la guarigione di un'ossessa. La composizione è qui maggior-
mente studiata. Contro una parete di edificio di sottili quattrocentesche sagome, tinta
col prediletto viola, le figure segnano una conca, che si continua nel paese veduto a
traverso un'arcata, il quale, corso da bianchi bagliori, ttitto tremulo e abbrividente, è
certo la parte più bella dell'affresco. Ma queste finezze paesistiche sono gli ultimi con-
tatti col eptattrocento e compaiono soltanto nelle opere della prima maniera e, per
(pianto siano belle, bisogna pure porle come elementi da superare.
Nelle figure si vedono le forme cilindriche e compatte, i panni pesanti a grosse
pieghe, che furono notati nell'apparizione di Gesù alla Maddalena.
Lenità coloristica e ampiezza maggiore sono nei due ultimi affreschi che illustrano
altri due miracoli del santo. Si ripete in entrambi la composizione a conca - a cui è
dato maggiore sviluppo architettonico —come la più adatta e raccogliere l'atmosfera.
Nel primo, dove la scena è resa secondo lo schema tradizionale, a Firenze, per la rap-
presentazione di un santo morto, con persone intorno che lo assistono e fanno gesti
di dolore, che Andrea certo studiò specialmente nella cappella Sassetti in Santa Tri-
nità, l'architettura ha un'eccezionale grandezza e un insolito peso. Le figure seguono la
1 Vedi il «Prospetto cronologico della Vita e cumenti » nel Commentario alla vita di Andrea
delle Opere di Andrea del Sarto desunto dai do- del Sarto (Vasari, ediz. cit., tomo V, pag. 66).