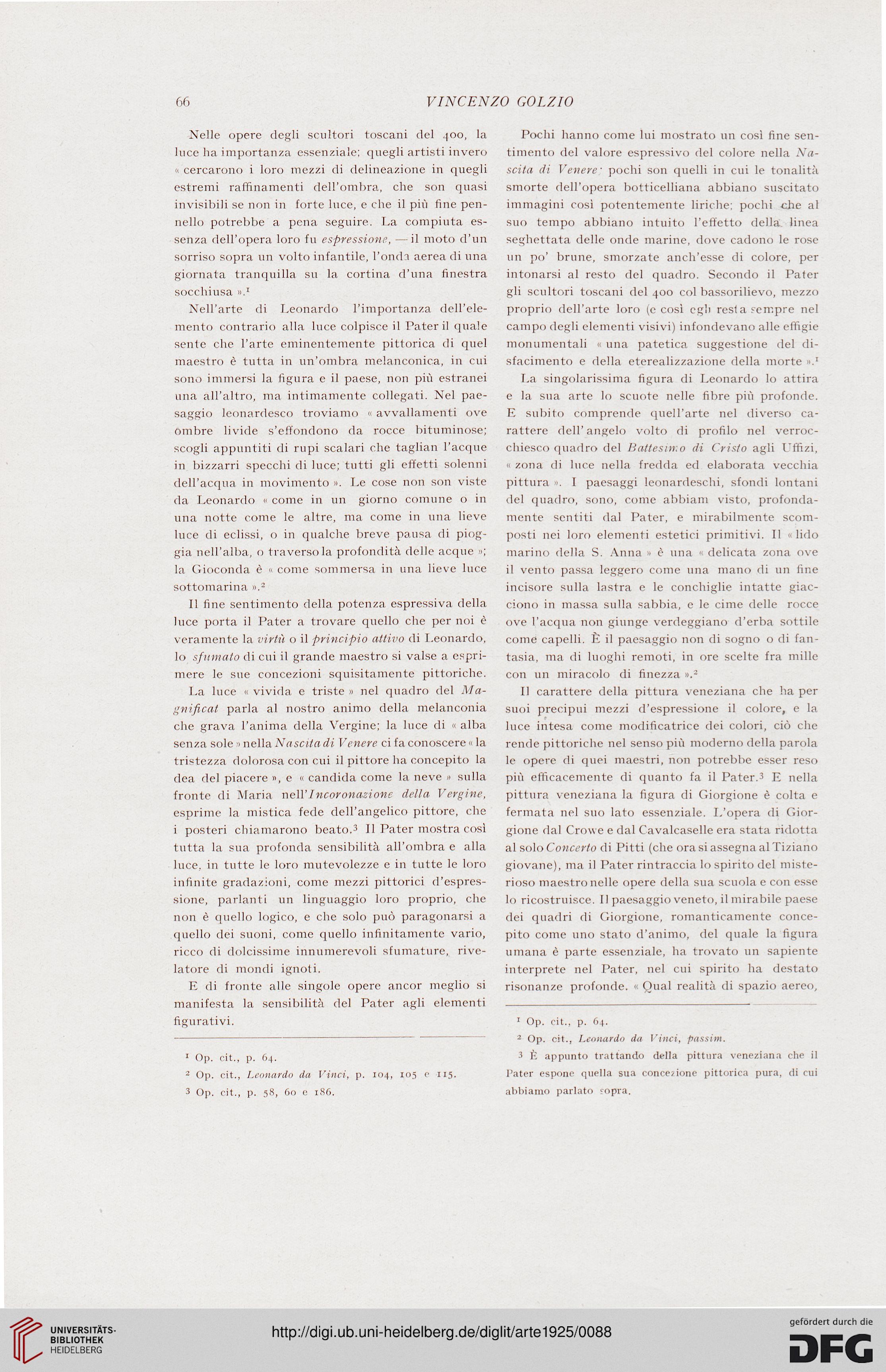66
VINCENZO GOLZIO
Nelle opere degli scultori toscani del 400, la
luce ha importanza essenziale; quegli artisti invero
« cercarono i loro mezzi di delineazione in quegli
estremi raffinamenti dell'ombra, che son quasi
invisibili se non in forte luce, e che il più fine pen-
nello potrebbe a pena seguire. La compiuta es-
senza dell'opera loro fu espressione, —il moto d'un
sorriso sopra un volto infantile, l'ondi aerea di una
giornata tranquilla su la cortina d'una finestra
socchiusa
Nell'arte di Leonardo l'importanza dell'ele-
mento contrario alla luce colpisce il Pater il quale
sente che l'arte eminentemente pittorica di quel
maestro è tutta in un'ombra melanconica, in cui
sono immersi la figura e il paese, non più estranei
una all'altro, ma intimamente collegati. Nel pae-
saggio leonardesco troviamo « avvallamenti ove
ombre livide s'effondono da rocce bituminose;
scogli appuntiti di rupi scalari che tagliali l'acque
in bizzarri specchi di luce; tutti gli effetti solenni
dell'acqua in movimento ». Le cose non son viste
da Leonardo « come in un giorno comune ó in
una notte come le altre, ma come in una lieve
luce di eclissi, 0 in qualche breve pausa di piog-
gia nell'alba, o traversola profondità delle acque »;
la Gioconda è « come sommersa in una lieve luce
sottomarina ».2
Il fine sentimento della potenza espressiva della
luce porta il Pater a trovare quello che per noi è
veramente la virtù o il principio attivo di Leonardo,
lo sfumato di cui il grande maestro si valse a espri-
mere le sue concezioni squisitamente pittoriche.
La luce « vivida e triste » nel quadro del Ma-
gnificat parla al nostro animo della melanconia
che grava l'anima della Vergine; la luce di « alba
senza sole » nella Nascita di Venere ci fa conoscere» la
tristezza dolorosa con cui il pittore ha concepito la
dea del piacere », e « candida come la neve » sulla
fronte di Maria nell'Incoronazione della Vergine,
esprime la mistica fede dell'angelico pittore, che
i posteri chiamarono beato.3 Il Pater mostra così
tutta la sua profonda sensibilità all'ombra e alla
luce, in tutte le loro mutevolezze e in tutte le loro
infinite gradazioni, come mezzi pittorici d'espres-
sione, parlanti un linguaggio loro proprio, che
non è quello logico, e che solo può paragonarsi a
quello dei suoni, come quello infinitamente vario,
ricco di dolcissime innumerevoli sfumature, rive-
latore di mondi ignoti.
E di fronte alle singole opere ancor meglio si
manifesta la sensibilità del Pater agli elementi
figurativi.
1 Op. cit., p. 64.
2 Op. cit., Leonardo da Vinci, p. 104, 105 e 115.
3 Op. cit., p. 58, 60 c iSfi.
Pochi hanno come lui mostrato un cosi fine sen-
timento del valore espressivo del colore nella Na-
scita di Venere pochi son quelli in cui le tonalità
smorte dell'opera botticelliana abbiano suscitato
immagini così potentemente liriche; pochi che al
suo tempo abbiano intuito l'effetto della linea
seghettata delle onde marine, dove cadono le rose
un po' brune, smorzate anch'esse di colore, per
intonarsi al resto del quadro. Secondo il Pater
gli scultori toscani del 400 col bassorilievo, mezzo
proprio dell'arte loro (c cosi egli resta sempre nel
campo degli elementi visivi) infondevano alle effigie
monumentali « una patetica suggestione del di-
sfacimento e della eterealizzazione della morte ».1
La singolarissima figura di Leonardo lo attira
e la sua arte lo scuote nelle fibre più profonde.
E subito comprende quell'arte nel diverso ca-
rattere dell'angelo volto di profilo nel verroc-
chiesco quadro del Battesm.o di Cristo agli Uffizi,
« zona di luce nella fredda ed elaborata vecchia
pittura 9. I paesaggi leonardeschi, sfondi lontani
del quadro, sono, come abbiam visto, profonda-
mente sentiti dal Pater, e mirabilmente scom-
posti nei loro elementi estetici primitivi. Il « lido
marino della S. Anna » e una 1 delicata zona ove
il vento passa leggero come una mano di un fine
incisore sulla lastra e le conchiglie intatte giac-
ciono in massa sulla sabbia, e le cime delle rocce
ove l'acqua non giunge verdeggiano d'erba sottile
come capelli. È il paesaggio non di sogno o di fan-
tasia, ma di luoghi remoti, in ore scelte fra mille
con un miracolo di finezza ».2
Il carattere della pittura veneziana che ha per
suoi precipui mezzi d'espressione il colore, e la
luce intesa come modificatrice dei colori, ciò che
rende pittoriche nel senso più moderno della parola
le opere di quei maestri, non potrebbe esser reso
più efficacemente di quanto fa il Pater.3 E nella
pittura veneziana la figura di Giorgione è colta e
fermata nel suo lato essenziale. L'opera di Gior-
gione dal Crowe e dal Cavalcasene era stata ridotta
al solo Concerto di Pitti (che ora si assegna al Tiziano
giovane), ma il Pater rintraccia lo spirito del miste-
rioso maestro nelle opere della sua scuola e con esse
lo ricostruisce. Il paesaggio veneto, il mirabile paese
dei quadri di Giorgione, romanticamente conce-
pito come uno stato d'animo, del quale la figura
umana è parte essenziale, ha trovato un sapiente
interprete nel Pater, nel cui spirito ha destato
risonanze profonde. « Qual realità di spazio aereo,
1 Op. cit., p. 64.
2 Op. cit., Leonardo da l'ilici, passim.
i P. appunto trattando della pittura veneziana che il
Pater espone quella sua concezione pittorica pura, di cui
abbiamo parlato ?opra.
VINCENZO GOLZIO
Nelle opere degli scultori toscani del 400, la
luce ha importanza essenziale; quegli artisti invero
« cercarono i loro mezzi di delineazione in quegli
estremi raffinamenti dell'ombra, che son quasi
invisibili se non in forte luce, e che il più fine pen-
nello potrebbe a pena seguire. La compiuta es-
senza dell'opera loro fu espressione, —il moto d'un
sorriso sopra un volto infantile, l'ondi aerea di una
giornata tranquilla su la cortina d'una finestra
socchiusa
Nell'arte di Leonardo l'importanza dell'ele-
mento contrario alla luce colpisce il Pater il quale
sente che l'arte eminentemente pittorica di quel
maestro è tutta in un'ombra melanconica, in cui
sono immersi la figura e il paese, non più estranei
una all'altro, ma intimamente collegati. Nel pae-
saggio leonardesco troviamo « avvallamenti ove
ombre livide s'effondono da rocce bituminose;
scogli appuntiti di rupi scalari che tagliali l'acque
in bizzarri specchi di luce; tutti gli effetti solenni
dell'acqua in movimento ». Le cose non son viste
da Leonardo « come in un giorno comune ó in
una notte come le altre, ma come in una lieve
luce di eclissi, 0 in qualche breve pausa di piog-
gia nell'alba, o traversola profondità delle acque »;
la Gioconda è « come sommersa in una lieve luce
sottomarina ».2
Il fine sentimento della potenza espressiva della
luce porta il Pater a trovare quello che per noi è
veramente la virtù o il principio attivo di Leonardo,
lo sfumato di cui il grande maestro si valse a espri-
mere le sue concezioni squisitamente pittoriche.
La luce « vivida e triste » nel quadro del Ma-
gnificat parla al nostro animo della melanconia
che grava l'anima della Vergine; la luce di « alba
senza sole » nella Nascita di Venere ci fa conoscere» la
tristezza dolorosa con cui il pittore ha concepito la
dea del piacere », e « candida come la neve » sulla
fronte di Maria nell'Incoronazione della Vergine,
esprime la mistica fede dell'angelico pittore, che
i posteri chiamarono beato.3 Il Pater mostra così
tutta la sua profonda sensibilità all'ombra e alla
luce, in tutte le loro mutevolezze e in tutte le loro
infinite gradazioni, come mezzi pittorici d'espres-
sione, parlanti un linguaggio loro proprio, che
non è quello logico, e che solo può paragonarsi a
quello dei suoni, come quello infinitamente vario,
ricco di dolcissime innumerevoli sfumature, rive-
latore di mondi ignoti.
E di fronte alle singole opere ancor meglio si
manifesta la sensibilità del Pater agli elementi
figurativi.
1 Op. cit., p. 64.
2 Op. cit., Leonardo da Vinci, p. 104, 105 e 115.
3 Op. cit., p. 58, 60 c iSfi.
Pochi hanno come lui mostrato un cosi fine sen-
timento del valore espressivo del colore nella Na-
scita di Venere pochi son quelli in cui le tonalità
smorte dell'opera botticelliana abbiano suscitato
immagini così potentemente liriche; pochi che al
suo tempo abbiano intuito l'effetto della linea
seghettata delle onde marine, dove cadono le rose
un po' brune, smorzate anch'esse di colore, per
intonarsi al resto del quadro. Secondo il Pater
gli scultori toscani del 400 col bassorilievo, mezzo
proprio dell'arte loro (c cosi egli resta sempre nel
campo degli elementi visivi) infondevano alle effigie
monumentali « una patetica suggestione del di-
sfacimento e della eterealizzazione della morte ».1
La singolarissima figura di Leonardo lo attira
e la sua arte lo scuote nelle fibre più profonde.
E subito comprende quell'arte nel diverso ca-
rattere dell'angelo volto di profilo nel verroc-
chiesco quadro del Battesm.o di Cristo agli Uffizi,
« zona di luce nella fredda ed elaborata vecchia
pittura 9. I paesaggi leonardeschi, sfondi lontani
del quadro, sono, come abbiam visto, profonda-
mente sentiti dal Pater, e mirabilmente scom-
posti nei loro elementi estetici primitivi. Il « lido
marino della S. Anna » e una 1 delicata zona ove
il vento passa leggero come una mano di un fine
incisore sulla lastra e le conchiglie intatte giac-
ciono in massa sulla sabbia, e le cime delle rocce
ove l'acqua non giunge verdeggiano d'erba sottile
come capelli. È il paesaggio non di sogno o di fan-
tasia, ma di luoghi remoti, in ore scelte fra mille
con un miracolo di finezza ».2
Il carattere della pittura veneziana che ha per
suoi precipui mezzi d'espressione il colore, e la
luce intesa come modificatrice dei colori, ciò che
rende pittoriche nel senso più moderno della parola
le opere di quei maestri, non potrebbe esser reso
più efficacemente di quanto fa il Pater.3 E nella
pittura veneziana la figura di Giorgione è colta e
fermata nel suo lato essenziale. L'opera di Gior-
gione dal Crowe e dal Cavalcasene era stata ridotta
al solo Concerto di Pitti (che ora si assegna al Tiziano
giovane), ma il Pater rintraccia lo spirito del miste-
rioso maestro nelle opere della sua scuola e con esse
lo ricostruisce. Il paesaggio veneto, il mirabile paese
dei quadri di Giorgione, romanticamente conce-
pito come uno stato d'animo, del quale la figura
umana è parte essenziale, ha trovato un sapiente
interprete nel Pater, nel cui spirito ha destato
risonanze profonde. « Qual realità di spazio aereo,
1 Op. cit., p. 64.
2 Op. cit., Leonardo da l'ilici, passim.
i P. appunto trattando della pittura veneziana che il
Pater espone quella sua concezione pittorica pura, di cui
abbiamo parlato ?opra.