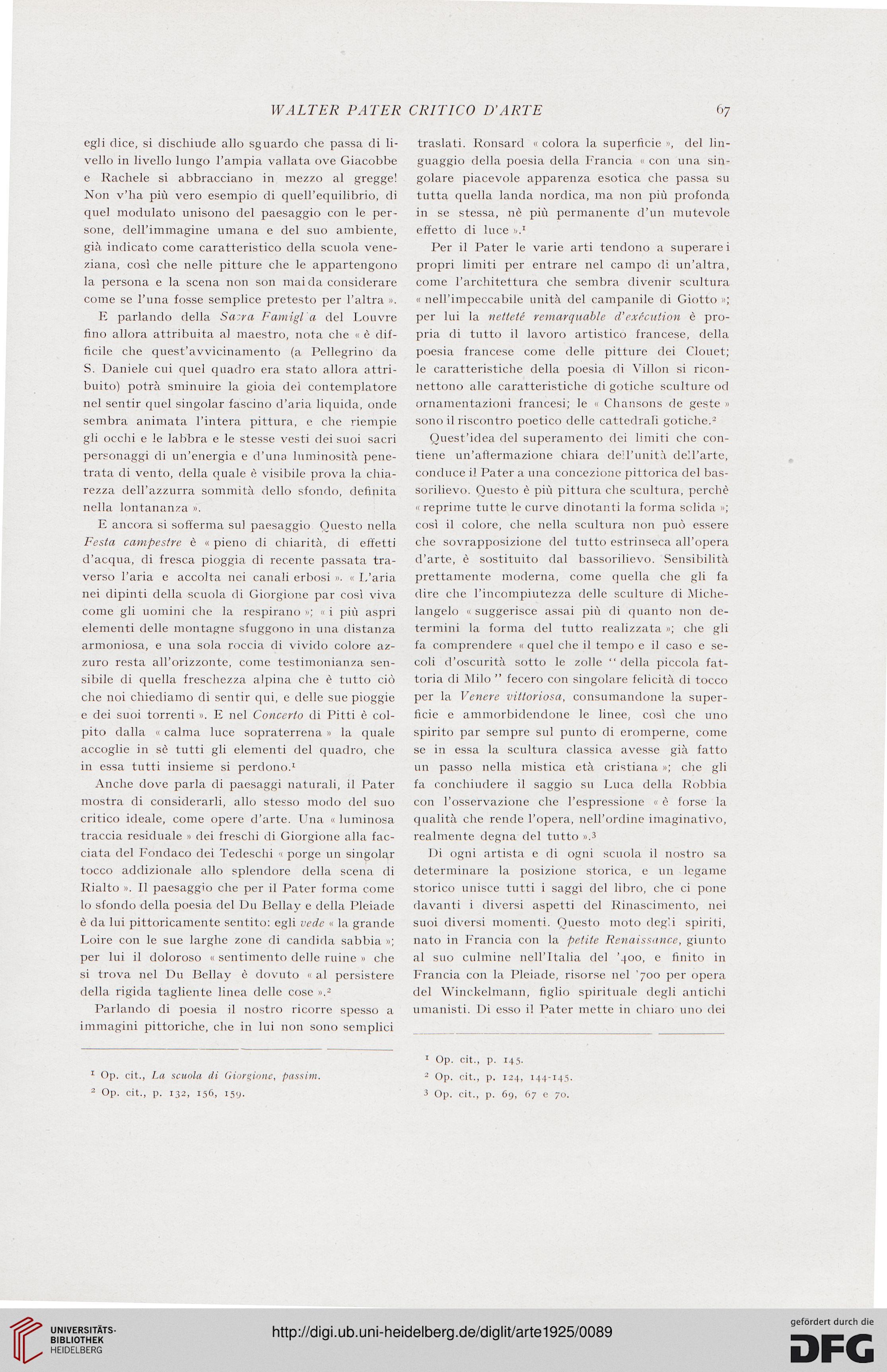WALTER PATER CRITICO D'ARTE
67
egli dice, si dischiude allo sguardo che passa di li-
vello in livello lungo l'ampia vallata ove Giacobbe
e Rachele si abbracciano in mezzo al greggel
Non v'ha più vero esempio di quell'equilibrio, di
quel modulato unisono del paesaggio con le per-
sone, dell'immagine umana e del suo ambiente,
già indicato come caratteristico della scuola vene-
ziana, cosi che nelle pitture che le appartengono
la persona e la scena non son mai da considerare
come se l'una fosse semplice pretesto per l'altra ».
E parlando della Sa;ra Fam igl a del Louvre
fino allora attribuita al maestro, nota che « è dif-
ficile che quest'avvicinamento (a Pellegrino da
S. Daniele cui quel quadro era slato allora attri-
buito) potrà sminuire la gioia dei contemplatore
nel sentir quel singoiar fascino d'aria liquida, onde
sembra animata l'intera pittura, e che riempie
gli occhi e le labbra e le stesse vesti dei suoi sacri
personaggi di un'energia e d'una luminosità pene-
trata di vento, della quale è visibile prova la chia-
rezza dell'azzurra sommità dello sfondo, definita
nella lontananza ».
E ancora si sofferma sul paesaggio Questo nella
Festa campestre è « pieno di chiarità, di effetti
d'acqua, di fresca pioggia di recente passata tra-
verso l'aria e accolta nei canali erbosi ». « L'aria
nei dipinti della scuola di Giorgione par così viva
come gli uomini che la respirano »; « i più aspri
elementi delle montagne sfuggono in una distanza
armoniosa, e una sola roccia di vivido colore az-
zuro resta all'orizzonte, come testimonianza sen-
sibile di ciucila freschezza alpina che è tutto ciò
clie noi chiediamo di sentir qui, e delle sue pioggie
e dei suoi torrenti ». E nel Concerto di Pitti è col-
pito dalla « calma luce sopraterrena » la quale
accoglie in sè tutti gli elementi del quadro, che
in essa tutti insieme si perdono.1
Anche dove parla di paesaggi naturali, il Pater
mostra di considerarli, allo stesso modo del suo
critico ideale, come opere d'arte. Una « luminosa
traccia residuale » dei freschi di Giorgione alla fac-
ciata del Fondaco dei Tedeschi ■< porge un singoiar
tocco addizionale allo splendore della scena di
Rialto ». Il paesaggio che per il Pater forma come
lo sfondo della poesia del Du Bellay e della Pleiade
è da lui pittoricamente sentito: egli vede « la grande
Loire con le sue larghe zone di candida sabbia »;
per lui il doloroso « sentimento delle mine » che
si trova nel Du Bellay è dovuto « al persistere
della rigida tagliente linea delle cose ».2
Parlando di poesia il nostro ricorre spesso a
immagini pittoriche, che in lui non sono semplici
traslati. Ronsard « colora la superficie », del lin-
guaggio della poesia della Francia « con una sin-
golare piacevole apparenza esotica che passa su
tutta quella landa nordica, ma non più profonda
in se stessa, nè più permanente d'un mutevole
effetto di luce
Per il Pater le varie arti tendono a superare i
propri limiti per entrare nel campo di un'altra,
come l'architettura che sembra divenir scultura
« nell'impeccabile unità del campanile di Giotto »;
per lui la netteté remarquable d'exrctition è pro-
pria di tutto il lavoro artistico francese, della
poesia francese come delle pitture dei Clouet;
le caratteristiche della poesia di Villon si ricon-
nettono alle caratteristiche di gotiche sculture od
ornamentazioni francesi; le « Chansons de geste »
sono il riscontro poetico delle cattedrali gotiche.2
Quest'idea del superamento dei limiti che con-
tiene un'affermazione chiara dell'unità dell'arte,
conduce il Pater a una concezione pittorica del bas-
sorilievo. Questo è più pittura che scultura, perchè
«reprime tutte le curve dinotanti la forma solida »;
così il colore, che nella scultura non può essere
che sovrapposizione del tutto estrinseca all'opera
d'arte, è sostituito dal bassorilievo. Sensibilità
prettamente moderna, come quella che gli fa
dire che l'incompiutezza delle sculture di Miche-
langelo « suggerisce assai più di quanto non de-
termini la forma del tutto realizzata »; che gli
fa comprendere « quel che il tempo e il caso e se-
coli d'oscurità sotto le zolle " della piccola fat-
toria di Milo " fecero con singolare felicità di tocco
per la Venere vittoriosa, consumandone la super-
ficie e ammorbidendone le linee, cosi che uno
spirito par sempre sul punto di eromperne, come
se in essa la scultura classica avesse già fatto
un passo nella mistica età cristiana »; che gli
fa conchiudere il saggio su Luca della Robbia
con l'osservazione che l'espressione « è forse la
qualità che rende l'opera, nell'ordine imaginativo,
realmente degna del tutto ».3
Di ogni artista e di ogni scuola il nostro sa
determinare la posizione storica, e un legame
storico unisce tutti i saggi del libro, che ci pone
davanti i diversi aspetti del Rinascimento, nei
suoi diversi momenti. Questo moto (lega spiriti,
nato in Francia con la petite Renaissance, giunto
al suo culmine nell'Italia del '400, e finito in
Francia con la Pleiade, risorse nel '700 per opera
del Winckelmann, figlio spirituale degli antichi
umanisti. Di esso il Pater mette in chiaro uno dei
1 Op. cit., La scuola di Giorgiongt passivi.
2 Op. cit., p. 132, 156, 15<j.
1 Op. cit., p. 145.
J Op. cit., p. 12-U I44-I45.
3 Op. cit., p. 69, 67 e 711.
67
egli dice, si dischiude allo sguardo che passa di li-
vello in livello lungo l'ampia vallata ove Giacobbe
e Rachele si abbracciano in mezzo al greggel
Non v'ha più vero esempio di quell'equilibrio, di
quel modulato unisono del paesaggio con le per-
sone, dell'immagine umana e del suo ambiente,
già indicato come caratteristico della scuola vene-
ziana, cosi che nelle pitture che le appartengono
la persona e la scena non son mai da considerare
come se l'una fosse semplice pretesto per l'altra ».
E parlando della Sa;ra Fam igl a del Louvre
fino allora attribuita al maestro, nota che « è dif-
ficile che quest'avvicinamento (a Pellegrino da
S. Daniele cui quel quadro era slato allora attri-
buito) potrà sminuire la gioia dei contemplatore
nel sentir quel singoiar fascino d'aria liquida, onde
sembra animata l'intera pittura, e che riempie
gli occhi e le labbra e le stesse vesti dei suoi sacri
personaggi di un'energia e d'una luminosità pene-
trata di vento, della quale è visibile prova la chia-
rezza dell'azzurra sommità dello sfondo, definita
nella lontananza ».
E ancora si sofferma sul paesaggio Questo nella
Festa campestre è « pieno di chiarità, di effetti
d'acqua, di fresca pioggia di recente passata tra-
verso l'aria e accolta nei canali erbosi ». « L'aria
nei dipinti della scuola di Giorgione par così viva
come gli uomini che la respirano »; « i più aspri
elementi delle montagne sfuggono in una distanza
armoniosa, e una sola roccia di vivido colore az-
zuro resta all'orizzonte, come testimonianza sen-
sibile di ciucila freschezza alpina che è tutto ciò
clie noi chiediamo di sentir qui, e delle sue pioggie
e dei suoi torrenti ». E nel Concerto di Pitti è col-
pito dalla « calma luce sopraterrena » la quale
accoglie in sè tutti gli elementi del quadro, che
in essa tutti insieme si perdono.1
Anche dove parla di paesaggi naturali, il Pater
mostra di considerarli, allo stesso modo del suo
critico ideale, come opere d'arte. Una « luminosa
traccia residuale » dei freschi di Giorgione alla fac-
ciata del Fondaco dei Tedeschi ■< porge un singoiar
tocco addizionale allo splendore della scena di
Rialto ». Il paesaggio che per il Pater forma come
lo sfondo della poesia del Du Bellay e della Pleiade
è da lui pittoricamente sentito: egli vede « la grande
Loire con le sue larghe zone di candida sabbia »;
per lui il doloroso « sentimento delle mine » che
si trova nel Du Bellay è dovuto « al persistere
della rigida tagliente linea delle cose ».2
Parlando di poesia il nostro ricorre spesso a
immagini pittoriche, che in lui non sono semplici
traslati. Ronsard « colora la superficie », del lin-
guaggio della poesia della Francia « con una sin-
golare piacevole apparenza esotica che passa su
tutta quella landa nordica, ma non più profonda
in se stessa, nè più permanente d'un mutevole
effetto di luce
Per il Pater le varie arti tendono a superare i
propri limiti per entrare nel campo di un'altra,
come l'architettura che sembra divenir scultura
« nell'impeccabile unità del campanile di Giotto »;
per lui la netteté remarquable d'exrctition è pro-
pria di tutto il lavoro artistico francese, della
poesia francese come delle pitture dei Clouet;
le caratteristiche della poesia di Villon si ricon-
nettono alle caratteristiche di gotiche sculture od
ornamentazioni francesi; le « Chansons de geste »
sono il riscontro poetico delle cattedrali gotiche.2
Quest'idea del superamento dei limiti che con-
tiene un'affermazione chiara dell'unità dell'arte,
conduce il Pater a una concezione pittorica del bas-
sorilievo. Questo è più pittura che scultura, perchè
«reprime tutte le curve dinotanti la forma solida »;
così il colore, che nella scultura non può essere
che sovrapposizione del tutto estrinseca all'opera
d'arte, è sostituito dal bassorilievo. Sensibilità
prettamente moderna, come quella che gli fa
dire che l'incompiutezza delle sculture di Miche-
langelo « suggerisce assai più di quanto non de-
termini la forma del tutto realizzata »; che gli
fa comprendere « quel che il tempo e il caso e se-
coli d'oscurità sotto le zolle " della piccola fat-
toria di Milo " fecero con singolare felicità di tocco
per la Venere vittoriosa, consumandone la super-
ficie e ammorbidendone le linee, cosi che uno
spirito par sempre sul punto di eromperne, come
se in essa la scultura classica avesse già fatto
un passo nella mistica età cristiana »; che gli
fa conchiudere il saggio su Luca della Robbia
con l'osservazione che l'espressione « è forse la
qualità che rende l'opera, nell'ordine imaginativo,
realmente degna del tutto ».3
Di ogni artista e di ogni scuola il nostro sa
determinare la posizione storica, e un legame
storico unisce tutti i saggi del libro, che ci pone
davanti i diversi aspetti del Rinascimento, nei
suoi diversi momenti. Questo moto (lega spiriti,
nato in Francia con la petite Renaissance, giunto
al suo culmine nell'Italia del '400, e finito in
Francia con la Pleiade, risorse nel '700 per opera
del Winckelmann, figlio spirituale degli antichi
umanisti. Di esso il Pater mette in chiaro uno dei
1 Op. cit., La scuola di Giorgiongt passivi.
2 Op. cit., p. 132, 156, 15<j.
1 Op. cit., p. 145.
J Op. cit., p. 12-U I44-I45.
3 Op. cit., p. 69, 67 e 711.