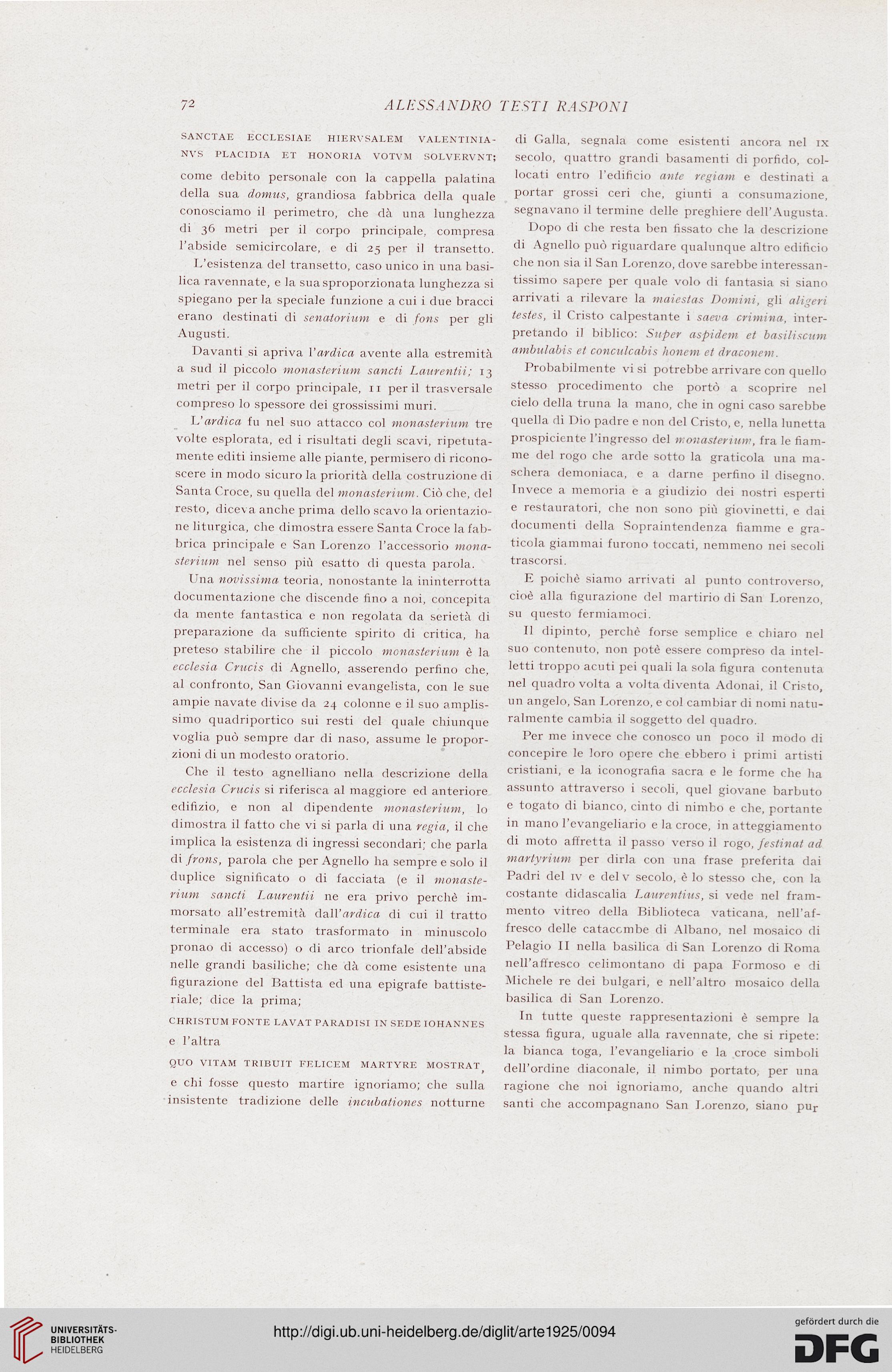7*
A LI: SS ANDRO TESTI RASP0N1
SANCTAE ECCLESIAE HIERVSALEM VALENTINIA-
NV'S PLACIDIA ET HONORIA VOTVM SOLVERVNT;
come debito personale con la cappella palatina
della sua domus, grandiosa fabbrica della quale
conosciamo il perimetro, che dà una lunghezza
di 36 metri per il corpo principale, compresa
l'abside semicircolare, e di 25 per il transetto.
L'esistenza del transetto, caso unico in una basi-
lica ravennate, e la sua sproporzionata lunghezza si
spiegano perla speciale funzione a cui i due bracci
erano destinati di senatorium e di fons per gli
Augusti.
Davanti si apriva Vardica avente alla estremità
a sud il piccolo monasterium sancti Laurenlii; 13
metri per il corpo principale, 11 perii trasversale
compreso lo spessore dei grossissimi muri.
\.'ardica fu nel suo attacco col monasterium tre
volte esplorata, ed i risultati degli scavi, ripetuta-
mente editi insieme alle piante, permisero di ricono-
scere in modo sicuro la priorità della costruzione di
Santa Croce, su quella del monasterium. Ciò che, del
resto, diceva anche prima dello scavo la orientazio-
ne liturgica, che dimostra essere Santa Croce la fab-
brica principale e San Lorenzo l'accessorio mona-
sterium nel senso più esatto di questa parola.
Una novissima teoria, nonostante la ininterrotta
documentazione che discende fino a noi, concepita
da mente fantastica e non regolata da serietà di
preparazione da sufficiente spirito di critica, ha
preteso stabilire che il piccolo monasterium è la
ecclesia Crucis di Agnello, asserendo perfino che,
al confronto, San Giovanni evangelista, con le sue
ampie navate divise da 24 colonne e il suo amplis-
simo quadriportico sui resti del (piale chiunque
voglia può sempre dar di naso, assume le propor-
zioni di un modesto oratorio.
Che il testo agnelliano nella descrizione della
ecclesia Crucis si riferisca al maggiore ed anteriore
edifizio, e non al dipendente monasterium, lo
dimostra il fatto che vi si parla di una regia, il che
implica la esistenza di ingressi secondari; che parla
di frons, parola che per Agnello ha sempre e solo il
duplice significato o di facciata (e il monaste-
rium sancii I.aurcntii ne era privo perchè im-
morsato all'estremità dalVardica di cui il tratto
terminale era stato trasformato in minuscolo
pronao di accesso) o di arco trionfale dell'abside
nelle grandi basiliche; che dà come esistente una
figurazione del Battista ed una epigrafe battiste-
riale; dice la prima;
CHRISTUM FONTE LAVAT PARADISI IN SEDE IOHANNES
e l'altra
QUO VITAM TRIBUIT FELICEM MARTYRE MOSTRAT
e chi fosse questo martire ignoriamo; che sulla
insistente tradizione delle incubationes notturne
di Galla, segnala come esistenti ancora nel ix
secolo, quattro grandi basamenti di porfido, col-
locati entro l'edificio ante regiam e destinati a
portar grossi ceri che, giunti a consumazione,
segnavano il termine delle preghiere dell'Augusta.
Dopo di che resta ben fissato che la descrizione
di Agnello può riguardare qualunque altro edificio
che non sia il San Lorenzo, dove sarebbe interessan-
tissimo sapere per quale volo di fantasia si siano
arrivati a rilevare la maiestas Domini, gli aligeri
testes, il Cristo calpestante i saeva crimina, inter-
pretando il biblico: Super aspidem et basiliscum
ambulabis et conculcabis honem et draconem.
Probabilmente vi si potrebbe arrivare con quello
stesso procedimento che portò a scoprire nel
cielo della truna la mano, che in ogni caso sarebbe
quella di Dio padre e non del Cristo, e, nella lunetta
prospiciente l'ingresso del monasterium, fra le fiam-
me del rogo che arde sotto la graticola una ma-
schera demoniaca, e a darne perfino il disegno.
Invece a memoria e a giudizio dei nostri esperti
e restauratori, che non sono più giovinetti, e dai
documenti della Sopraintendenza fiamme e gra-
ticola giammai furono toccati, nemmeno nei secoli
trascorsi.
E poiché siamo arrivati al punto controverso,
cioè alla figurazione del martirio di San Lorenzo,
su questo fermiamoci.
Il dipinto, perchè forse semplice e chiaro nel
suo contenuto, non potè essere compreso da intel-
letti troppo acuti pei quali la sola figura contenuta
nel quadro volta a volta diventa Adonai, il Cristo,
un angelo, San Lorenzo, e col cambiar di nomi natu-
ralmente cambia il soggetto del quadro.
Per me invece che conosco un poco il modo di
concepire le loro opere che ebbero i primi artisti
cristiani, e la iconografia sacra e le forme che ha
assunto attraverso i secoli, quel giovane barbuto
e togato di bianco, cinto di nimbo e che, portante
in mano l'evangeliario e la croce, in atteggiamento
di moto affretta il passo verso il rogo, festina! ad
martyrium per dirla con una frase preferita dai
Padri del rv e del v secolo, è lo stesso che, con la
costante didascalia Laurentius, si vede nel fram-
mento vitreo della Biblioteca vaticana, nell'af-
fresco delle catacombe di Albano, nel mosaico di
Pelagio II nella basilica di San Lorenzo di Roma
nell'affresco cclimontano di papa Formoso e di
Michele re dei bulgari, e nell'altro mosaico della
basilica di San Lorenzo.
In tutte queste rappresentazioni è sempre la
stessa figura, uguale alla ravennate, che si ripete:
la bianca toga, l'evangeliario e la croce simboli
dell'ordine diaconale, il nimbo portato, per una
ragione che noi ignoriamo, anche quando altri
santi che accompagnano San Lorenzo, siano pur
A LI: SS ANDRO TESTI RASP0N1
SANCTAE ECCLESIAE HIERVSALEM VALENTINIA-
NV'S PLACIDIA ET HONORIA VOTVM SOLVERVNT;
come debito personale con la cappella palatina
della sua domus, grandiosa fabbrica della quale
conosciamo il perimetro, che dà una lunghezza
di 36 metri per il corpo principale, compresa
l'abside semicircolare, e di 25 per il transetto.
L'esistenza del transetto, caso unico in una basi-
lica ravennate, e la sua sproporzionata lunghezza si
spiegano perla speciale funzione a cui i due bracci
erano destinati di senatorium e di fons per gli
Augusti.
Davanti si apriva Vardica avente alla estremità
a sud il piccolo monasterium sancti Laurenlii; 13
metri per il corpo principale, 11 perii trasversale
compreso lo spessore dei grossissimi muri.
\.'ardica fu nel suo attacco col monasterium tre
volte esplorata, ed i risultati degli scavi, ripetuta-
mente editi insieme alle piante, permisero di ricono-
scere in modo sicuro la priorità della costruzione di
Santa Croce, su quella del monasterium. Ciò che, del
resto, diceva anche prima dello scavo la orientazio-
ne liturgica, che dimostra essere Santa Croce la fab-
brica principale e San Lorenzo l'accessorio mona-
sterium nel senso più esatto di questa parola.
Una novissima teoria, nonostante la ininterrotta
documentazione che discende fino a noi, concepita
da mente fantastica e non regolata da serietà di
preparazione da sufficiente spirito di critica, ha
preteso stabilire che il piccolo monasterium è la
ecclesia Crucis di Agnello, asserendo perfino che,
al confronto, San Giovanni evangelista, con le sue
ampie navate divise da 24 colonne e il suo amplis-
simo quadriportico sui resti del (piale chiunque
voglia può sempre dar di naso, assume le propor-
zioni di un modesto oratorio.
Che il testo agnelliano nella descrizione della
ecclesia Crucis si riferisca al maggiore ed anteriore
edifizio, e non al dipendente monasterium, lo
dimostra il fatto che vi si parla di una regia, il che
implica la esistenza di ingressi secondari; che parla
di frons, parola che per Agnello ha sempre e solo il
duplice significato o di facciata (e il monaste-
rium sancii I.aurcntii ne era privo perchè im-
morsato all'estremità dalVardica di cui il tratto
terminale era stato trasformato in minuscolo
pronao di accesso) o di arco trionfale dell'abside
nelle grandi basiliche; che dà come esistente una
figurazione del Battista ed una epigrafe battiste-
riale; dice la prima;
CHRISTUM FONTE LAVAT PARADISI IN SEDE IOHANNES
e l'altra
QUO VITAM TRIBUIT FELICEM MARTYRE MOSTRAT
e chi fosse questo martire ignoriamo; che sulla
insistente tradizione delle incubationes notturne
di Galla, segnala come esistenti ancora nel ix
secolo, quattro grandi basamenti di porfido, col-
locati entro l'edificio ante regiam e destinati a
portar grossi ceri che, giunti a consumazione,
segnavano il termine delle preghiere dell'Augusta.
Dopo di che resta ben fissato che la descrizione
di Agnello può riguardare qualunque altro edificio
che non sia il San Lorenzo, dove sarebbe interessan-
tissimo sapere per quale volo di fantasia si siano
arrivati a rilevare la maiestas Domini, gli aligeri
testes, il Cristo calpestante i saeva crimina, inter-
pretando il biblico: Super aspidem et basiliscum
ambulabis et conculcabis honem et draconem.
Probabilmente vi si potrebbe arrivare con quello
stesso procedimento che portò a scoprire nel
cielo della truna la mano, che in ogni caso sarebbe
quella di Dio padre e non del Cristo, e, nella lunetta
prospiciente l'ingresso del monasterium, fra le fiam-
me del rogo che arde sotto la graticola una ma-
schera demoniaca, e a darne perfino il disegno.
Invece a memoria e a giudizio dei nostri esperti
e restauratori, che non sono più giovinetti, e dai
documenti della Sopraintendenza fiamme e gra-
ticola giammai furono toccati, nemmeno nei secoli
trascorsi.
E poiché siamo arrivati al punto controverso,
cioè alla figurazione del martirio di San Lorenzo,
su questo fermiamoci.
Il dipinto, perchè forse semplice e chiaro nel
suo contenuto, non potè essere compreso da intel-
letti troppo acuti pei quali la sola figura contenuta
nel quadro volta a volta diventa Adonai, il Cristo,
un angelo, San Lorenzo, e col cambiar di nomi natu-
ralmente cambia il soggetto del quadro.
Per me invece che conosco un poco il modo di
concepire le loro opere che ebbero i primi artisti
cristiani, e la iconografia sacra e le forme che ha
assunto attraverso i secoli, quel giovane barbuto
e togato di bianco, cinto di nimbo e che, portante
in mano l'evangeliario e la croce, in atteggiamento
di moto affretta il passo verso il rogo, festina! ad
martyrium per dirla con una frase preferita dai
Padri del rv e del v secolo, è lo stesso che, con la
costante didascalia Laurentius, si vede nel fram-
mento vitreo della Biblioteca vaticana, nell'af-
fresco delle catacombe di Albano, nel mosaico di
Pelagio II nella basilica di San Lorenzo di Roma
nell'affresco cclimontano di papa Formoso e di
Michele re dei bulgari, e nell'altro mosaico della
basilica di San Lorenzo.
In tutte queste rappresentazioni è sempre la
stessa figura, uguale alla ravennate, che si ripete:
la bianca toga, l'evangeliario e la croce simboli
dell'ordine diaconale, il nimbo portato, per una
ragione che noi ignoriamo, anche quando altri
santi che accompagnano San Lorenzo, siano pur