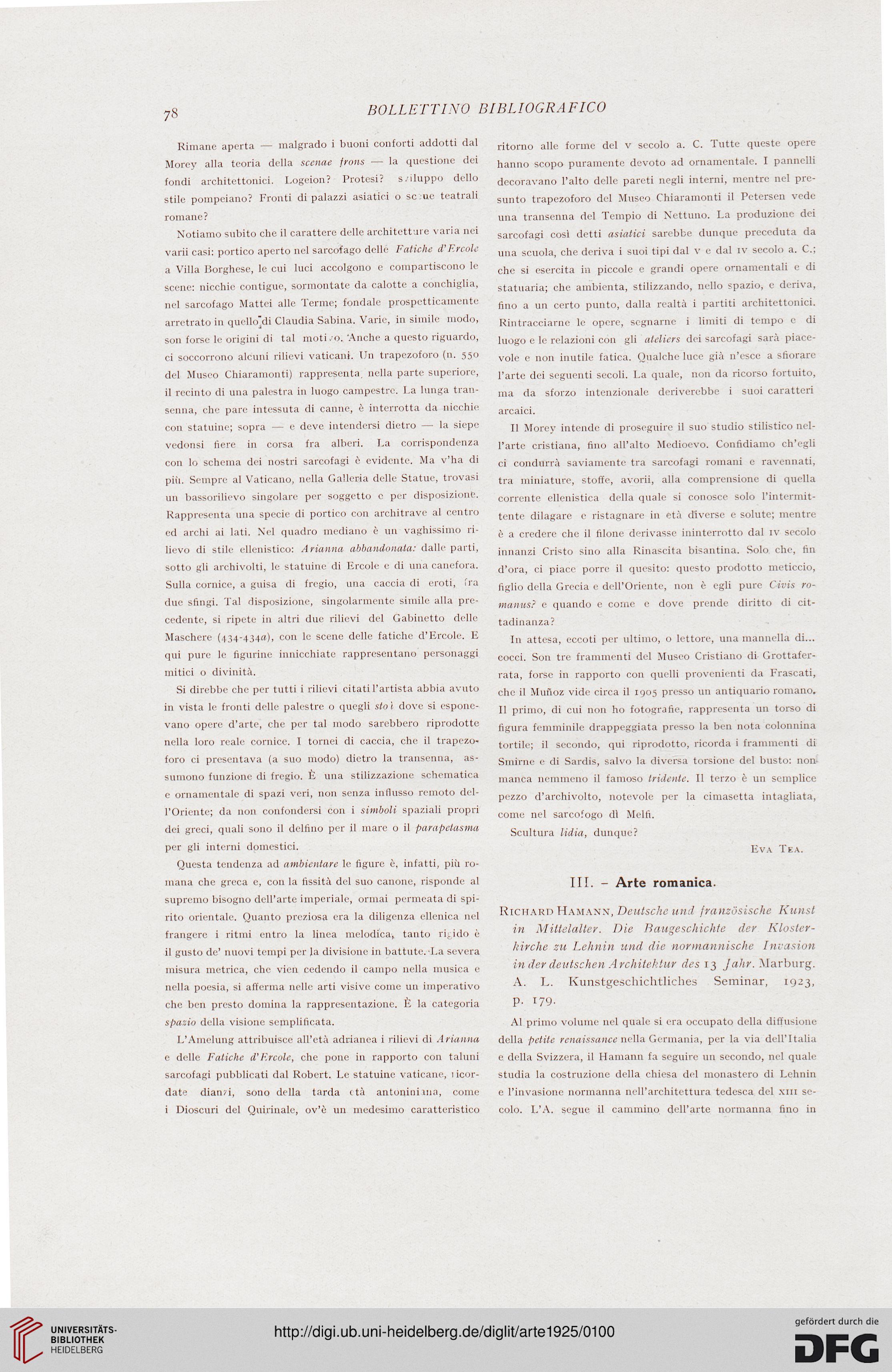78
BOLLETTINI BIBLIOGRA FICO
Rimane aperta — malgrado i buoni conforti addotti dal
Morey alla teoria della scenae frons — la questione dei
fondi architettonici. Logeion? Protesi? s/iluppo dello
stile pompeiano? Fronti di palazzi asiatici o se uc teatrali
r< tuiane?
Notiamo subito che il carattere delle architetture varia nei
varii casi: portico aperto nel sarcofago delle Fatiche d'Ercole
a Villa Borghese, le cui luci accolgono e compartiscono le
scene: nicchie contigue, sormontate da calotte a conchiglia,
nel sarcofago Mattd alle Terme; fondale prospetticamente
arretrato in quello'di Claudia Sabina. Varie, in simile modo,
son forse le origini di tal moti . o. Anche a questo riguardo,
ci soccorrono alcuni rilievi vaticani. Un trapezoforo (n. 550
del Museo Chiarainonti) rappresenta nella parte supcriore,
il recinto di una palestra in luogo campestre. I.a lunga tran-
senna, che pare intessuta di canne, è interrotta da nicchie
con statuine; sopra — e deve intendersi dietro — la siepe
vedonsi fiere in corsa fra alberi. I.a corrispondenza
con lo schema dei nostri sarcofagi è evidente. Ma v'ha di
più. Sempre al Vaticano, nella Galleria delle Statue, trovasi
un bassorilievo singolare per soggetto c per disposizione.
Rappresenta una specie di portico con architrave al centro
ed archi ai lati. Nel quadro mediano è un vaghissimo ri-
lievo di stile ellenistico: Arianna abbandonata: dalle parti,
sotto gli archivolti, le statuine di Ercole e di una canefora.
Sulla cornice, a guisa di fregio, una caccia di eroti, fra
due sfingi. Tal disposizione, singolarmente simile alla pre-
cedente, si ripete in altri due rilievi del Gabinetto delle
Maschere (434-4340), con le scene delle fatiche d'Ercole. E
qui pure le figurine innicchiate rappresentano personaggi
mitici o divinità.
Si direbbe che per tutti i rilievi citati l'artista abbia avuto
in vista le fronti delle palestre o quegli stoì dove si espone-
vano opere d'arte, che per tal modo sarebbero riprodotte
nella loro reale cornice. 1 tornei di caccia, che il trapezo-
foro ci presentava (a suo modo) dietro la transenna, as-
sumono funzione di fregio. È una stilizzazione schematica
e ornamentale di spazi veri, non senza influsso remoto del-
l'Oriente; da non confondersi con i simboli spaziali propri
dei greci, quali sono il delfino per il mare o il parapetasma
per gli interni domestici.
Questa tendenza ad ambientare le figure è, infatti, più ro-
mana che greca e, con la fissità del suo canone, risponde al
supremo bisogno dell'arte imperiale, ormai permeata di spi-
rito orientale. Quanto preziosa era la diligenza ellenica nel
frangere i ritmi entro la linea melodica, tanto ri;ido è
il gusto de' nuovi tempi per la divisione in battute. La severa
misura metrica, che vien cedendo il campo nella musica e
nella poesia, si afferma nelle arti visive come un imperativo
che ben presto domina la rappresentazione. È la categoria
spazio della visione semplificata.
L'Amelung attribuisce all'età adriatica i rilievi di Arianna
e delle Fatiche d'Ercole, che pone in rapporto con taluni
sarcofagi pubblicati dal Robert. Le statuinc vaticane, 1 icor-
date dianzi, sono della tarda (tà antonini ma, come
i Dioscuri del Quirinale, ov'è un medesimo caratteristico
ritorno alle forme del v secolo a. C. Tutte queste opere
hanno scopo puramente devoto ad ornamentale. I pannelli
decoravano l'alto delle pareti negli interni, mentre nel pre-
sunto trapezoforo del Museo Chiaramonti il Petersen vede
una transenna del Tempio di Nettuno. La produzione dei
sarcofagi cosi detti asiatici sarebbe dunque preceduta da
una scuola, che deriva i suoi tipi dal v e dal iv secolo a. C;
che si esercita in piccole e grandi opere ornamentali e di
statuaria; che ambienta, stilizzando, nello spazio, e deriva,
fino a un certo punto, dalla realtà i partiti architettonici.
Rintracciarne le opere, segnarne i limiti di tempo e di
luogo e le relazioni con gli ateliers dei sarcofagi sarà piace-
vole e non inutile fatica. Qualche luce già n'esce a sfiorare
l'arte dei seguenti secoli. La quale, non da ricorso fortuito,
ma da sforzo intenzionale deriverebbe i suoi caratteri
arcaici.
Il Morey intende di proseguire il suo studio stilistico nel-
l'arte cristiana, fino all'alto Medioevo. Confidiamo ch'egli
ci condurrà saviamente tra sarcofagi romani c ravennati,
tra miniature, stoffe, avorii, alla comprensione di quella
corrente ellenistica della quale si conosce solo l'intermit-
tente dilagare e ristagnare in età diverse e solute; mentre
è a credere che il filone derivasse ininterrotto dal iv secolo
innanzi Cristo sino alla Rinascita bizantina. Solo che, fin
d'ora, ci piace porre il quesito: questo prodotto meticcio,
tìglio della Grecia e dell'Oriente, non è egli pure Civis ro-
mamts? e quando e come e dove prende diritto di cit-
tadinanza?
In attesa, eccoti per ultimo, o lettore, una mannella di...
cocci. Son tre frammenti del Museo Cristiano di Grottafer-
rata, forse in rapporto con quelli provenienti da Frascati,
che il Munoz vide circa il 1905 presso un antiquario romano.
Il primo, di cui non ho fotografie, rappresenta un torso di
figura femminile drappeggiata presso la ben nota colonnina
tortile; il secondo, qui riprodotto, ricorda i frammenti di
Smirne e di Sardis, salvo la diversa torsione del busto: non-
manca nemmeno il famoso tridente. Il terzo è un semplice
pezzo d'archivolto, notevole per la ciniasetta intagliata,
come nel sarcofogo di Melfi.
Scultura lidia, dunque?
Eva Tea.
III. - Arte romanica.
RICHARD Hamann, Deutsche unii franzosische Kunst
in Miltelaltcr. Die BaugesckicMe der Klosler-
Itirche zu Lehnin und die normannische Invasion
in der deutschen Arcltitehtur des 13 Jahr. Marburg.
A. L. Kunstgeschichtliches Seminar, 1923,
P- 179.
Al primo volume nel quale si era occupato della diffusione
della petite renaissance nella Germania, per la via dell'Italia
e della Svizzera, il Hamann fa seguire un secondo, nel quale
studia la costruzione della chiesa del monastero di Lehnin
e l'invasione normanna nell'architettura tedesca del xxxi se-
colo. L'A. segue il cammino dell'arte normanna fino in
BOLLETTINI BIBLIOGRA FICO
Rimane aperta — malgrado i buoni conforti addotti dal
Morey alla teoria della scenae frons — la questione dei
fondi architettonici. Logeion? Protesi? s/iluppo dello
stile pompeiano? Fronti di palazzi asiatici o se uc teatrali
r< tuiane?
Notiamo subito che il carattere delle architetture varia nei
varii casi: portico aperto nel sarcofago delle Fatiche d'Ercole
a Villa Borghese, le cui luci accolgono e compartiscono le
scene: nicchie contigue, sormontate da calotte a conchiglia,
nel sarcofago Mattd alle Terme; fondale prospetticamente
arretrato in quello'di Claudia Sabina. Varie, in simile modo,
son forse le origini di tal moti . o. Anche a questo riguardo,
ci soccorrono alcuni rilievi vaticani. Un trapezoforo (n. 550
del Museo Chiarainonti) rappresenta nella parte supcriore,
il recinto di una palestra in luogo campestre. I.a lunga tran-
senna, che pare intessuta di canne, è interrotta da nicchie
con statuine; sopra — e deve intendersi dietro — la siepe
vedonsi fiere in corsa fra alberi. I.a corrispondenza
con lo schema dei nostri sarcofagi è evidente. Ma v'ha di
più. Sempre al Vaticano, nella Galleria delle Statue, trovasi
un bassorilievo singolare per soggetto c per disposizione.
Rappresenta una specie di portico con architrave al centro
ed archi ai lati. Nel quadro mediano è un vaghissimo ri-
lievo di stile ellenistico: Arianna abbandonata: dalle parti,
sotto gli archivolti, le statuine di Ercole e di una canefora.
Sulla cornice, a guisa di fregio, una caccia di eroti, fra
due sfingi. Tal disposizione, singolarmente simile alla pre-
cedente, si ripete in altri due rilievi del Gabinetto delle
Maschere (434-4340), con le scene delle fatiche d'Ercole. E
qui pure le figurine innicchiate rappresentano personaggi
mitici o divinità.
Si direbbe che per tutti i rilievi citati l'artista abbia avuto
in vista le fronti delle palestre o quegli stoì dove si espone-
vano opere d'arte, che per tal modo sarebbero riprodotte
nella loro reale cornice. 1 tornei di caccia, che il trapezo-
foro ci presentava (a suo modo) dietro la transenna, as-
sumono funzione di fregio. È una stilizzazione schematica
e ornamentale di spazi veri, non senza influsso remoto del-
l'Oriente; da non confondersi con i simboli spaziali propri
dei greci, quali sono il delfino per il mare o il parapetasma
per gli interni domestici.
Questa tendenza ad ambientare le figure è, infatti, più ro-
mana che greca e, con la fissità del suo canone, risponde al
supremo bisogno dell'arte imperiale, ormai permeata di spi-
rito orientale. Quanto preziosa era la diligenza ellenica nel
frangere i ritmi entro la linea melodica, tanto ri;ido è
il gusto de' nuovi tempi per la divisione in battute. La severa
misura metrica, che vien cedendo il campo nella musica e
nella poesia, si afferma nelle arti visive come un imperativo
che ben presto domina la rappresentazione. È la categoria
spazio della visione semplificata.
L'Amelung attribuisce all'età adriatica i rilievi di Arianna
e delle Fatiche d'Ercole, che pone in rapporto con taluni
sarcofagi pubblicati dal Robert. Le statuinc vaticane, 1 icor-
date dianzi, sono della tarda (tà antonini ma, come
i Dioscuri del Quirinale, ov'è un medesimo caratteristico
ritorno alle forme del v secolo a. C. Tutte queste opere
hanno scopo puramente devoto ad ornamentale. I pannelli
decoravano l'alto delle pareti negli interni, mentre nel pre-
sunto trapezoforo del Museo Chiaramonti il Petersen vede
una transenna del Tempio di Nettuno. La produzione dei
sarcofagi cosi detti asiatici sarebbe dunque preceduta da
una scuola, che deriva i suoi tipi dal v e dal iv secolo a. C;
che si esercita in piccole e grandi opere ornamentali e di
statuaria; che ambienta, stilizzando, nello spazio, e deriva,
fino a un certo punto, dalla realtà i partiti architettonici.
Rintracciarne le opere, segnarne i limiti di tempo e di
luogo e le relazioni con gli ateliers dei sarcofagi sarà piace-
vole e non inutile fatica. Qualche luce già n'esce a sfiorare
l'arte dei seguenti secoli. La quale, non da ricorso fortuito,
ma da sforzo intenzionale deriverebbe i suoi caratteri
arcaici.
Il Morey intende di proseguire il suo studio stilistico nel-
l'arte cristiana, fino all'alto Medioevo. Confidiamo ch'egli
ci condurrà saviamente tra sarcofagi romani c ravennati,
tra miniature, stoffe, avorii, alla comprensione di quella
corrente ellenistica della quale si conosce solo l'intermit-
tente dilagare e ristagnare in età diverse e solute; mentre
è a credere che il filone derivasse ininterrotto dal iv secolo
innanzi Cristo sino alla Rinascita bizantina. Solo che, fin
d'ora, ci piace porre il quesito: questo prodotto meticcio,
tìglio della Grecia e dell'Oriente, non è egli pure Civis ro-
mamts? e quando e come e dove prende diritto di cit-
tadinanza?
In attesa, eccoti per ultimo, o lettore, una mannella di...
cocci. Son tre frammenti del Museo Cristiano di Grottafer-
rata, forse in rapporto con quelli provenienti da Frascati,
che il Munoz vide circa il 1905 presso un antiquario romano.
Il primo, di cui non ho fotografie, rappresenta un torso di
figura femminile drappeggiata presso la ben nota colonnina
tortile; il secondo, qui riprodotto, ricorda i frammenti di
Smirne e di Sardis, salvo la diversa torsione del busto: non-
manca nemmeno il famoso tridente. Il terzo è un semplice
pezzo d'archivolto, notevole per la ciniasetta intagliata,
come nel sarcofogo di Melfi.
Scultura lidia, dunque?
Eva Tea.
III. - Arte romanica.
RICHARD Hamann, Deutsche unii franzosische Kunst
in Miltelaltcr. Die BaugesckicMe der Klosler-
Itirche zu Lehnin und die normannische Invasion
in der deutschen Arcltitehtur des 13 Jahr. Marburg.
A. L. Kunstgeschichtliches Seminar, 1923,
P- 179.
Al primo volume nel quale si era occupato della diffusione
della petite renaissance nella Germania, per la via dell'Italia
e della Svizzera, il Hamann fa seguire un secondo, nel quale
studia la costruzione della chiesa del monastero di Lehnin
e l'invasione normanna nell'architettura tedesca del xxxi se-
colo. L'A. segue il cammino dell'arte normanna fino in