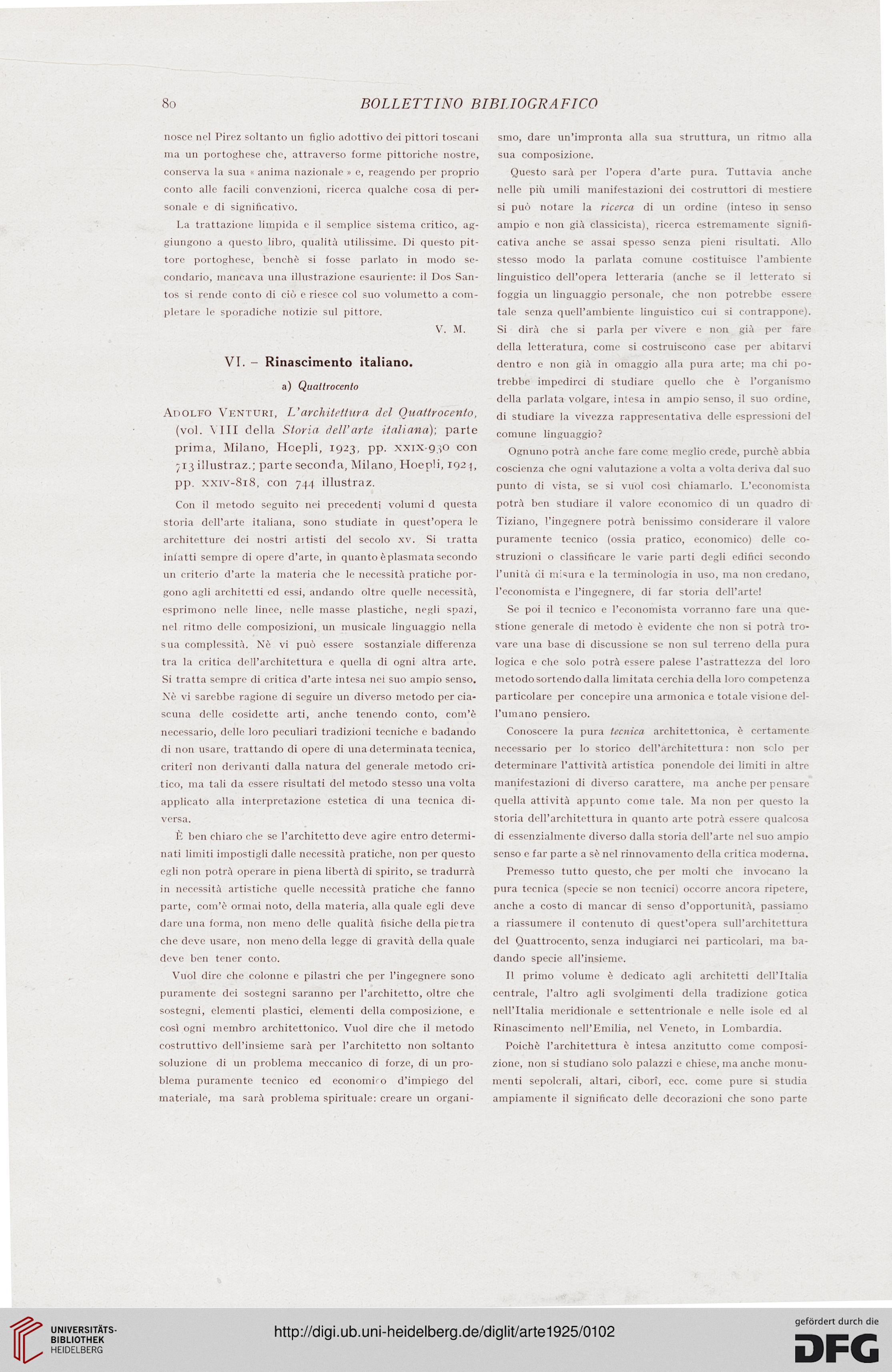8o
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
nosce nel Pirez soltanto un figlio adottivo dei pittori toscani
ma un portoghese che, attraverso forme pittoriche nostre,
conserva la sua « anima nazionale » e, reagendo per proprio
conto alle facili convenzioni, ricerca qualche cosa di per*
sonale e di significativo.
La trattazione limpida e ii semplice sistema critico, ag-
giungono a questo libro, qualità utilissime. Di questo pit-
tore portoghese, benché si fosse parlato in modo se-
condario, mancava una illustrazione esauriente: il Dos San-
tos si rende conto di ciò e riesce col suo volumetto a com-
pletare le sporadiche notizie sul pittore.
V. M.
VI. - Rinascimento italiano.
a) Quattrocento
Adolfo Venturi, L'architettura del Quattrocento,
(voi. Vili della Storia dell'arte italiana); parie
prima, Milano, Hoepli, 1923, pp. xxix-g 50 con
-13 illustra?.; parte seconda, Milano, Hoepli, 192 |,
pp. xxiv-818, con 744 illustraz.
Con il metodo seguito nei precedenti volumi d questa
storia dell'arte italiana, sono studiate in quest'opera le
architetture dei nostri aitisti del secolo XV. Si tratta
inlatti sempre di opere d'arte, in quanto èplasmata secondo
un criterio d'arte la materia che le necessità pratiche por-
gono agli architetti ed essi, andando oltre quelle necessità,
esprimono nelle lince, nelle masse plastiche, negli spazi,
nel ritmo delle composizioni, un musicale linguaggio nella
sua complessità. Nè vi può essere sostanziale differenza
tra la critica dell'architettura c quella di ogni altra arte.
Si tratta sempre di critica d'arte intesa nel suo ampio senso.
Nè vi sarebbe ragione di seguire un diverso metodo per cia-
scuna delle cosidette arti, anche tenendo conto, com'è
necessario, delle loro peculiari tradizioni tecniche e badando
di non usare, trattando di opere di una detcrminata tecnica,
criteri non derivanti dalla natura del generale metodo cri-
tico, ina tali da essere risultati del metodo stesso una volta
applicato alla interpretazione estetica di una tecnica di-
versa.
È ben chiaro che se l'architetto deve agire entro detcrmi-
nati limiti impostigli dalle necessità pratiche, non per questo
egli non potrà operare in piena libertà di spirito, se tradurrà
in necessità artistiche quelle necessità pratiche che fanno
parte, com'è ormai noto, della materia, alla quale egli deve
dare una forma, non meno delle qualità fisiche della pietra
che deve usare, non meno della legge di gravità della quale
deve ben tener conto.
Vuol dire che colonne e pilastri che per l'ingegnere sono
puramente dei sostegni saranno per l'architetto, oltre che
sostegni, clementi plastici, elementi della composizione, e
così ogni membro architettonico. Vuol dire che il metodo
costruttivo dell'insieme sarà per l'architetto non soltanto
soluzione di un problema meccanico di forze, di un pro-
blema puramente tecnico ed economi'o d'impiego del
materiale, ma sarà problema spirituale: creare un organi-
smo, dare un'impronta alla sua struttura, un ritmo alla
sua composizione
Questo sarà per l'opera d'arte pura. Tuttavia anche
nelle più umili manifestazioni dei costruttori di mestiere
si può notare la ricerca di un ordine (inteso in senso
ampio e non già classicista), ricerca estremamente signifi-
cativa anche se assai spesso senza pieni risultati. Allo
stesso modo la parlata comune costituisce l'ambiente
linguistico dell'opera letteraria (anche se il letterato si
foggia un linguaggio personale, che non potrebbe essere
tale senza quell'ambiente linguistico cui si contrappone).
Si dirà che si parla per vivere e non già per fare
della letteratura, come si costruiscono case per abitarvi
dentro e non già in omaggio alla pura arte; ma chi po-
trebbe impedirci di studiare quello che è l'organismo
della parlata volgare, intesa in ampio senso, il suo ordine,
di studiare la vivezza rappresentativa delle espressioni del
comune linguaggio?
Ognuno potrà anche fare come meglio crede, purché abbia
coscienza che ogni valutazione a volta a volta deriva dal suo
punto di vista, se si vuol così chiamarlo. L'economista
potrà ben studiare il valore economico di un quadro di
Tiziano, l'ingegnere potrà benissimo considerare il valore
puramente tecnico (ossia pratico, economico) delle co-
struzioni o classificare le varie parti degli edifici secondo
l'unità ci misura e la terminologia in uso, ma non credano,
l'economista e l'ingegnere, di far storia dell'arte!
Se poi il tecnico e l'economista vorranno fare una que-
stione generale di metodo è evidente che non si potrà tro-
vare una base di discussione se non sul terreno della pura
logica e che solo potrà essere palese l'astrattezza del loro
metodo sortendo dalla limitata cerchia della loro competenza
particolare per concepire una armonica e totale visione del-
l'umano pensiero.
Conoscere la pura tecnica architettonica, è certamente
necessario per Io storico dell'architettura : non solo per
determinare l'attività artistica ponendole dei limiti in altre
manifestazioni di diverso carattere, ma anche per pensare
quella attività appunto come tale. Ma non per questo la
storia dell'architettura in quanto arte potrà essere qualcosa
di essenzialmente diverso dalla storia dell'arte nel suo ampio
senso e far parte a sè nel rinnovamento della critica moderna.
Premesso tutto questo, che per molti che invocano la
pura tecnica (specie se non tecnici) occorre ancora ripetere,
anche a costo di mancar di senso d'opportunità, passiamo
a riassumere il contenuto di quest'opera sull'architettura
del Quattrocento, senza indugiarci nei particolari, ma ba-
dando specie all'insieme.
Il primo volume è dedicato agli architetti dell'Italia
centrale, l'altro agli svolgimenti della tradizione gotica
nell'Italia meridionale e settentrionale e nelle isole ed al
Rinascimento nell'Emilia, nel Veneto, in Lombardia.
Poiché l'architettura è intesa anzitutto come composi-
zione, non si studiano solo palazzi e chiese, ma anche monu-
menti sepolcrali, altari, cibori, ecc. come pure si studia
ampiamente il significato delle decorazioni che sono parte
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
nosce nel Pirez soltanto un figlio adottivo dei pittori toscani
ma un portoghese che, attraverso forme pittoriche nostre,
conserva la sua « anima nazionale » e, reagendo per proprio
conto alle facili convenzioni, ricerca qualche cosa di per*
sonale e di significativo.
La trattazione limpida e ii semplice sistema critico, ag-
giungono a questo libro, qualità utilissime. Di questo pit-
tore portoghese, benché si fosse parlato in modo se-
condario, mancava una illustrazione esauriente: il Dos San-
tos si rende conto di ciò e riesce col suo volumetto a com-
pletare le sporadiche notizie sul pittore.
V. M.
VI. - Rinascimento italiano.
a) Quattrocento
Adolfo Venturi, L'architettura del Quattrocento,
(voi. Vili della Storia dell'arte italiana); parie
prima, Milano, Hoepli, 1923, pp. xxix-g 50 con
-13 illustra?.; parte seconda, Milano, Hoepli, 192 |,
pp. xxiv-818, con 744 illustraz.
Con il metodo seguito nei precedenti volumi d questa
storia dell'arte italiana, sono studiate in quest'opera le
architetture dei nostri aitisti del secolo XV. Si tratta
inlatti sempre di opere d'arte, in quanto èplasmata secondo
un criterio d'arte la materia che le necessità pratiche por-
gono agli architetti ed essi, andando oltre quelle necessità,
esprimono nelle lince, nelle masse plastiche, negli spazi,
nel ritmo delle composizioni, un musicale linguaggio nella
sua complessità. Nè vi può essere sostanziale differenza
tra la critica dell'architettura c quella di ogni altra arte.
Si tratta sempre di critica d'arte intesa nel suo ampio senso.
Nè vi sarebbe ragione di seguire un diverso metodo per cia-
scuna delle cosidette arti, anche tenendo conto, com'è
necessario, delle loro peculiari tradizioni tecniche e badando
di non usare, trattando di opere di una detcrminata tecnica,
criteri non derivanti dalla natura del generale metodo cri-
tico, ina tali da essere risultati del metodo stesso una volta
applicato alla interpretazione estetica di una tecnica di-
versa.
È ben chiaro che se l'architetto deve agire entro detcrmi-
nati limiti impostigli dalle necessità pratiche, non per questo
egli non potrà operare in piena libertà di spirito, se tradurrà
in necessità artistiche quelle necessità pratiche che fanno
parte, com'è ormai noto, della materia, alla quale egli deve
dare una forma, non meno delle qualità fisiche della pietra
che deve usare, non meno della legge di gravità della quale
deve ben tener conto.
Vuol dire che colonne e pilastri che per l'ingegnere sono
puramente dei sostegni saranno per l'architetto, oltre che
sostegni, clementi plastici, elementi della composizione, e
così ogni membro architettonico. Vuol dire che il metodo
costruttivo dell'insieme sarà per l'architetto non soltanto
soluzione di un problema meccanico di forze, di un pro-
blema puramente tecnico ed economi'o d'impiego del
materiale, ma sarà problema spirituale: creare un organi-
smo, dare un'impronta alla sua struttura, un ritmo alla
sua composizione
Questo sarà per l'opera d'arte pura. Tuttavia anche
nelle più umili manifestazioni dei costruttori di mestiere
si può notare la ricerca di un ordine (inteso in senso
ampio e non già classicista), ricerca estremamente signifi-
cativa anche se assai spesso senza pieni risultati. Allo
stesso modo la parlata comune costituisce l'ambiente
linguistico dell'opera letteraria (anche se il letterato si
foggia un linguaggio personale, che non potrebbe essere
tale senza quell'ambiente linguistico cui si contrappone).
Si dirà che si parla per vivere e non già per fare
della letteratura, come si costruiscono case per abitarvi
dentro e non già in omaggio alla pura arte; ma chi po-
trebbe impedirci di studiare quello che è l'organismo
della parlata volgare, intesa in ampio senso, il suo ordine,
di studiare la vivezza rappresentativa delle espressioni del
comune linguaggio?
Ognuno potrà anche fare come meglio crede, purché abbia
coscienza che ogni valutazione a volta a volta deriva dal suo
punto di vista, se si vuol così chiamarlo. L'economista
potrà ben studiare il valore economico di un quadro di
Tiziano, l'ingegnere potrà benissimo considerare il valore
puramente tecnico (ossia pratico, economico) delle co-
struzioni o classificare le varie parti degli edifici secondo
l'unità ci misura e la terminologia in uso, ma non credano,
l'economista e l'ingegnere, di far storia dell'arte!
Se poi il tecnico e l'economista vorranno fare una que-
stione generale di metodo è evidente che non si potrà tro-
vare una base di discussione se non sul terreno della pura
logica e che solo potrà essere palese l'astrattezza del loro
metodo sortendo dalla limitata cerchia della loro competenza
particolare per concepire una armonica e totale visione del-
l'umano pensiero.
Conoscere la pura tecnica architettonica, è certamente
necessario per Io storico dell'architettura : non solo per
determinare l'attività artistica ponendole dei limiti in altre
manifestazioni di diverso carattere, ma anche per pensare
quella attività appunto come tale. Ma non per questo la
storia dell'architettura in quanto arte potrà essere qualcosa
di essenzialmente diverso dalla storia dell'arte nel suo ampio
senso e far parte a sè nel rinnovamento della critica moderna.
Premesso tutto questo, che per molti che invocano la
pura tecnica (specie se non tecnici) occorre ancora ripetere,
anche a costo di mancar di senso d'opportunità, passiamo
a riassumere il contenuto di quest'opera sull'architettura
del Quattrocento, senza indugiarci nei particolari, ma ba-
dando specie all'insieme.
Il primo volume è dedicato agli architetti dell'Italia
centrale, l'altro agli svolgimenti della tradizione gotica
nell'Italia meridionale e settentrionale e nelle isole ed al
Rinascimento nell'Emilia, nel Veneto, in Lombardia.
Poiché l'architettura è intesa anzitutto come composi-
zione, non si studiano solo palazzi e chiese, ma anche monu-
menti sepolcrali, altari, cibori, ecc. come pure si studia
ampiamente il significato delle decorazioni che sono parte