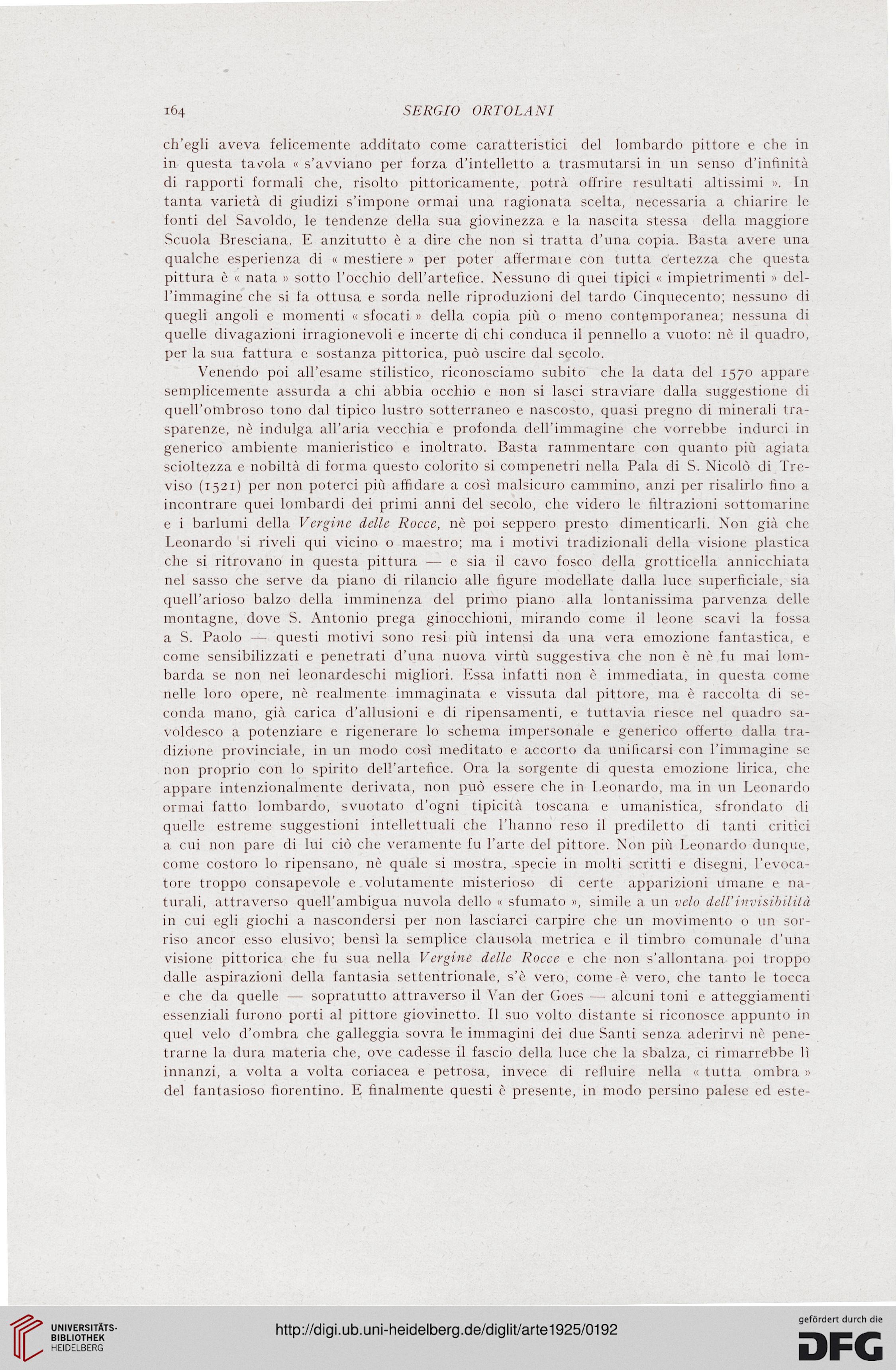164
SERGIO ORTOLANI
ch'egli aveva felicemente additato come caratteristici del lombardo pittore e che in
in questa tavola « s'avviano per forza d'intelletto a trasmutarsi in un senso d'infinità
di rapporti formali che, risolto pittoricamente, potrà offrire resultati altissimi ». In
tanta varietà di giudizi s'impone ormai una ragionata scelta, necessaria a chiarire le
fonti del Savoldo, le tendenze della sua giovinezza e la nascita stessa della maggiore
Scuola Bresciana. E anzitutto è a dire che non si tratta d'una copia. Basta avere una
qualche esperienza di « mestiere » per poter affermate con tutta certezza che questa
pittura è « nata » sotto l'occhio dell'artefice. Nessuno di quei tipici « impietrimenti » del-
l'immagine che si fa ottusa e sorda nelle riproduzioni del tardo Cinquecento; nessuno di
quegli angoli e momenti « sfocati » della copia più o meno contemporanea; nessuna di
quelle divagazioni irragionevoli e incerte di chi conduca il pennello a vuoto; nò il quadro,
per la sua fattura e sostanza pittorica, può uscire dal secolo.
Venendo poi all'esame stilistico, riconosciamo subito che la data del 1570 appare
semplicemente assurda a chi abbia occhio e non si lasci straviare dalla suggestione di
quell'ombroso tono dal tipico lustro sotterraneo e nascosto, quasi pregno di minerali tra-
sparenze, ne indulga all'aria vecchia e profonda dell'immagine che vorrebbe indurci in
generico ambiente manieristico e inoltrato. Basta rammentare con quanto più agiata
scioltezza e nobiltà di forma questo colorito si compenetri nella Pala di S. Nicolò di Tre-
viso (1521) per non poterci più affidare a così malsicuro cammino, anzi per risalirlo lino a
incontrare quei lombardi dei primi anni del secolo, che videro le filtrazioni sottomarine
e i barlumi della Vergine delle Rocce, nò poi seppero presto dimenticarli. Non già che
Leonardo si riveli qui vicino o maestro; ma i motivi tradizionali della visione plastica
che si ritrovano in questa pittura — e sia il cavo fosco della grotticella annicchiata
nel sasso che serve da piano di rilancio alle figure modellate dalla luce superficiale, sia
quell'arioso balzo della imminenza del primo piano alla lontanissima parvenza delle
montagne, dove S. Antonio prega ginocchioni, mirando come il leone scavi la fossa
a S. Paolo — questi motivi sono resi più intensi da una vera emozione fantastica, e
come sensibilizzati e penetrati d'una nuova virtù suggestiva che non è nè fu mai lom-
barda se non nei leonardeschi migliori. Essa infatti non è immediata, in questa come
nelle loro opere, ne realmente immaginata e vissuta dal pittore, ma è raccolta di se-
conda mano, già carica d'allusioni e di ripensamenti, e tuttavia riesce nel quadro sa-
voldesco a potenziare e rigenerare lo schema impersonale e generico offerto dalla tra-
dizione provinciale, in un modo così meditato e accorto da unificarsi con l'immagine se
non proprio con lo spirito dell'artefice. Ora la sorgente di questa emozione lirica, che
appare intenzionalmente derivata, non può essere che in Leonardo, ma in un Leonardo
ormai fatto lombardo, svuotato d'ogni tipicità toscana e umanistica, sfrondato di
quelle estreme suggestioni intellettuali che l'hanno reso il prediletto di tanti critici
a cui non pare di lui ciò che veramente fu l'arte del pittore. Non più Leonardo dunque,
come costoro lo ripensano, nè quale si mostra, specie in molti scritti e disegni, l'evoca-
tore troppo consapevole e volutamente misterioso di certe apparizioni umane e na-
turali, attraverso quell'ambigua nuvola dello « sfumato », simile a un velo dell'invisibilità
in cui egli giochi a nascondersi per non lasciarci carpire che un movimento o un sor-
riso ancor esso elusivo; bensì la semplice clausola metrica e il timbro comunale d'una
visione pittorica che fu sua nella Vergine delle Rocce e che non s'allontana poi troppo
dalle aspirazioni della fantasia settentrionale, s'è vero, come è vero, che tanto le tocca
e che da quelle — sopratutto attraverso il Van der Goes — alcuni toni e atteggiamenti
essenziali furono porti al pittore giovinetto. Il suo volto distante si riconosce appunto in
quel velo d'ombra che galleggia sovra le immagini dei due Santi senza aderirvi nè pene-
trarne la dura materia che, ove cadesse il fascio della luce che la sbalza, ci rimarrebbe lì
innanzi, a volta a volta coriacea e petrosa, invece di refluire nella « tutta ombra »
del fantasioso fiorentino. E finalmente questi è presente, in modo persino palese ed este-
SERGIO ORTOLANI
ch'egli aveva felicemente additato come caratteristici del lombardo pittore e che in
in questa tavola « s'avviano per forza d'intelletto a trasmutarsi in un senso d'infinità
di rapporti formali che, risolto pittoricamente, potrà offrire resultati altissimi ». In
tanta varietà di giudizi s'impone ormai una ragionata scelta, necessaria a chiarire le
fonti del Savoldo, le tendenze della sua giovinezza e la nascita stessa della maggiore
Scuola Bresciana. E anzitutto è a dire che non si tratta d'una copia. Basta avere una
qualche esperienza di « mestiere » per poter affermate con tutta certezza che questa
pittura è « nata » sotto l'occhio dell'artefice. Nessuno di quei tipici « impietrimenti » del-
l'immagine che si fa ottusa e sorda nelle riproduzioni del tardo Cinquecento; nessuno di
quegli angoli e momenti « sfocati » della copia più o meno contemporanea; nessuna di
quelle divagazioni irragionevoli e incerte di chi conduca il pennello a vuoto; nò il quadro,
per la sua fattura e sostanza pittorica, può uscire dal secolo.
Venendo poi all'esame stilistico, riconosciamo subito che la data del 1570 appare
semplicemente assurda a chi abbia occhio e non si lasci straviare dalla suggestione di
quell'ombroso tono dal tipico lustro sotterraneo e nascosto, quasi pregno di minerali tra-
sparenze, ne indulga all'aria vecchia e profonda dell'immagine che vorrebbe indurci in
generico ambiente manieristico e inoltrato. Basta rammentare con quanto più agiata
scioltezza e nobiltà di forma questo colorito si compenetri nella Pala di S. Nicolò di Tre-
viso (1521) per non poterci più affidare a così malsicuro cammino, anzi per risalirlo lino a
incontrare quei lombardi dei primi anni del secolo, che videro le filtrazioni sottomarine
e i barlumi della Vergine delle Rocce, nò poi seppero presto dimenticarli. Non già che
Leonardo si riveli qui vicino o maestro; ma i motivi tradizionali della visione plastica
che si ritrovano in questa pittura — e sia il cavo fosco della grotticella annicchiata
nel sasso che serve da piano di rilancio alle figure modellate dalla luce superficiale, sia
quell'arioso balzo della imminenza del primo piano alla lontanissima parvenza delle
montagne, dove S. Antonio prega ginocchioni, mirando come il leone scavi la fossa
a S. Paolo — questi motivi sono resi più intensi da una vera emozione fantastica, e
come sensibilizzati e penetrati d'una nuova virtù suggestiva che non è nè fu mai lom-
barda se non nei leonardeschi migliori. Essa infatti non è immediata, in questa come
nelle loro opere, ne realmente immaginata e vissuta dal pittore, ma è raccolta di se-
conda mano, già carica d'allusioni e di ripensamenti, e tuttavia riesce nel quadro sa-
voldesco a potenziare e rigenerare lo schema impersonale e generico offerto dalla tra-
dizione provinciale, in un modo così meditato e accorto da unificarsi con l'immagine se
non proprio con lo spirito dell'artefice. Ora la sorgente di questa emozione lirica, che
appare intenzionalmente derivata, non può essere che in Leonardo, ma in un Leonardo
ormai fatto lombardo, svuotato d'ogni tipicità toscana e umanistica, sfrondato di
quelle estreme suggestioni intellettuali che l'hanno reso il prediletto di tanti critici
a cui non pare di lui ciò che veramente fu l'arte del pittore. Non più Leonardo dunque,
come costoro lo ripensano, nè quale si mostra, specie in molti scritti e disegni, l'evoca-
tore troppo consapevole e volutamente misterioso di certe apparizioni umane e na-
turali, attraverso quell'ambigua nuvola dello « sfumato », simile a un velo dell'invisibilità
in cui egli giochi a nascondersi per non lasciarci carpire che un movimento o un sor-
riso ancor esso elusivo; bensì la semplice clausola metrica e il timbro comunale d'una
visione pittorica che fu sua nella Vergine delle Rocce e che non s'allontana poi troppo
dalle aspirazioni della fantasia settentrionale, s'è vero, come è vero, che tanto le tocca
e che da quelle — sopratutto attraverso il Van der Goes — alcuni toni e atteggiamenti
essenziali furono porti al pittore giovinetto. Il suo volto distante si riconosce appunto in
quel velo d'ombra che galleggia sovra le immagini dei due Santi senza aderirvi nè pene-
trarne la dura materia che, ove cadesse il fascio della luce che la sbalza, ci rimarrebbe lì
innanzi, a volta a volta coriacea e petrosa, invece di refluire nella « tutta ombra »
del fantasioso fiorentino. E finalmente questi è presente, in modo persino palese ed este-