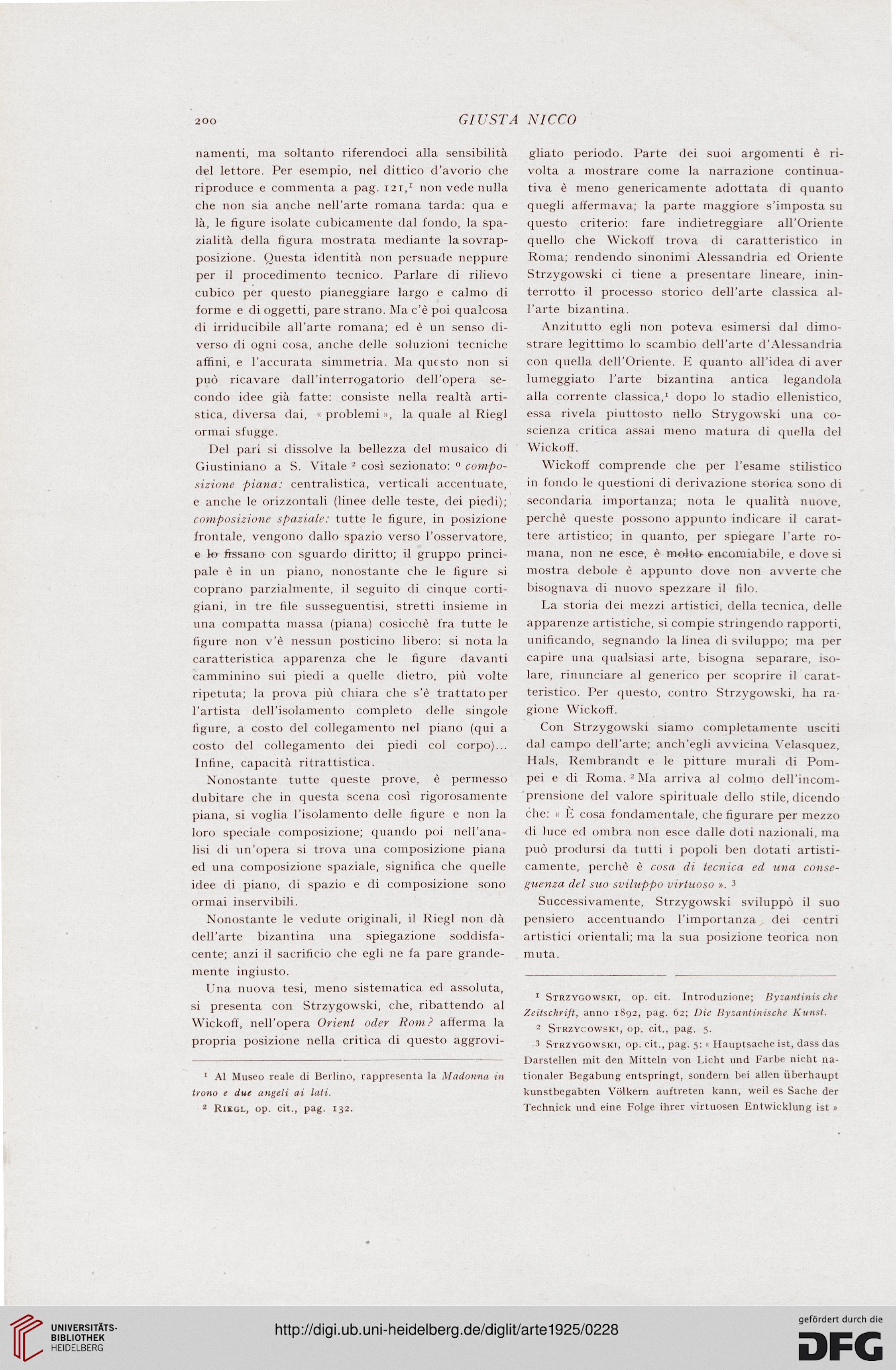200
GIUSTA NICCO
namenti, ma soltanto riferendoci alla sensibilità
del lettore. Per esempio, nel dittico d'avorio che
riproduce e commenta a pag. 121,1 non vede nulla
che non sia anche nell'arte romana tarda: qua e
là, le figure isolate cubicamente dal fondo, la spa-
zialità della figura mostrata mediante la sovrap-
posizione. Questa identità non persuade neppure
per il procedimento tecnico. Parlare di rilievo
cubico per questo pianeggiare largo e calmo di
forme e di oggetti, pare strano. Afa c'è poi qualcosa
di irriducibile all'arte romana; ed è un senso di-
verso di ogni cosa, anche delle soluzioni tecniche
affini, e l'accurata simmetria. Ma questo non si
può ricavare dall'interrogatorio dell'opera se-
condo idee già fatte: consiste nella realtà arti-
stica, diversa dai, « problemi », la quale al Riegl
ormai sfugge.
Del pari si dissolve la bellezza del musaico di
Giustiniano a S. V'itale 2 così sezionato: 0 compo-
sizione piana: centralistica, verticali accentuate,
e anche le orizzontali (linee delle teste, dei piedi);
composizione spaziale: tutte le figure, in posizione
frontale, vengono dallo spazio verso l'osservatore,
e Ut fissano con sguardo diritto; il gruppo princi-
pale è in un piano, nonostante che le figure si
coprano parzialmente, il seguito di cinque corti-
giani, in tre file susseguentisi, stretti insieme in
una compatta massa (piana) cosicché fra tutte le
figure non v'è nessun posticino libero: si nota la
caratteristica apparenza che le figure davanti
camminino sui piedi a quelle dietro, più volte
ripetuta; la prova più chiara che s'è trattato per
l'artista dell'isolamento completo delle singole
figure, a costo del collegamento nel piano (qui a
costo del collegamento dei piedi col corpo)...
Infine, capacità ritrattistica.
Nonostante tutte queste prove, è permesso
dubitare che in questa scena così rigorosamente
piana, si voglia l'isolamento delle figure e non la
loro speciale composizione; quando poi nell'ana-
lisi di un'opera si trova una composizione piana
ed una composizione spaziale, significa che quelle
idee di piano, di spazio e di composizione sono
ormai inservibili.
Nonostante le vedute originali, il Riegl non dà
dell'arte bizantina una spiegazione soddisfa-
cente; anzi il sacrificio che egli ne fa pare grande-
mente ingiusto.
Una nuova tesi, meno sistematica ed assoluta,
si presenta con Strzygowski, che, ribattendo al
Wickofi, nell'opera Orient oder Rom ? afferma la
propria posizione nella critica di questo aggrovi-
1 Al Museo reale di Berlino, rappresenta la Madonna in
trono e due angeli ai lati.
a Riegl, op. cit., pag. 132.
gliato periodo. Parte dei suoi argomenti è ri-
volta a mostrare come la narrazione continua-
tiva è meno genericamente adottata di quanto
quegli affermava; la parte maggiore s'imposta su
questo criterio: fare indietreggiare all'Oriente
quello che Wickofi trova di caratteristico in
Roma; rendendo sinonimi Alessandria ed Oriente
Strzygowski ci tiene a presentare lineare, inin-
terrotto il processo storico dell'arte classica al-
l'arte bizantina.
Anzitutto egli non poteva esimersi dal dimo-
strare legittimo lo scambio dell'arte d'Alessandria
con quella dell'Oriente. R quanto all'idea di aver
lumeggiato l'arte bizantina antica legandola
alla corrente classica,1 dopo lo stadio ellenistico,
essa rivela piuttosto nello Strygowski una co-
scienza critica assai meno matura di quella del
Wickoff.
Wickoff comprende che per l'esame stilistico
in fondo le questioni di derivazione storica sono di
secondaria importanza; nota le qualità nuove,
perchè queste possono appunto indicare il carat-
tere artistico; in quanto, per spiegare l'arte ro-
mana, non ne esce, è molto encomiabile, e dove si
mostra debole è appunto dove non avverte che
bisognava di nuovo spezzare il filo.
La storia dei mezzi artistici, della tecnica, delle
apparenze artistiche, si compie stringendo rapporti,
unificando, segnando la linea di sviluppo; ma per
capire una qualsiasi arte, bisogna separare, iso-
lare, rinunciare al generico per scoprire il carat-
teristico. Per questo, contro Strzygowski, ha ra-
gione Wickoff.
Con Strzygowski siamo completamente usciti
dal campo dell'arte; anch'egli avvicina Velasquez,
Hals, Rembrandt e le pitture murali di Pom-
pei e di Roma.2 Ma arriva al colmo dell'incom-
prensione del valore spirituale dello stile, dicendo
che: « K cosa fondamentale, che figurare per mezzo
di luce ed ombra non esce dalle doti nazionali, ma
può prodursi da tutti i popoli ben dotati artisti-
camente, perchè è cosa di tecnica ed una conse-
guenza del suo sviluppo virtuoso ». 3
Successivamente, Strzygowski sviluppò il suo
pensiero accentuando l'importanza dei centri
artistici orientali; ma la sua posizione teorica non
muta.
1 Strzygowski, op. cit. Introduzione; Byzantinis che
Zcitschrift, anno 1892, pag. 62; Die Hy-zaiitiiiìschc1 Kunst.
2 Strzygowski, op. cit., pag. 5.
3 Strzygowski, op. cit., pag. 5: « Hauptsache ist, dass das
Darstellen mit den Mitteln von Licht und Farbe nicht na-
tionaler Begabung entspringt, sondern bei alien ùberhaupt
kunstbegabten Volkern auftreten kann, weil es Sache der
Technick und eine Folge ihrer virtuosen Entwicklung ist »
GIUSTA NICCO
namenti, ma soltanto riferendoci alla sensibilità
del lettore. Per esempio, nel dittico d'avorio che
riproduce e commenta a pag. 121,1 non vede nulla
che non sia anche nell'arte romana tarda: qua e
là, le figure isolate cubicamente dal fondo, la spa-
zialità della figura mostrata mediante la sovrap-
posizione. Questa identità non persuade neppure
per il procedimento tecnico. Parlare di rilievo
cubico per questo pianeggiare largo e calmo di
forme e di oggetti, pare strano. Afa c'è poi qualcosa
di irriducibile all'arte romana; ed è un senso di-
verso di ogni cosa, anche delle soluzioni tecniche
affini, e l'accurata simmetria. Ma questo non si
può ricavare dall'interrogatorio dell'opera se-
condo idee già fatte: consiste nella realtà arti-
stica, diversa dai, « problemi », la quale al Riegl
ormai sfugge.
Del pari si dissolve la bellezza del musaico di
Giustiniano a S. V'itale 2 così sezionato: 0 compo-
sizione piana: centralistica, verticali accentuate,
e anche le orizzontali (linee delle teste, dei piedi);
composizione spaziale: tutte le figure, in posizione
frontale, vengono dallo spazio verso l'osservatore,
e Ut fissano con sguardo diritto; il gruppo princi-
pale è in un piano, nonostante che le figure si
coprano parzialmente, il seguito di cinque corti-
giani, in tre file susseguentisi, stretti insieme in
una compatta massa (piana) cosicché fra tutte le
figure non v'è nessun posticino libero: si nota la
caratteristica apparenza che le figure davanti
camminino sui piedi a quelle dietro, più volte
ripetuta; la prova più chiara che s'è trattato per
l'artista dell'isolamento completo delle singole
figure, a costo del collegamento nel piano (qui a
costo del collegamento dei piedi col corpo)...
Infine, capacità ritrattistica.
Nonostante tutte queste prove, è permesso
dubitare che in questa scena così rigorosamente
piana, si voglia l'isolamento delle figure e non la
loro speciale composizione; quando poi nell'ana-
lisi di un'opera si trova una composizione piana
ed una composizione spaziale, significa che quelle
idee di piano, di spazio e di composizione sono
ormai inservibili.
Nonostante le vedute originali, il Riegl non dà
dell'arte bizantina una spiegazione soddisfa-
cente; anzi il sacrificio che egli ne fa pare grande-
mente ingiusto.
Una nuova tesi, meno sistematica ed assoluta,
si presenta con Strzygowski, che, ribattendo al
Wickofi, nell'opera Orient oder Rom ? afferma la
propria posizione nella critica di questo aggrovi-
1 Al Museo reale di Berlino, rappresenta la Madonna in
trono e due angeli ai lati.
a Riegl, op. cit., pag. 132.
gliato periodo. Parte dei suoi argomenti è ri-
volta a mostrare come la narrazione continua-
tiva è meno genericamente adottata di quanto
quegli affermava; la parte maggiore s'imposta su
questo criterio: fare indietreggiare all'Oriente
quello che Wickofi trova di caratteristico in
Roma; rendendo sinonimi Alessandria ed Oriente
Strzygowski ci tiene a presentare lineare, inin-
terrotto il processo storico dell'arte classica al-
l'arte bizantina.
Anzitutto egli non poteva esimersi dal dimo-
strare legittimo lo scambio dell'arte d'Alessandria
con quella dell'Oriente. R quanto all'idea di aver
lumeggiato l'arte bizantina antica legandola
alla corrente classica,1 dopo lo stadio ellenistico,
essa rivela piuttosto nello Strygowski una co-
scienza critica assai meno matura di quella del
Wickoff.
Wickoff comprende che per l'esame stilistico
in fondo le questioni di derivazione storica sono di
secondaria importanza; nota le qualità nuove,
perchè queste possono appunto indicare il carat-
tere artistico; in quanto, per spiegare l'arte ro-
mana, non ne esce, è molto encomiabile, e dove si
mostra debole è appunto dove non avverte che
bisognava di nuovo spezzare il filo.
La storia dei mezzi artistici, della tecnica, delle
apparenze artistiche, si compie stringendo rapporti,
unificando, segnando la linea di sviluppo; ma per
capire una qualsiasi arte, bisogna separare, iso-
lare, rinunciare al generico per scoprire il carat-
teristico. Per questo, contro Strzygowski, ha ra-
gione Wickoff.
Con Strzygowski siamo completamente usciti
dal campo dell'arte; anch'egli avvicina Velasquez,
Hals, Rembrandt e le pitture murali di Pom-
pei e di Roma.2 Ma arriva al colmo dell'incom-
prensione del valore spirituale dello stile, dicendo
che: « K cosa fondamentale, che figurare per mezzo
di luce ed ombra non esce dalle doti nazionali, ma
può prodursi da tutti i popoli ben dotati artisti-
camente, perchè è cosa di tecnica ed una conse-
guenza del suo sviluppo virtuoso ». 3
Successivamente, Strzygowski sviluppò il suo
pensiero accentuando l'importanza dei centri
artistici orientali; ma la sua posizione teorica non
muta.
1 Strzygowski, op. cit. Introduzione; Byzantinis che
Zcitschrift, anno 1892, pag. 62; Die Hy-zaiitiiiìschc1 Kunst.
2 Strzygowski, op. cit., pag. 5.
3 Strzygowski, op. cit., pag. 5: « Hauptsache ist, dass das
Darstellen mit den Mitteln von Licht und Farbe nicht na-
tionaler Begabung entspringt, sondern bei alien ùberhaupt
kunstbegabten Volkern auftreten kann, weil es Sache der
Technick und eine Folge ihrer virtuosen Entwicklung ist »