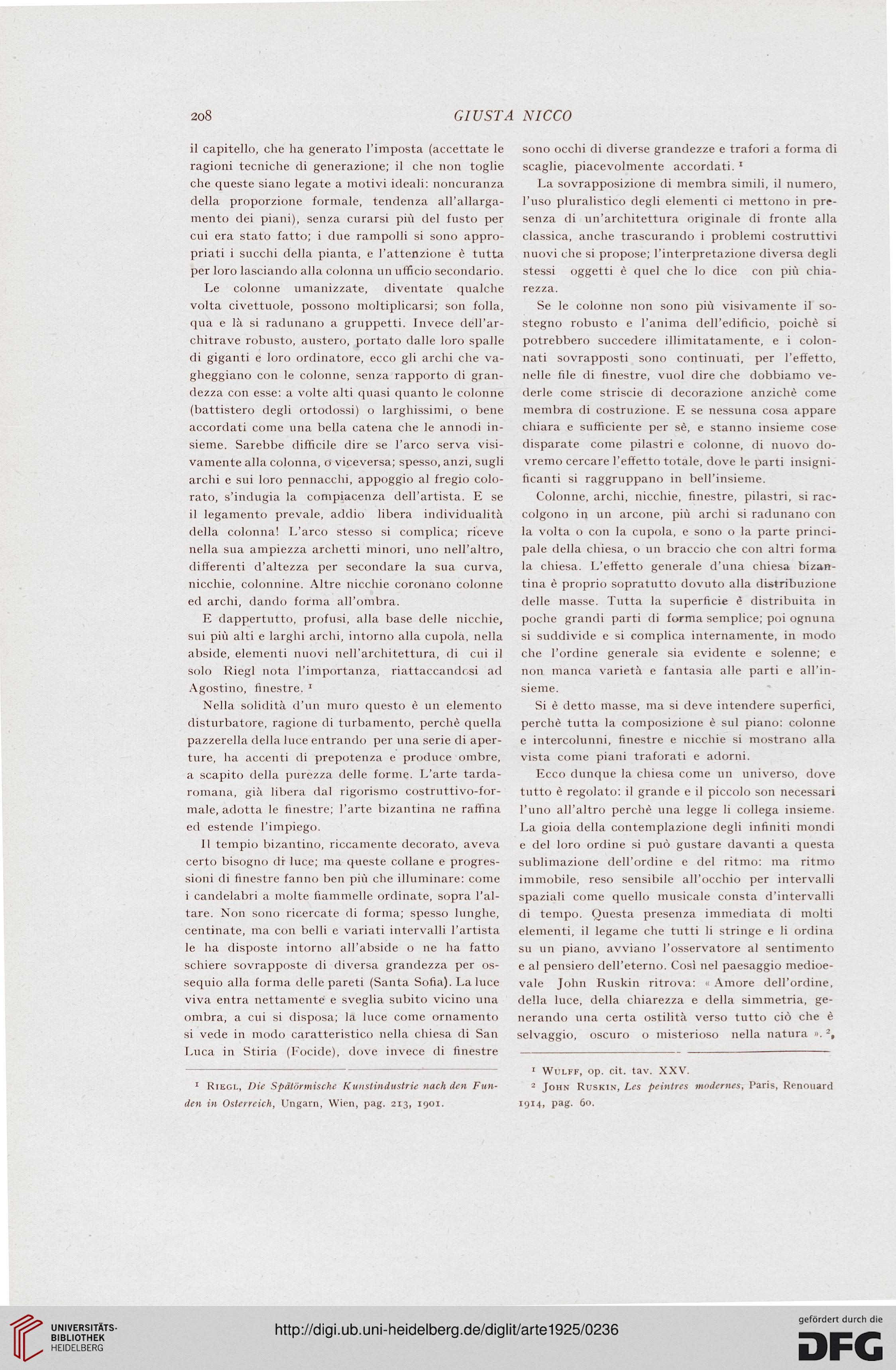208
GIUSTA NICCO
il capitello, che ha generato l'imposta (accettate le
ragioni tecniche di generazione; il che non toglie
che queste siano legate a motivi ideali: noncuranza
della proporzione formale, tendenza all'allarga-
mento dei piani), senza curarsi più del fusto per
cui era stato fatto; i due rampolli si sono appro-
priati i succhi della pianta, e l'attenzione è tutta
per loro lasciando alla colonna un ufficio secondario.
Le colonne umanizzate, diventate qualche
volta civettuole, possono moltiplicarsi; son folla,
qua e là si radunano a gruppetti. Invece dell'ar-
chitrave robusto, austero, portato dalle loro spalle
di giganti e loro ordinatore, ecco gli archi che va-
gheggiano con le colonne, senza rapporto di 1^1 nu-
dezza con esse: a volte alti quasi quanto le colonne
(battistero degli ortodossi) o larghissimi, o bene
accordati come una bella catena che le annodi in-
sieme. Sarebbe diffìcile dire se l'arco serva visi-
vamente alla colonna, a viceversa; spesso, anzi, sugli
archi e sui loro pennacchi, appoggio al fregio colo-
rato, s'indugia la compiacenza dell'artista. E se
il legamento prevale, addio libera individualità
della colonna! L'arco stesso si complica; riceve
nella sua ampiezza archetti minori, uno nell'altro,
differenti d'altezza per secondare la sua curva,
nicchie, colonnine. Altre nicchie coronano colonne
ed archi, dando forma all'ombra.
E dappertutto, profusi, alla base delle nicchie,
sui più alti e larghi archi, intorno alla cupola, nella
abside, elementi nuovi nell'architettura, di cui il
solo Kiegl nota l'importanza, riattaccandosi ad
Agostino, finestre. 1
Nella solidità d'un muro questo è un elemento
disturbatore, ragione di turbamento, perchè quella
pazzerella della luce entrando per una serie di aper-
ture, ha accenti di prepotenza e produce ombre,
a scapito della purezza delle forme. L'arte tarda-
romana, già libera dal rigorismo costruttivo-for-
male, adotta le finestre; l'arte bizantina ne raffina
ed estende l'impiego.
11 tempio bizantino, riccamente decorato, aveva
certo bisogno di luce; ma queste collane e progres-
sioni di finestre fanno ben più che illuminare: come
i candelabri a molte fiammelle ordinate, sopra l'al-
tare. Non sono ricercate di forma; spesso lunghe,
centinate, ma con belli e variati intervalli l'artista
le ha disposte intorno all'abside o ne ha fatto
schiere sovrapposte di diversa grandezza per os-
sequio alla forma delle pareti (Santa Sofia). La luce
viva entra nettamente e sveglia subito vicino una
ombra, a cui si disposa; la luce come ornamento
si vede in modo caratteristico nella chiesa di San
Luca in Stiria (Focide), dove invece di finestre
1 RlEGL, Die Spàtiirmische Kunstindustrie nach den Fun-
den in Osterreich, Ungarn, Wien, pag. 213, 1901.
sono occhi di diverse grandezze e trafori a forma di
scaglie, piacevolmente accordati. 1
La sovrapposizione di membra simili, il numero,
l'uso pluralistico degli elementi ci mettono in pre-
senza di un'architettura originale di fronte alla
classica, anche trascurando i problemi costruttivi
nuovi che si propose; l'interpretazione diversa degli
stessi oggetti è quel che lo dice con più chia-
rezza.
Se le colonne non sono più visivamente il so-
stegno robusto e l'anima dell'edificio, poiché si
potrebbero succedere illimitatamente, e i colon-
nati sovrapposti sono continuati, per l'effetto,
nelle file di finestre, vuol dire che dobbiamo ve-
derle come striscie di decorazione anziché come
membra di costruzione. E se nessuna cosa appare
chiara e sufficiente per sé, e stanno insieme cose
disparate come pilastri e colonne, di nuovo do-
vremo cercare l'effetto totale, dove le parti insigni-
ficanti si raggruppano in bell'insieme.
Colonne, archi, nicchie, finestre, pilastri, si rac-
colgono in un arcone, più archi si radunano con
la volta o con la cupola, e sono o la parte princi-
pale della chiesa, o un braccio che con altri forma
la chiesa. L'effetto generale d'una chiesa bizan-
tina è proprio sopratutto dovuto alla distribuzione
delle masse. Tutta la superficie è distribuita in
poche grandi parti di forma semplice; poi ognuna
si suddivide e si complica internamente, in modo
che l'ordine generale sia evidente e solenne; e
non manca varietà e fantasia alle parti e all'in-
sieme.
Si è detto masse, ma si deve intendere superfici,
perchè tutta la composizione è sul piano: colonne
e intercolunni, finestre e nicchie si mostrano alla
vista come piani traforati e adorni.
Ecco dunque la chiesa come un universo, dove
tutto è regolato: il grande e il piccolo son necessari
l'uno all'altro perchè una legge li collega insieme.
La gioia della contemplazione degli infiniti mondi
e del loro ordine si può gustare davanti a questa
sublimazione dell'ordine e del ritmo: ma ritmo
immobile, reso sensibile all'occhio per intervalli
spaziali come quello musicale consta d'intervalli
di tempo. Questa presenza immediata di molti
elementi, il legame che tutti li stringe e li ordina
su un piano, avviano l'osservatore al sentimento
e al pensiero dell'eterno. Così nel paesaggio medioe-
vale John Ruskin ritrova: « Amore dell'ordine,
della luce, della chiarezza e della simmetria, ge-
nerando una certa ostilità verso tutto ciò che è
selvaggio, oscuro o misterioso nella natura ». -,
1 Wulff, op. cit. tav. XXV.
2 John Ruskin, Les peintres modemes, Paris, Renouard
1914, pag. 60.
GIUSTA NICCO
il capitello, che ha generato l'imposta (accettate le
ragioni tecniche di generazione; il che non toglie
che queste siano legate a motivi ideali: noncuranza
della proporzione formale, tendenza all'allarga-
mento dei piani), senza curarsi più del fusto per
cui era stato fatto; i due rampolli si sono appro-
priati i succhi della pianta, e l'attenzione è tutta
per loro lasciando alla colonna un ufficio secondario.
Le colonne umanizzate, diventate qualche
volta civettuole, possono moltiplicarsi; son folla,
qua e là si radunano a gruppetti. Invece dell'ar-
chitrave robusto, austero, portato dalle loro spalle
di giganti e loro ordinatore, ecco gli archi che va-
gheggiano con le colonne, senza rapporto di 1^1 nu-
dezza con esse: a volte alti quasi quanto le colonne
(battistero degli ortodossi) o larghissimi, o bene
accordati come una bella catena che le annodi in-
sieme. Sarebbe diffìcile dire se l'arco serva visi-
vamente alla colonna, a viceversa; spesso, anzi, sugli
archi e sui loro pennacchi, appoggio al fregio colo-
rato, s'indugia la compiacenza dell'artista. E se
il legamento prevale, addio libera individualità
della colonna! L'arco stesso si complica; riceve
nella sua ampiezza archetti minori, uno nell'altro,
differenti d'altezza per secondare la sua curva,
nicchie, colonnine. Altre nicchie coronano colonne
ed archi, dando forma all'ombra.
E dappertutto, profusi, alla base delle nicchie,
sui più alti e larghi archi, intorno alla cupola, nella
abside, elementi nuovi nell'architettura, di cui il
solo Kiegl nota l'importanza, riattaccandosi ad
Agostino, finestre. 1
Nella solidità d'un muro questo è un elemento
disturbatore, ragione di turbamento, perchè quella
pazzerella della luce entrando per una serie di aper-
ture, ha accenti di prepotenza e produce ombre,
a scapito della purezza delle forme. L'arte tarda-
romana, già libera dal rigorismo costruttivo-for-
male, adotta le finestre; l'arte bizantina ne raffina
ed estende l'impiego.
11 tempio bizantino, riccamente decorato, aveva
certo bisogno di luce; ma queste collane e progres-
sioni di finestre fanno ben più che illuminare: come
i candelabri a molte fiammelle ordinate, sopra l'al-
tare. Non sono ricercate di forma; spesso lunghe,
centinate, ma con belli e variati intervalli l'artista
le ha disposte intorno all'abside o ne ha fatto
schiere sovrapposte di diversa grandezza per os-
sequio alla forma delle pareti (Santa Sofia). La luce
viva entra nettamente e sveglia subito vicino una
ombra, a cui si disposa; la luce come ornamento
si vede in modo caratteristico nella chiesa di San
Luca in Stiria (Focide), dove invece di finestre
1 RlEGL, Die Spàtiirmische Kunstindustrie nach den Fun-
den in Osterreich, Ungarn, Wien, pag. 213, 1901.
sono occhi di diverse grandezze e trafori a forma di
scaglie, piacevolmente accordati. 1
La sovrapposizione di membra simili, il numero,
l'uso pluralistico degli elementi ci mettono in pre-
senza di un'architettura originale di fronte alla
classica, anche trascurando i problemi costruttivi
nuovi che si propose; l'interpretazione diversa degli
stessi oggetti è quel che lo dice con più chia-
rezza.
Se le colonne non sono più visivamente il so-
stegno robusto e l'anima dell'edificio, poiché si
potrebbero succedere illimitatamente, e i colon-
nati sovrapposti sono continuati, per l'effetto,
nelle file di finestre, vuol dire che dobbiamo ve-
derle come striscie di decorazione anziché come
membra di costruzione. E se nessuna cosa appare
chiara e sufficiente per sé, e stanno insieme cose
disparate come pilastri e colonne, di nuovo do-
vremo cercare l'effetto totale, dove le parti insigni-
ficanti si raggruppano in bell'insieme.
Colonne, archi, nicchie, finestre, pilastri, si rac-
colgono in un arcone, più archi si radunano con
la volta o con la cupola, e sono o la parte princi-
pale della chiesa, o un braccio che con altri forma
la chiesa. L'effetto generale d'una chiesa bizan-
tina è proprio sopratutto dovuto alla distribuzione
delle masse. Tutta la superficie è distribuita in
poche grandi parti di forma semplice; poi ognuna
si suddivide e si complica internamente, in modo
che l'ordine generale sia evidente e solenne; e
non manca varietà e fantasia alle parti e all'in-
sieme.
Si è detto masse, ma si deve intendere superfici,
perchè tutta la composizione è sul piano: colonne
e intercolunni, finestre e nicchie si mostrano alla
vista come piani traforati e adorni.
Ecco dunque la chiesa come un universo, dove
tutto è regolato: il grande e il piccolo son necessari
l'uno all'altro perchè una legge li collega insieme.
La gioia della contemplazione degli infiniti mondi
e del loro ordine si può gustare davanti a questa
sublimazione dell'ordine e del ritmo: ma ritmo
immobile, reso sensibile all'occhio per intervalli
spaziali come quello musicale consta d'intervalli
di tempo. Questa presenza immediata di molti
elementi, il legame che tutti li stringe e li ordina
su un piano, avviano l'osservatore al sentimento
e al pensiero dell'eterno. Così nel paesaggio medioe-
vale John Ruskin ritrova: « Amore dell'ordine,
della luce, della chiarezza e della simmetria, ge-
nerando una certa ostilità verso tutto ciò che è
selvaggio, oscuro o misterioso nella natura ». -,
1 Wulff, op. cit. tav. XXV.
2 John Ruskin, Les peintres modemes, Paris, Renouard
1914, pag. 60.