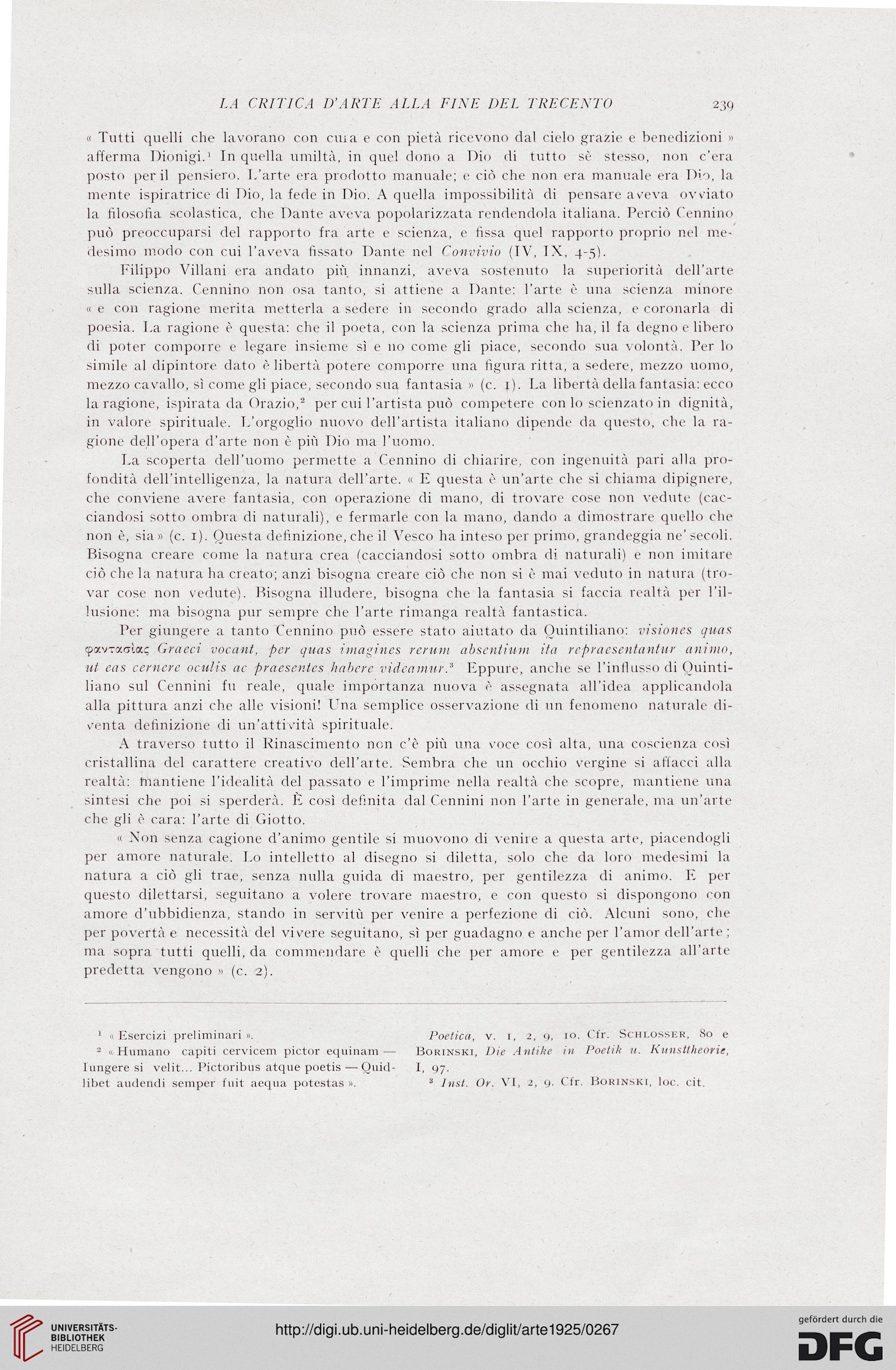LA CRITICA D'ARTE ALLA FINE DEL TRECENTO
239
« Tutti quelli che lavorano con Cina e con pietà ricevono dal cielo grazie e benedizioni »
afferma Dionigi.1 In quella umiltà, in quel dono a Dio di tutto sè stesso, non c'era
posto perii pensiero. L'arte era prodotto manuale; e ciò che non era manuale era Dio, la
mente ispiratrice di Dio, la fede in Dio. A quella impossibilità di pensare aveva ovviato
la filosofìa scolastica, che Dante aveva popolarizzata rendendola italiana. Perciò Cennino
può preoccuparsi del rapporto fra arte e scienza, e fissa quel rapporto proprio nel me-
desimo modo con cui l'aveva fissato Dante nel Convivio (TV, IX, 4-5).
Filippo Villani era andato più innanzi, aveva sostenuto la superiorità dell'arte
sulla scienza. Cennino non osa tanto, si attiene a Dante: l'arte è una scienza minore
« e con ragione merita metterla a sedere in secondo grado alla scienza, e coronarla di
poesia. La ragione è questa: che il poeta, con la scienza prima che ha, il fa degno e libero
di poter comporre e legare insieme sì e no come gli piace, secondo sua volontà. Per lo
simile al dipintore dato è libertà potere comporre una figura ritta, a sedere, mezzo uomo,
mezzo ca vallo, sì come gli piace, secondo sua fantasia » (c. j). La libertà della fantasia: ecco
la ragione, ispirata da Orazio,2 per cui l'artista può competere con lo scienzato in dignità,
in valore spirituale. L'orgoglio nuovo dell'artista italiano dipende da questo, (die la ra-
gione dell'opera d'arte non è più Dio ma l'uomo.
La scoperta dell'uomo permette a Cennino di chiarire, con ingenuità pari alla pro-
fondità dell'intelligenza, la natura dell'arte. « E questa è un'arte che si chiama dipignere,
che conviene avere fantasia, con operazione di mano, di trovare cose non vedute (cac-
ciandosi sotto ombra di naturali), e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che
non è, sia » (c. 1). Questa definizione, che il Vesco ha inteso per primo, grandeggia ne' secoli.
Bisogna creare come la natura crea (cacciandosi sotto ombra di naturali) e non imitare
ciò che la natura ha creato; anzi bisogna creare ciò che non si è mai veduto in natura (tro-
var cose non vedute). Bisogna illudere, bisogna che la fantasia si faccia realtà per l'il-
lusione: ma bisogna pur sempre che l'arte rimanga realtà fantastica.
Per giungere a tanto Cennino può essere stato aiutato da Quintiliano: visioncs quax
cpavTaala? Graeci vocant, per quas imagincs rerum abscntinm ita repraesentantur animo,
ut eas cernere oculis ae praesentes habere videamur.' Eppure, anche se l'influsso di Quinti-
liano sul Cennini fu reale, quale importanza nuova è assegnata all'idea applicandola
alla pittura anzi die alle visioni! Una semplice osservazione di un fenomeno naturale di-
venta definizione di un'attività spirituale.
A traverso tutto il Rinascimento non c'è più una voce così alta, una coscienza così
cristallina del carattere creativo dell'arte. Sembra che un occhio vergine si affacci alla
realtà: mantiene l'idealità del passato e l'imprime nella realtà che scopre, mantiene una
sintesi che poi si sperderà. È così definita dal Cennini non l'arte in generale, ma un'arte
che gli è cara: l'arte di Ciotto.
" Noli senza cagione d'animo gentile si muovono di venire a questa arte, piacendogli
per amore naturale. Lo intelletto al disegno si diletta, solo che da loro medesimi la
natura a ciò gli trae, senza nulla guida di maestro, per gentilezza di animo. E per
questo dilettarsi, seguitano a volere trovare maestro, e con questo si dispongono con
amore d'ubbidienza, stando in servitù per venire a perfezione di ciò. Alcuni sono, che
per povertà e necessità del vivere seguitano, sì per guadagno e anche per l'amor dell'arte ;
ma sopra tutti quelli, da commendare è quelli che per amore e per gentilezza all'arte
predetta vengono » (c. 2).
1 «Esercizi preliminari». Poetica, v. 1, 2, 9, IO. Cfr. Schlosser, 80 e
2 ■ Hiiraano capiti cervicem pictor equinam— Borinski, Die Antike in l'oe/i/i n. Kunsttheórie,
Iungeresi velit... Pictoribus atque poetis—Quid- I, 97.
litici audendi semper fuit acqua potestas ». 3 Just. Or. X1, 2, Cfr. BORINSKI, lue. cit.
239
« Tutti quelli che lavorano con Cina e con pietà ricevono dal cielo grazie e benedizioni »
afferma Dionigi.1 In quella umiltà, in quel dono a Dio di tutto sè stesso, non c'era
posto perii pensiero. L'arte era prodotto manuale; e ciò che non era manuale era Dio, la
mente ispiratrice di Dio, la fede in Dio. A quella impossibilità di pensare aveva ovviato
la filosofìa scolastica, che Dante aveva popolarizzata rendendola italiana. Perciò Cennino
può preoccuparsi del rapporto fra arte e scienza, e fissa quel rapporto proprio nel me-
desimo modo con cui l'aveva fissato Dante nel Convivio (TV, IX, 4-5).
Filippo Villani era andato più innanzi, aveva sostenuto la superiorità dell'arte
sulla scienza. Cennino non osa tanto, si attiene a Dante: l'arte è una scienza minore
« e con ragione merita metterla a sedere in secondo grado alla scienza, e coronarla di
poesia. La ragione è questa: che il poeta, con la scienza prima che ha, il fa degno e libero
di poter comporre e legare insieme sì e no come gli piace, secondo sua volontà. Per lo
simile al dipintore dato è libertà potere comporre una figura ritta, a sedere, mezzo uomo,
mezzo ca vallo, sì come gli piace, secondo sua fantasia » (c. j). La libertà della fantasia: ecco
la ragione, ispirata da Orazio,2 per cui l'artista può competere con lo scienzato in dignità,
in valore spirituale. L'orgoglio nuovo dell'artista italiano dipende da questo, (die la ra-
gione dell'opera d'arte non è più Dio ma l'uomo.
La scoperta dell'uomo permette a Cennino di chiarire, con ingenuità pari alla pro-
fondità dell'intelligenza, la natura dell'arte. « E questa è un'arte che si chiama dipignere,
che conviene avere fantasia, con operazione di mano, di trovare cose non vedute (cac-
ciandosi sotto ombra di naturali), e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che
non è, sia » (c. 1). Questa definizione, che il Vesco ha inteso per primo, grandeggia ne' secoli.
Bisogna creare come la natura crea (cacciandosi sotto ombra di naturali) e non imitare
ciò che la natura ha creato; anzi bisogna creare ciò che non si è mai veduto in natura (tro-
var cose non vedute). Bisogna illudere, bisogna che la fantasia si faccia realtà per l'il-
lusione: ma bisogna pur sempre che l'arte rimanga realtà fantastica.
Per giungere a tanto Cennino può essere stato aiutato da Quintiliano: visioncs quax
cpavTaala? Graeci vocant, per quas imagincs rerum abscntinm ita repraesentantur animo,
ut eas cernere oculis ae praesentes habere videamur.' Eppure, anche se l'influsso di Quinti-
liano sul Cennini fu reale, quale importanza nuova è assegnata all'idea applicandola
alla pittura anzi die alle visioni! Una semplice osservazione di un fenomeno naturale di-
venta definizione di un'attività spirituale.
A traverso tutto il Rinascimento non c'è più una voce così alta, una coscienza così
cristallina del carattere creativo dell'arte. Sembra che un occhio vergine si affacci alla
realtà: mantiene l'idealità del passato e l'imprime nella realtà che scopre, mantiene una
sintesi che poi si sperderà. È così definita dal Cennini non l'arte in generale, ma un'arte
che gli è cara: l'arte di Ciotto.
" Noli senza cagione d'animo gentile si muovono di venire a questa arte, piacendogli
per amore naturale. Lo intelletto al disegno si diletta, solo che da loro medesimi la
natura a ciò gli trae, senza nulla guida di maestro, per gentilezza di animo. E per
questo dilettarsi, seguitano a volere trovare maestro, e con questo si dispongono con
amore d'ubbidienza, stando in servitù per venire a perfezione di ciò. Alcuni sono, che
per povertà e necessità del vivere seguitano, sì per guadagno e anche per l'amor dell'arte ;
ma sopra tutti quelli, da commendare è quelli che per amore e per gentilezza all'arte
predetta vengono » (c. 2).
1 «Esercizi preliminari». Poetica, v. 1, 2, 9, IO. Cfr. Schlosser, 80 e
2 ■ Hiiraano capiti cervicem pictor equinam— Borinski, Die Antike in l'oe/i/i n. Kunsttheórie,
Iungeresi velit... Pictoribus atque poetis—Quid- I, 97.
litici audendi semper fuit acqua potestas ». 3 Just. Or. X1, 2, Cfr. BORINSKI, lue. cit.