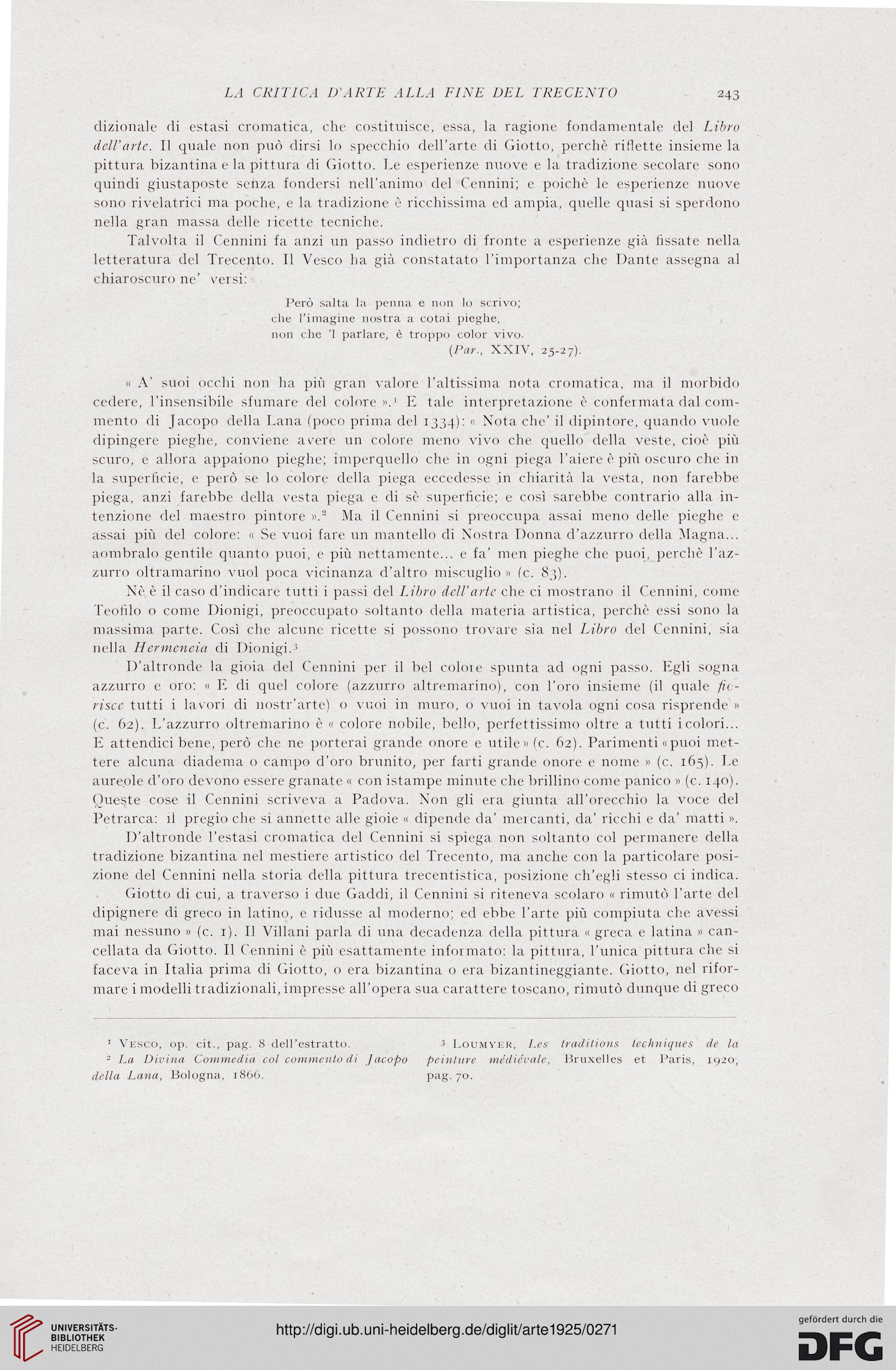LA CRII ICA D'ARTE ALLA FINE DEL TRECENTO
243
dizionale di estasi cromatica, che costituisce, essa, la ragione fondamentale del Libro
dell'arte. Il quale non può dirsi lo specchio dell'arte di Giotto, perchè riflette insieme la
pittura bizantina e la pittura di (dotto. Le esperienze nuove e la tradizione secolare sono
quindi giustaposte senza fondersi nell'animo del Cennini; e poiché le esperienze nuove
sono rivelatrici ma poche, e la tradizione è ricchissima ed ampia, quelle quasi si sperdono
nella gran massa delle ricette tecniche.
Talvolta il Cennini fa anzi un passo indietro di fronte a esperienze già fissate nella
letteratura del Trecento. Il Vesco ha già constatato l'importanza che Dante assegna al
chiaroscuro ne' versi:
Però salta la penna e non lo scrivo;
che l'imagine nostra a cotai pieghe,
non che '1 parlare, è troppo color vivo.
{Par., XXIV, 25-27).
« A' suoi occhi non ha più gran valore l'altissima nota cromatica, ma il morbido
cedere, l'insensibile sfumare del colore».' E tale interpretazione è confermata dal com-
mento di Jacopo della Lana (poco prima del [334): <■ Xota che' il dipintore, quando vuole
dipingere pieghe, conviene avere un colore meno vivo che quello della veste, cioè più
scuro, e allora appaiono pieghe; imperquello che in ogni piega l'aiere è più oscuro che in
la superficie, e però se lo colore della piega eccedesse in chiarità la vesta, non farebbe
piega, anzi farebbe della vesta piega e di sè superficie; e così sarebbe contrario alla in-
tenzione del maestro pintore Ma il Cennini si preoccupa assai meno delle pieghe e
assai più del colore: « Se vuoi fare un mantello di Nostra Donna d'azzurro della Magna...
aombralo gentile quanto puoi, e più nettamente... e fa' men pieghe che puoi, perchè l'az-
zurro oltramarino vuol poca vicinanza d'altro miscuglio» (c. 8;).
Nò è il caso d'indicare tutti i passi del Libro dell'arte che ci mostrano il Cennini, come
Teofìlo o come Dionigi, preoccupato soltanto della materia artistica, perchè essi sono la
massima parte. Così che alcune ricette si possono trovare sia nel Libro del Cennini, sia
nella H'ermencia di Dionigi.5
D'altronde la gioia del Cennini per il bel colore spunta ad ogni passo. Egli sogna
azzurro e oro: « E di quel colore (azzurro altremarino), con l'oro insieme (il quale fio-
risce tutti i lavori di nostr'arte) 0 vuoi in muro, ò vuoi in tavola ogni cosa risprende »
(c. 62). L'azzurro oltremarino è « colore nobile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori...
E attendici bene, però che ne porterai grande onore e utile» (c. 62). Parimenti « puoi met-
tere alcuna diadema o campo d'oro brunito, per farti grande onore e nome » (c. 165). Le
aureole d'oro devono essere granate « con istampe minute che brillino come panico » (c. 140).
Chieste cose il Cennini scriveva a Padova. Non gli era giunta all'orecchio la voce del
Petrarca: li pregio che si annetti- alle gioie « dipende da' mercanti, da' ricchi e da' matti».
D'altronde l'estasi cromatica del Cennini si spiega non soltanto col permanere della
tradizione bizantina nel mestiere artistico del Trecento, ma anche con la particolare posi-
zione del Cennini nella storia della pittura trecentistica, posizione ch'egli stesso ci indica.
Giotto di cui, a traverso i due Gaddi, il Cennini si riteneva scolaro « rimutò l'arte del
dipignere di greco in latino, e ridusse al moderno; ed ebbe l'arte più compiuta che avessi
mai nessuno » (c. 1). Il Villani parla di una decadenza della pittura « greca e latina » can-
cellata da (dotto. Il Cennini è più esattamente informato: la pittura, l'unica pittura che si
faceva in Italia prima di Giotto, o era bizantina 0 era bizantineggiante. Giotto, nel rifor-
mare i modelli tradizionali, impresse all'opera sua carattere toscano, rimutò dunque di greco
1 VéSCO, op. cit., pag. 8 dell'estratto.
2 La Divina Commedia col commento di Jacopo
della Lana, Bologna, [866.
3 LOUMYER, Les traditions techniques de la
peinlure medievale, Bruxelles et Paris, 1920,
pag. 70.
243
dizionale di estasi cromatica, che costituisce, essa, la ragione fondamentale del Libro
dell'arte. Il quale non può dirsi lo specchio dell'arte di Giotto, perchè riflette insieme la
pittura bizantina e la pittura di (dotto. Le esperienze nuove e la tradizione secolare sono
quindi giustaposte senza fondersi nell'animo del Cennini; e poiché le esperienze nuove
sono rivelatrici ma poche, e la tradizione è ricchissima ed ampia, quelle quasi si sperdono
nella gran massa delle ricette tecniche.
Talvolta il Cennini fa anzi un passo indietro di fronte a esperienze già fissate nella
letteratura del Trecento. Il Vesco ha già constatato l'importanza che Dante assegna al
chiaroscuro ne' versi:
Però salta la penna e non lo scrivo;
che l'imagine nostra a cotai pieghe,
non che '1 parlare, è troppo color vivo.
{Par., XXIV, 25-27).
« A' suoi occhi non ha più gran valore l'altissima nota cromatica, ma il morbido
cedere, l'insensibile sfumare del colore».' E tale interpretazione è confermata dal com-
mento di Jacopo della Lana (poco prima del [334): <■ Xota che' il dipintore, quando vuole
dipingere pieghe, conviene avere un colore meno vivo che quello della veste, cioè più
scuro, e allora appaiono pieghe; imperquello che in ogni piega l'aiere è più oscuro che in
la superficie, e però se lo colore della piega eccedesse in chiarità la vesta, non farebbe
piega, anzi farebbe della vesta piega e di sè superficie; e così sarebbe contrario alla in-
tenzione del maestro pintore Ma il Cennini si preoccupa assai meno delle pieghe e
assai più del colore: « Se vuoi fare un mantello di Nostra Donna d'azzurro della Magna...
aombralo gentile quanto puoi, e più nettamente... e fa' men pieghe che puoi, perchè l'az-
zurro oltramarino vuol poca vicinanza d'altro miscuglio» (c. 8;).
Nò è il caso d'indicare tutti i passi del Libro dell'arte che ci mostrano il Cennini, come
Teofìlo o come Dionigi, preoccupato soltanto della materia artistica, perchè essi sono la
massima parte. Così che alcune ricette si possono trovare sia nel Libro del Cennini, sia
nella H'ermencia di Dionigi.5
D'altronde la gioia del Cennini per il bel colore spunta ad ogni passo. Egli sogna
azzurro e oro: « E di quel colore (azzurro altremarino), con l'oro insieme (il quale fio-
risce tutti i lavori di nostr'arte) 0 vuoi in muro, ò vuoi in tavola ogni cosa risprende »
(c. 62). L'azzurro oltremarino è « colore nobile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori...
E attendici bene, però che ne porterai grande onore e utile» (c. 62). Parimenti « puoi met-
tere alcuna diadema o campo d'oro brunito, per farti grande onore e nome » (c. 165). Le
aureole d'oro devono essere granate « con istampe minute che brillino come panico » (c. 140).
Chieste cose il Cennini scriveva a Padova. Non gli era giunta all'orecchio la voce del
Petrarca: li pregio che si annetti- alle gioie « dipende da' mercanti, da' ricchi e da' matti».
D'altronde l'estasi cromatica del Cennini si spiega non soltanto col permanere della
tradizione bizantina nel mestiere artistico del Trecento, ma anche con la particolare posi-
zione del Cennini nella storia della pittura trecentistica, posizione ch'egli stesso ci indica.
Giotto di cui, a traverso i due Gaddi, il Cennini si riteneva scolaro « rimutò l'arte del
dipignere di greco in latino, e ridusse al moderno; ed ebbe l'arte più compiuta che avessi
mai nessuno » (c. 1). Il Villani parla di una decadenza della pittura « greca e latina » can-
cellata da (dotto. Il Cennini è più esattamente informato: la pittura, l'unica pittura che si
faceva in Italia prima di Giotto, o era bizantina 0 era bizantineggiante. Giotto, nel rifor-
mare i modelli tradizionali, impresse all'opera sua carattere toscano, rimutò dunque di greco
1 VéSCO, op. cit., pag. 8 dell'estratto.
2 La Divina Commedia col commento di Jacopo
della Lana, Bologna, [866.
3 LOUMYER, Les traditions techniques de la
peinlure medievale, Bruxelles et Paris, 1920,
pag. 70.