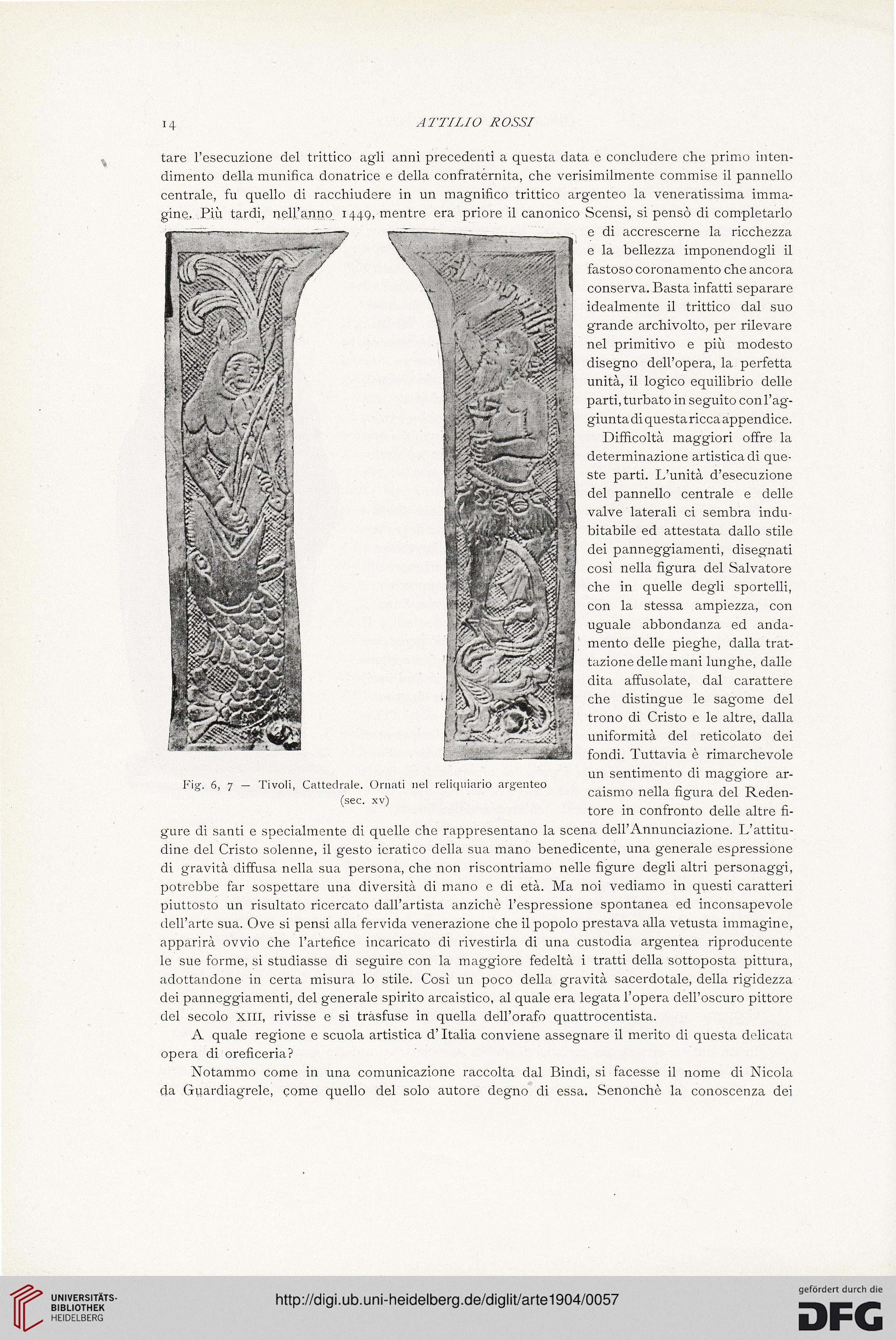14
ATTILIO ROSSI
tare l’esecuzione del trittico agli anni precedenti a questa data e concludere che primo inten-
dimento della munifica donatrice e della confratèrnita, che verisimilmente commise il pannello
centrale, fu quello di racchiudere in un magnifico trittico argenteo la veneratissima imma-
Scensi, si pensò di completarlo
e di accrescerne la ricchezza
e la bellezza imponendogli il
fastoso coronamento che ancora
conserva. Basta infatti separare
idealmente il trittico dal suo
grande archivolto, per rilevare
nel primitivo e più modesto
disegno dell’opera, la perfetta
unità, il logico equilibrio delle
parti, turbato in seguito con rag-
giunta di questa ricca appendice.
Difficoltà maggiori offre la
determinazione artistica di que-
ste parti. L’unità d’esecuzione
del pannello centrale e delle
valve laterali ci sembra indu-
bitabile ed attestata dallo stile
dei panneggiamenti, disegnati
cosi nella figura del Salvatore
che in quelle degli sportelli,
con la stessa ampiezza, con
uguale abbondanza ed anda-
mento delle pieghe, dalla trat-
tazione delle mani lunghe, dalle
dita affusolate, dal carattere
che distingue le sagome del
trono di Cristo e le altre, dalla
uniformità del reticolato dei
fondi. Tuttavia è rimarchevole
un sentimento di maggiore ar-
caismo nella figura del Reden-
tore in confronto delle altre fi-
gure di santi e specialmente di quelle che rappresentano la scena dell’Annunciazione. L’attitu-
dine del Cristo solenne, il gesto ieratico della sua mano benedicente, una generale espressione
di gravità diffusa nella sua persona, che non riscontriamo nelle figure degli altri personaggi,
potrebbe far sospettare una diversità di mano e di età. Ma noi vediamo in questi caratteri
piuttosto un risultato ricercato dall’artista anziché l’espressione spontanea ed inconsapevole
dell’arte sua. Ove si pensi alla fervida venerazione che il popolo prestava alla vetusta immagine,
apparirà ovvio che l’artefice incaricato di rivestirla di una custodia argentea riproducente
le sue forme, si studiasse di seguire con la maggiore fedeltà i tratti della sottoposta pittura,
adottandone in certa misura lo stile. Così un poco della gravità sacerdotale, della rigidezza
dei panneggiamenti, del generale spirito arcaistico, al quale era legata l’opera dell’oscuro pittore
del secolo xiii, rivisse e si trasfuse in quella dell’orafo quattrocentista.
A quale regione e scuola artistica d’Italia conviene assegnare il merito di questa delicata
opera di oreficeria?
Notammo come in una comunicazione raccolta dal Bindi, si facesse il nome di Nicola
da Guardiagrele, come quello del solo autore degno di essa, Senonchè la conoscenza dei
pine. Più tardi, nell’anno 1449, mentre era priore il canonico
Fig. 6, 7 — Tivoli, Cattedrale. Ornati nel reliquiario argenteo
(sec. xv)
ATTILIO ROSSI
tare l’esecuzione del trittico agli anni precedenti a questa data e concludere che primo inten-
dimento della munifica donatrice e della confratèrnita, che verisimilmente commise il pannello
centrale, fu quello di racchiudere in un magnifico trittico argenteo la veneratissima imma-
Scensi, si pensò di completarlo
e di accrescerne la ricchezza
e la bellezza imponendogli il
fastoso coronamento che ancora
conserva. Basta infatti separare
idealmente il trittico dal suo
grande archivolto, per rilevare
nel primitivo e più modesto
disegno dell’opera, la perfetta
unità, il logico equilibrio delle
parti, turbato in seguito con rag-
giunta di questa ricca appendice.
Difficoltà maggiori offre la
determinazione artistica di que-
ste parti. L’unità d’esecuzione
del pannello centrale e delle
valve laterali ci sembra indu-
bitabile ed attestata dallo stile
dei panneggiamenti, disegnati
cosi nella figura del Salvatore
che in quelle degli sportelli,
con la stessa ampiezza, con
uguale abbondanza ed anda-
mento delle pieghe, dalla trat-
tazione delle mani lunghe, dalle
dita affusolate, dal carattere
che distingue le sagome del
trono di Cristo e le altre, dalla
uniformità del reticolato dei
fondi. Tuttavia è rimarchevole
un sentimento di maggiore ar-
caismo nella figura del Reden-
tore in confronto delle altre fi-
gure di santi e specialmente di quelle che rappresentano la scena dell’Annunciazione. L’attitu-
dine del Cristo solenne, il gesto ieratico della sua mano benedicente, una generale espressione
di gravità diffusa nella sua persona, che non riscontriamo nelle figure degli altri personaggi,
potrebbe far sospettare una diversità di mano e di età. Ma noi vediamo in questi caratteri
piuttosto un risultato ricercato dall’artista anziché l’espressione spontanea ed inconsapevole
dell’arte sua. Ove si pensi alla fervida venerazione che il popolo prestava alla vetusta immagine,
apparirà ovvio che l’artefice incaricato di rivestirla di una custodia argentea riproducente
le sue forme, si studiasse di seguire con la maggiore fedeltà i tratti della sottoposta pittura,
adottandone in certa misura lo stile. Così un poco della gravità sacerdotale, della rigidezza
dei panneggiamenti, del generale spirito arcaistico, al quale era legata l’opera dell’oscuro pittore
del secolo xiii, rivisse e si trasfuse in quella dell’orafo quattrocentista.
A quale regione e scuola artistica d’Italia conviene assegnare il merito di questa delicata
opera di oreficeria?
Notammo come in una comunicazione raccolta dal Bindi, si facesse il nome di Nicola
da Guardiagrele, come quello del solo autore degno di essa, Senonchè la conoscenza dei
pine. Più tardi, nell’anno 1449, mentre era priore il canonico
Fig. 6, 7 — Tivoli, Cattedrale. Ornati nel reliquiario argenteo
(sec. xv)