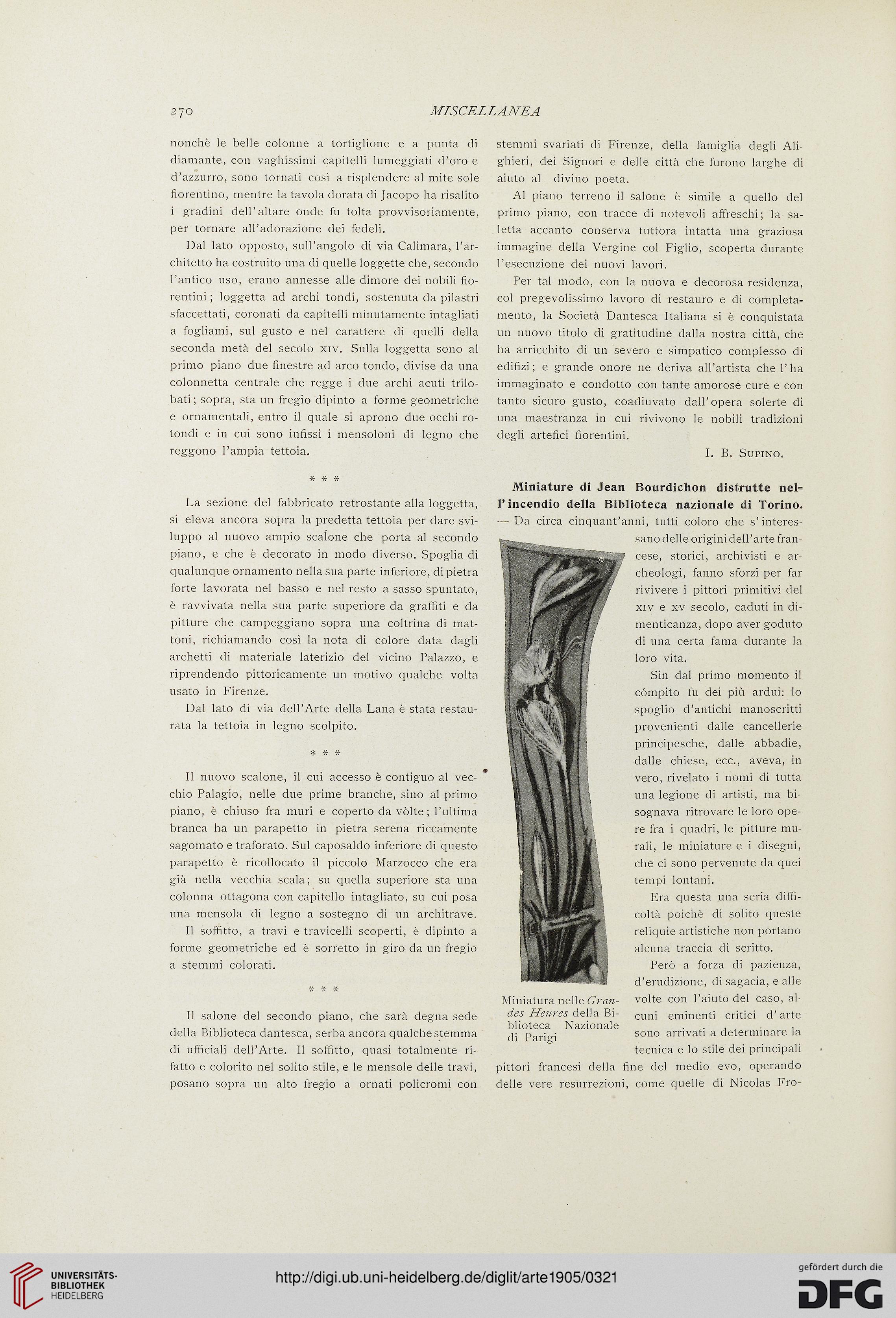2 70
MISCELLANEA
nonché le belle colonne a tortiglione e a punta di
diamante, con vaghissimi capitelli lumeggiati d’oro e
d’azzurro, sono tornati così a risplendere si mite sole
fiorentino, mentre la tavola dorata di Jacopo ha risalito
i gradini dell’altare onde fu tolta provvisoriamente,
per tornare all’adorazione dei fedeli.
Dal lato opposto, sull’angolo di via Calimara, l’ar-
chitetto ha costruito una di quelle loggette che, secondo
l’antico uso, erano annesse alle dimore dei nobili fio-
rentini ; loggetta ad archi tondi, sostenuta da pilastri
sfaccettati, coronati da capitelli minutamente intagliati
a fogliami, sul gusto e nel carattere di quelli della
seconda metà del secolo xiv. Sulla loggetta sono al
primo piano due finestre ad arco tondo, divise da una
colonnetta centrale che regge i due archi acuti trilo-
bati ; sopra, sta un fregio dipinto a forme geometriche
e ornamentali, entro il quale si aprono due occhi ro-
tondi e in cui sono infissi i mensoloni di legno che
reggono l’ampia tettoia.
stemmi svariati di Firenze, della famiglia degli Ali-
ghieri, dei Signori e delle città che furono larghe di
aiuto al divino poeta.
Al piano terreno il salone è simile a quello del
primo piano, con tracce di notevoli affreschi; la sa-
letta accanto conserva tuttora intatta una graziosa
immagine della Vergine col Figlio, scoperta durante
l’esecuzione dei nuovi lavori.
Per tal modo, con la nuova e decorosa residenza,
col pregevolissimo lavoro di restauro e di completa-
mento, la Società Dantesca Italiana si è conquistata
un nuovo titolo di gratitudine dalla nostra città, che
ha arricchito di un severo e simpatico complesso di
edifizi ; e grande onore ne deriva all’artista che l’ha
immaginato e condotto con tante amorose cure e con
tanto sicuro gusto, coadiuvato dall’opera solerte di
una maestranza in cui rivivono le nobili tradizioni
degli artefici fiorentini.
I. B. Supino.
* * *
La sezione del fabbricato retrostante alla loggetta,
si eleva ancora sopra la predetta tettoia per dare svi-
luppo al nuovo ampio scalone che porta al secondo
piano, e che è decorato in modo diverso. Spoglia di
qualunque ornamento nella sua parte inferiore, di pietra
forte lavorata nel basso e nel resto a sasso spuntato,
è ravvivata nella sua parte superiore da graffiti e da
pitture che campeggiano sopra una coltrina di mat-
toni, richiamando così la nota di colore data dagli
archetti di materiale laterizio del vicino Palazzo, e
riprendendo pittoricamente un motivo qualche volta
usato in Firenze.
Dal lato di via dell’Arte della Lana è stata restau-
rata la tettoia in legno scolpito.
* * *
Il nuovo scalone, il cui accesso è contiguo al vec-
chio Palagio, nelle due prime branche, sino al primo
piano, è chiuso fra muri e coperto da vòlte; l’ultima
branca ha un parapetto in pietra serena riccamente
sagomato e traforato. Sul caposaldo inferiore di questo
parapetto è ricollocato il piccolo Marzocco che era
già nella vecchia scala; su quella superiore sta una
colonna ottagona con capitello intagliato, su cui posa
una mensola di legno a sostegno di un architrave.
Il soffitto, a travi e travicelli scoperti, è dipinto a
forme geometriche ed è sorretto in giro da un fregio
a stemmi colorati.
* * *
Il salone del secondo piano, che sarà degna sede
della Biblioteca dantesca, serba ancora qualche stemma
di ufficiali dell’Arte. Il soffitto, quasi totalmente ri-
fatto e colorito nel solito stile, e le mensole delle travi,
posano sopra un alto fregio a ornati policromi con
Miniature di Jean Bourdichon distrutte nel-
l’incendio della Biblioteca nazionale di Torino.
— Da circa cinquantanni, tutti coloro che s’interes-
sano delle origini dell’arte fran-
cese, storici, archivisti e ar-
cheologi, fanno sforzi per far
rivivere i pittori primitivi del
xiv e xv secolo, caduti in di-
menticanza, dopo aver goduto
di una certa fama durante la
loro vita.
Sin dal primo momento il
compito fu dei più ardui: lo
spoglio d’antichi manoscritti
provenienti dalle cancellerie
principesche, dalle abbadie,
dalle chiese, ecc., aveva, in
vero, rivelato i nomi di tutta
una legione di artisti, ma bi-
sognava ritrovare le loro ope-
re fra i quadri, le pitture mu-
rali, le miniature e i disegni,
che ci sono pervenute da quei
tempi lontani.
Era questa una seria diffi-
coltà poiché di solito queste
reliquie artistiche non portano
alcuna traccia di scritto.
Però a forza di pazienza,
d’erudizione, di sagacia, e alle
volte con l’aiuto del caso, al-
cuni eminenti critici d’arte
sono arrivati a determinare la
tecnica e lo stile dei principali
pittori francesi della fine del medio evo, operando
delle vere resurrezioni, come quelle di Nicolas Fro-
Miniatura nelle Gran-
des Heures della Bi-
blioteca Nazionale
di Parigi
MISCELLANEA
nonché le belle colonne a tortiglione e a punta di
diamante, con vaghissimi capitelli lumeggiati d’oro e
d’azzurro, sono tornati così a risplendere si mite sole
fiorentino, mentre la tavola dorata di Jacopo ha risalito
i gradini dell’altare onde fu tolta provvisoriamente,
per tornare all’adorazione dei fedeli.
Dal lato opposto, sull’angolo di via Calimara, l’ar-
chitetto ha costruito una di quelle loggette che, secondo
l’antico uso, erano annesse alle dimore dei nobili fio-
rentini ; loggetta ad archi tondi, sostenuta da pilastri
sfaccettati, coronati da capitelli minutamente intagliati
a fogliami, sul gusto e nel carattere di quelli della
seconda metà del secolo xiv. Sulla loggetta sono al
primo piano due finestre ad arco tondo, divise da una
colonnetta centrale che regge i due archi acuti trilo-
bati ; sopra, sta un fregio dipinto a forme geometriche
e ornamentali, entro il quale si aprono due occhi ro-
tondi e in cui sono infissi i mensoloni di legno che
reggono l’ampia tettoia.
stemmi svariati di Firenze, della famiglia degli Ali-
ghieri, dei Signori e delle città che furono larghe di
aiuto al divino poeta.
Al piano terreno il salone è simile a quello del
primo piano, con tracce di notevoli affreschi; la sa-
letta accanto conserva tuttora intatta una graziosa
immagine della Vergine col Figlio, scoperta durante
l’esecuzione dei nuovi lavori.
Per tal modo, con la nuova e decorosa residenza,
col pregevolissimo lavoro di restauro e di completa-
mento, la Società Dantesca Italiana si è conquistata
un nuovo titolo di gratitudine dalla nostra città, che
ha arricchito di un severo e simpatico complesso di
edifizi ; e grande onore ne deriva all’artista che l’ha
immaginato e condotto con tante amorose cure e con
tanto sicuro gusto, coadiuvato dall’opera solerte di
una maestranza in cui rivivono le nobili tradizioni
degli artefici fiorentini.
I. B. Supino.
* * *
La sezione del fabbricato retrostante alla loggetta,
si eleva ancora sopra la predetta tettoia per dare svi-
luppo al nuovo ampio scalone che porta al secondo
piano, e che è decorato in modo diverso. Spoglia di
qualunque ornamento nella sua parte inferiore, di pietra
forte lavorata nel basso e nel resto a sasso spuntato,
è ravvivata nella sua parte superiore da graffiti e da
pitture che campeggiano sopra una coltrina di mat-
toni, richiamando così la nota di colore data dagli
archetti di materiale laterizio del vicino Palazzo, e
riprendendo pittoricamente un motivo qualche volta
usato in Firenze.
Dal lato di via dell’Arte della Lana è stata restau-
rata la tettoia in legno scolpito.
* * *
Il nuovo scalone, il cui accesso è contiguo al vec-
chio Palagio, nelle due prime branche, sino al primo
piano, è chiuso fra muri e coperto da vòlte; l’ultima
branca ha un parapetto in pietra serena riccamente
sagomato e traforato. Sul caposaldo inferiore di questo
parapetto è ricollocato il piccolo Marzocco che era
già nella vecchia scala; su quella superiore sta una
colonna ottagona con capitello intagliato, su cui posa
una mensola di legno a sostegno di un architrave.
Il soffitto, a travi e travicelli scoperti, è dipinto a
forme geometriche ed è sorretto in giro da un fregio
a stemmi colorati.
* * *
Il salone del secondo piano, che sarà degna sede
della Biblioteca dantesca, serba ancora qualche stemma
di ufficiali dell’Arte. Il soffitto, quasi totalmente ri-
fatto e colorito nel solito stile, e le mensole delle travi,
posano sopra un alto fregio a ornati policromi con
Miniature di Jean Bourdichon distrutte nel-
l’incendio della Biblioteca nazionale di Torino.
— Da circa cinquantanni, tutti coloro che s’interes-
sano delle origini dell’arte fran-
cese, storici, archivisti e ar-
cheologi, fanno sforzi per far
rivivere i pittori primitivi del
xiv e xv secolo, caduti in di-
menticanza, dopo aver goduto
di una certa fama durante la
loro vita.
Sin dal primo momento il
compito fu dei più ardui: lo
spoglio d’antichi manoscritti
provenienti dalle cancellerie
principesche, dalle abbadie,
dalle chiese, ecc., aveva, in
vero, rivelato i nomi di tutta
una legione di artisti, ma bi-
sognava ritrovare le loro ope-
re fra i quadri, le pitture mu-
rali, le miniature e i disegni,
che ci sono pervenute da quei
tempi lontani.
Era questa una seria diffi-
coltà poiché di solito queste
reliquie artistiche non portano
alcuna traccia di scritto.
Però a forza di pazienza,
d’erudizione, di sagacia, e alle
volte con l’aiuto del caso, al-
cuni eminenti critici d’arte
sono arrivati a determinare la
tecnica e lo stile dei principali
pittori francesi della fine del medio evo, operando
delle vere resurrezioni, come quelle di Nicolas Fro-
Miniatura nelle Gran-
des Heures della Bi-
blioteca Nazionale
di Parigi