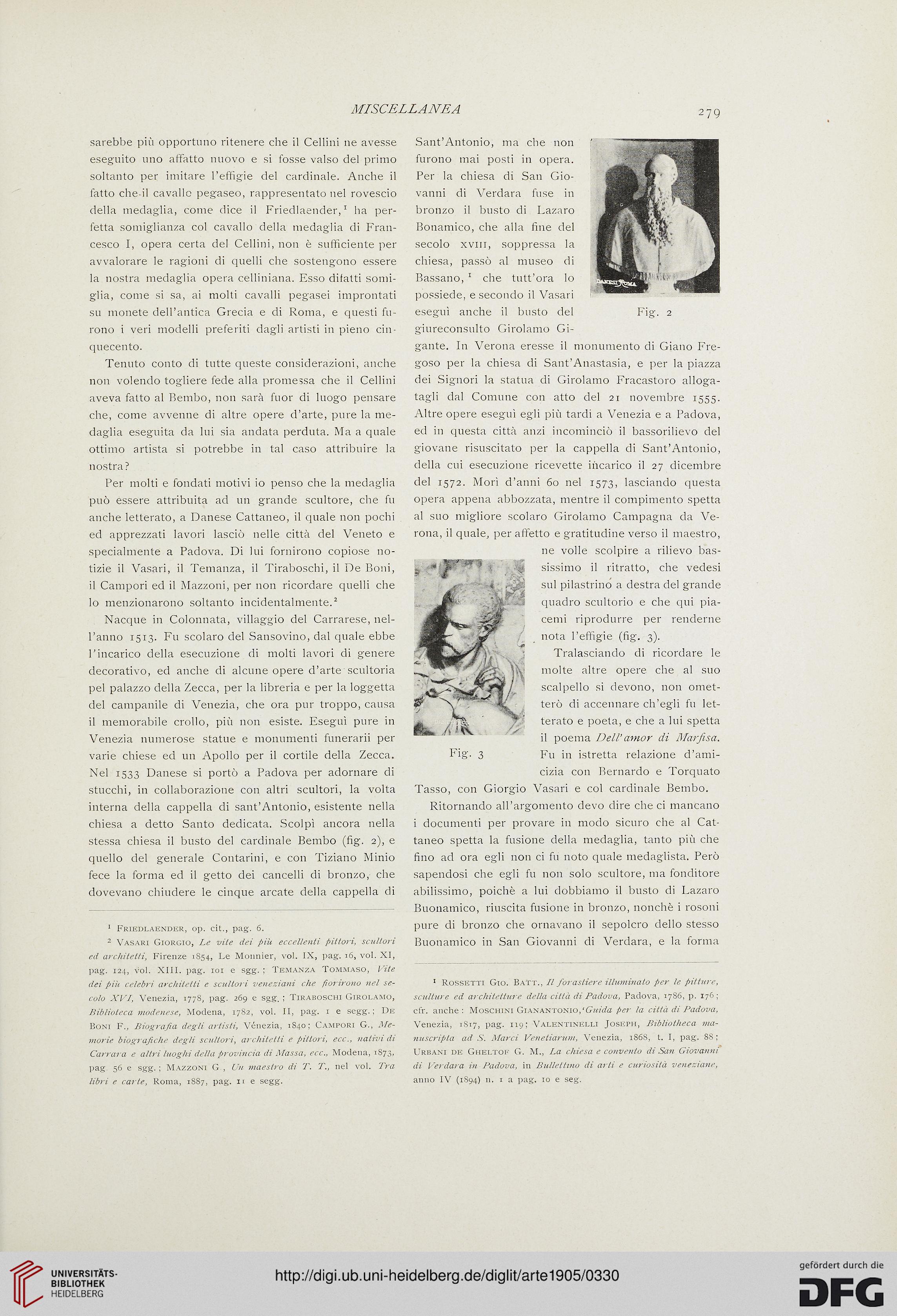MISCELLANEA
sarebbe più opportuno ritenere che il Celimi ne avesse
eseguito uno affatto nuovo e si fosse valso del primo
soltanto per imitare l’effigie del cardinale. Anche il
fatto che-il cavallo pegaseo, rappresentato nel rovescio
della medaglia, come dice il Friedlaender,1 ha per-
fetta somiglianza col cavallo della medaglia di Fran-
cesco I, opera certa del Cellini, non è sufficiente per
avvalorare le ragioni di quelli che sostengono essere
la nostra medaglia opera celliniana. Esso difatti somi-
glia, come si sa, ai molti cavalli pegasei improntati
su monete dell’antica Grecia e di Roma, e questi fu-
rono i veri modelli preferiti dagli artisti in pieno cin-
quecento.
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, anche
non volendo togliere fede alla promessa che il Cellini
aveva fatto al Bembo, non sarà fuor di luogo pensare
che, come avvenne di altre opere d’arte, pure la me-
daglia eseguita da lui sia andata perduta. Ma a quale
ottimo artista si potrebbe in tal caso attribuire la
nostra?
Per molti e fondati motivi io penso che la medaglia
può essere attribuita ad un grande scultore, che fu
anche letterato, a Danese Cattaneo, il quale non pochi
ed apprezzati lavori lasciò nelle città del Veneto e
specialmente a Padova. Di lui fornirono copiose no-
tizie il Vasari, il Temanza, il Tiraboschi, il De Boni,
il Campori ed il Mazzoni, per non ricordare quelli che
10 menzionarono soltanto incidentalmente.2
Nacque in Colonnata, villaggio del Carrarese, nel-
l’anno 1513. Fu scolaro del Sansovino, dal quale ebbe
l’incarico della esecuzione di molti lavori di genere
decorativo, ed anche di alcune opere d’arte scultoria
pel palazzo della Zecca, per la libreria e per la loggetta
del campanile di Venezia, che ora pur troppo, causa
11 memorabile crollo, più non esiste. Eseguì pure in
Venezia numerose statue e monumenti funerarii per
varie chiese ed un Apollo per il cortile della Zecca.
Nel 1533 Danese si portò a Padova per adornare di
stucchi, in collaborazione con altri scultori, la volta
interna della cappella di sant’Antonio, esistente nella
chiesa a detto Santo dedicata. Scolpì ancora nella
stessa chiesa il busto del cardinale Bembo (fig. 2), e
quello del generale Contarmi, e con Tiziano Minio
fece la forma ed il getto dei cancelli di bronzo, che
dovevano chiudere le cinque arcate della cappella di
1 Friedlaender, op. cit., pag. 6.
2 Vasari Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori
ed architetti, Firenze 1854, Le Mounier, voi. IX, pag. 16, voi. XI,
pag. 124, voi. XIII. pag. 101 e sgg. ; Temanza Tommaso, Vite
dei più celebri architetti e scultori veneziani che fior irono nel se-
colo XVI, Venezia, 1778, pag. 269 e sgg. ; Tiraboschi Girolamo,
Biblioteca modenese, Modena, 1782, voi. II, pag. 1 e segg. ; De
Boni F., Biografia degli artisti, Venezia, 1840; Campori G., Me-
morie biografiche degli scultori, architetti e pittori, ecc., nativi di
Carrara e altri luoghi della provincia di Massa, ecc., Modena, 1873,
pag. 56 e sgg.; Mazzoni G , Un maestro di T. T.t nel voi. Tra
libri e carte, Roma, 1887, pag. n e segg.
Sant’Antonio, ma che non
furono mai posti in opera.
Per la chiesa di San Gio-
vanni di Verdara fuse in
bronzo il busto di Lazaro
Bonamico, che alla fine del
secolo xviii, soppressa la
chiesa, passò al museo di
Bassano, 1 che tutt’ora lo
possiede, e secondo il Vasari
eseguì anche il busto del
giureconsulto Girolamo Gi-
gante. In Verona eresse il monumento di Giano Fre-
goso per la chiesa di Sant’Anastasia, e per la piazza
dei Signori la statua di Girolamo Fracastoro alloga-
tagli dal Comune con atto del 21 novembre 1555.
Altre opere eseguì egli più tardi a Venezia e a Padova,
ed in questa città anzi incominciò il bassorilievo del
giovane risuscitato per la cappella di Sant’Antonio,
della cui esecuzione ricevette incarico il 27 dicembre
del 1572. Morì d’anni 60 nel 1573, lasciando questa
opera appena abbozzata, mentre il compimento spetta
al suo migliore scolaro Girolamo Campagna da Ve-
rona, il quale, per affetto e gratitudine verso il maestro,
ne volle scolpire a rilievo bas-
sissimo il ritratto, che vedesi
sul pilastrino a destra del grande
quadro scultorio e che qui pia-
cemi riprodurre per renderne
nota l’effigie (fìg. 3).
Tralasciando di ricordare le
molte altre opere che al suo
scalpello si devono, non omet-
terò di accennare ch’egli fu let-
terato e poeta, e che a lui spetta
il poema Dell’ amor di Marfisa.
Fu in istretta relazione d’ami-
cizia con Bernardo e Torquato
Vasari e col cardinale Bembo.
Ritornando all’argomento devo dire che ci mancano
i documenti per provare in modo sicuro che al Cat-
taneo spetta la fusione della medaglia, tanto più che
fino ad ora egli non ci fu noto quale medaglista. Però
sapendosi che egli fu non solo scultore, ma fonditore
abilissimo, poiché a lui dobbiamo il busto di Lazaro
Buonamico, riuscita fusione in bronzo, nonché i rosoni
pure di bronzo che ornavano il sepolcro dello stesso
Buonamico in San Giovanni di Verdara, e la forma
1 Rossetti Gio. BaTt., Il forastiene illuminato per le pitture,
sculture ed architetture della città di Padova, Padova, 1786, p. 176;
cfr. anche: Moschini Gianantonio,‘GWafa per la città di Padova,
Venezia, 1817, pag. 119; Valentinelli Joseph, Bibliotheca ina-
nuscripta ad S. Marci Venetiarum, Venezia, 1868, t. I, pag. 88;
Urbani de Gheltof G. M., La chiesa e convento di San Giovanni
di Verdara in Padova, in Bullettmo di arti e curiosità veneziane,
anno IV (1894) n. 1 a pag. 10 e seg.
Fig. 3
Tasso, con Giorgio
sarebbe più opportuno ritenere che il Celimi ne avesse
eseguito uno affatto nuovo e si fosse valso del primo
soltanto per imitare l’effigie del cardinale. Anche il
fatto che-il cavallo pegaseo, rappresentato nel rovescio
della medaglia, come dice il Friedlaender,1 ha per-
fetta somiglianza col cavallo della medaglia di Fran-
cesco I, opera certa del Cellini, non è sufficiente per
avvalorare le ragioni di quelli che sostengono essere
la nostra medaglia opera celliniana. Esso difatti somi-
glia, come si sa, ai molti cavalli pegasei improntati
su monete dell’antica Grecia e di Roma, e questi fu-
rono i veri modelli preferiti dagli artisti in pieno cin-
quecento.
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, anche
non volendo togliere fede alla promessa che il Cellini
aveva fatto al Bembo, non sarà fuor di luogo pensare
che, come avvenne di altre opere d’arte, pure la me-
daglia eseguita da lui sia andata perduta. Ma a quale
ottimo artista si potrebbe in tal caso attribuire la
nostra?
Per molti e fondati motivi io penso che la medaglia
può essere attribuita ad un grande scultore, che fu
anche letterato, a Danese Cattaneo, il quale non pochi
ed apprezzati lavori lasciò nelle città del Veneto e
specialmente a Padova. Di lui fornirono copiose no-
tizie il Vasari, il Temanza, il Tiraboschi, il De Boni,
il Campori ed il Mazzoni, per non ricordare quelli che
10 menzionarono soltanto incidentalmente.2
Nacque in Colonnata, villaggio del Carrarese, nel-
l’anno 1513. Fu scolaro del Sansovino, dal quale ebbe
l’incarico della esecuzione di molti lavori di genere
decorativo, ed anche di alcune opere d’arte scultoria
pel palazzo della Zecca, per la libreria e per la loggetta
del campanile di Venezia, che ora pur troppo, causa
11 memorabile crollo, più non esiste. Eseguì pure in
Venezia numerose statue e monumenti funerarii per
varie chiese ed un Apollo per il cortile della Zecca.
Nel 1533 Danese si portò a Padova per adornare di
stucchi, in collaborazione con altri scultori, la volta
interna della cappella di sant’Antonio, esistente nella
chiesa a detto Santo dedicata. Scolpì ancora nella
stessa chiesa il busto del cardinale Bembo (fig. 2), e
quello del generale Contarmi, e con Tiziano Minio
fece la forma ed il getto dei cancelli di bronzo, che
dovevano chiudere le cinque arcate della cappella di
1 Friedlaender, op. cit., pag. 6.
2 Vasari Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori
ed architetti, Firenze 1854, Le Mounier, voi. IX, pag. 16, voi. XI,
pag. 124, voi. XIII. pag. 101 e sgg. ; Temanza Tommaso, Vite
dei più celebri architetti e scultori veneziani che fior irono nel se-
colo XVI, Venezia, 1778, pag. 269 e sgg. ; Tiraboschi Girolamo,
Biblioteca modenese, Modena, 1782, voi. II, pag. 1 e segg. ; De
Boni F., Biografia degli artisti, Venezia, 1840; Campori G., Me-
morie biografiche degli scultori, architetti e pittori, ecc., nativi di
Carrara e altri luoghi della provincia di Massa, ecc., Modena, 1873,
pag. 56 e sgg.; Mazzoni G , Un maestro di T. T.t nel voi. Tra
libri e carte, Roma, 1887, pag. n e segg.
Sant’Antonio, ma che non
furono mai posti in opera.
Per la chiesa di San Gio-
vanni di Verdara fuse in
bronzo il busto di Lazaro
Bonamico, che alla fine del
secolo xviii, soppressa la
chiesa, passò al museo di
Bassano, 1 che tutt’ora lo
possiede, e secondo il Vasari
eseguì anche il busto del
giureconsulto Girolamo Gi-
gante. In Verona eresse il monumento di Giano Fre-
goso per la chiesa di Sant’Anastasia, e per la piazza
dei Signori la statua di Girolamo Fracastoro alloga-
tagli dal Comune con atto del 21 novembre 1555.
Altre opere eseguì egli più tardi a Venezia e a Padova,
ed in questa città anzi incominciò il bassorilievo del
giovane risuscitato per la cappella di Sant’Antonio,
della cui esecuzione ricevette incarico il 27 dicembre
del 1572. Morì d’anni 60 nel 1573, lasciando questa
opera appena abbozzata, mentre il compimento spetta
al suo migliore scolaro Girolamo Campagna da Ve-
rona, il quale, per affetto e gratitudine verso il maestro,
ne volle scolpire a rilievo bas-
sissimo il ritratto, che vedesi
sul pilastrino a destra del grande
quadro scultorio e che qui pia-
cemi riprodurre per renderne
nota l’effigie (fìg. 3).
Tralasciando di ricordare le
molte altre opere che al suo
scalpello si devono, non omet-
terò di accennare ch’egli fu let-
terato e poeta, e che a lui spetta
il poema Dell’ amor di Marfisa.
Fu in istretta relazione d’ami-
cizia con Bernardo e Torquato
Vasari e col cardinale Bembo.
Ritornando all’argomento devo dire che ci mancano
i documenti per provare in modo sicuro che al Cat-
taneo spetta la fusione della medaglia, tanto più che
fino ad ora egli non ci fu noto quale medaglista. Però
sapendosi che egli fu non solo scultore, ma fonditore
abilissimo, poiché a lui dobbiamo il busto di Lazaro
Buonamico, riuscita fusione in bronzo, nonché i rosoni
pure di bronzo che ornavano il sepolcro dello stesso
Buonamico in San Giovanni di Verdara, e la forma
1 Rossetti Gio. BaTt., Il forastiene illuminato per le pitture,
sculture ed architetture della città di Padova, Padova, 1786, p. 176;
cfr. anche: Moschini Gianantonio,‘GWafa per la città di Padova,
Venezia, 1817, pag. 119; Valentinelli Joseph, Bibliotheca ina-
nuscripta ad S. Marci Venetiarum, Venezia, 1868, t. I, pag. 88;
Urbani de Gheltof G. M., La chiesa e convento di San Giovanni
di Verdara in Padova, in Bullettmo di arti e curiosità veneziane,
anno IV (1894) n. 1 a pag. 10 e seg.
Fig. 3
Tasso, con Giorgio