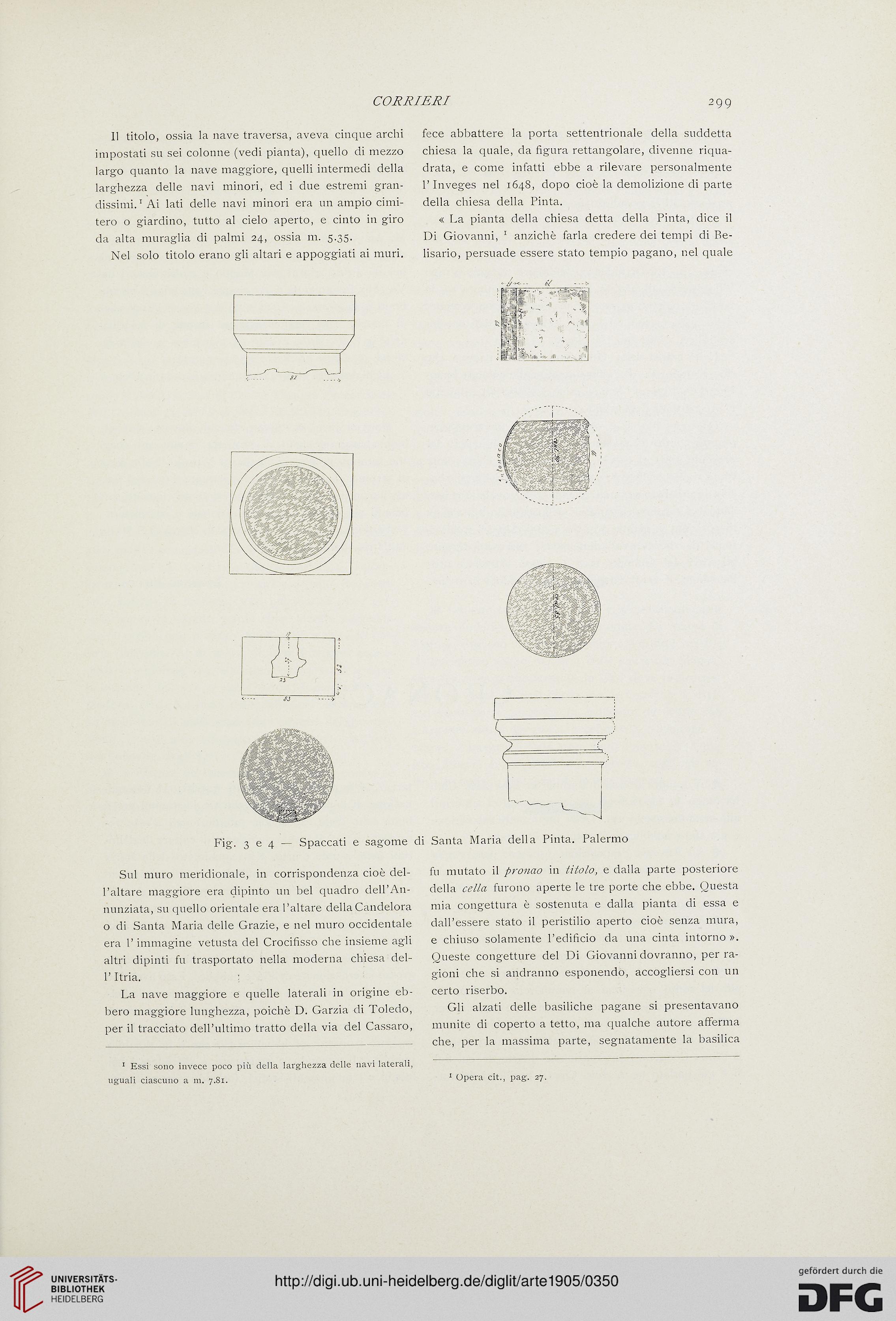CORRIERI 299
Il titolo, ossia la nave traversa, aveva cinque archi fece abbattere la porta settentrionale della suddetta
impostati su sei colonne (vedi pianta), quello di mezzo
largo quanto la nave maggiore, quelli intermedi della
larghezza delle navi minori, ed i due estremi gran-
dissimi.1 Ai lati delle navi minori era un ampio cimi-
tero o giardino, tutto al cielo aperto, e cinto in giro
da alta muraglia di palmi 24, ossia m. 5.35.
Nel solo titolo erano gli altari e appoggiati ai muri.
Fig. 3 e 4 — Spaccati e sagome di
Sul muro meridionale, in corrispondenza cioè del-
l’altare maggiore era dipinto un bel quadro dell’An-
nunziata, su quello orientale era l’altare della Candelora
o di Santa Maria delle Grazie, e nel muro occidentale
era l’immagine vetusta del Crocifisso che insieme agli
altri dipinti fu trasportato nella moderna chiesa del-
l’Itria.
La nave maggiore e quelle laterali in origine eb-
bero maggiore lunghezza, poiché D. Garzia di Toledo,
per il tracciato dell’ultimo tratto della via del Cassaro,
1 Essi sono invece poco più della larghezza delle navi laterali,
uguali ciascuno a m. 7.81.
chiesa la quale, da figura rettangolare, divenne riqua-
drata, e come infatti ebbe a rilevare personalmente
l’Inveges nel 1648, dopo cioè la demolizione di parte
della chiesa della Pinta.
« La pianta della chiesa detta della Pinta, dice il
Di Giovanni, 1 anziché farla credere dei tempi di Be-
lisario, persuade essere stato tempio pagano, nel quale
Santa Maria della Pinta. Palermo
fu mutato il pronao in titolo, e dalla parte posteriore
della cella furono aperte le tre porte che ebbe. Questa
mia congettura è sostenuta e dalla pianta di essa e
dall’essere stato il peristilio aperto cioè senza mura,
e chiuso solamente l’edificio da una cinta intorno ».
Queste congetture del Di Giovanni dovranno, per ra-
gioni che si andranno esponendo, accogliersi con un
certo riserbo.
Gli alzati delle basiliche pagane si presentavano
munite di coperto a tetto, ma qualche autore afferma
che, per la massima parte, segnatamente la basilica
1 Opera cit., pag. 27.
Il titolo, ossia la nave traversa, aveva cinque archi fece abbattere la porta settentrionale della suddetta
impostati su sei colonne (vedi pianta), quello di mezzo
largo quanto la nave maggiore, quelli intermedi della
larghezza delle navi minori, ed i due estremi gran-
dissimi.1 Ai lati delle navi minori era un ampio cimi-
tero o giardino, tutto al cielo aperto, e cinto in giro
da alta muraglia di palmi 24, ossia m. 5.35.
Nel solo titolo erano gli altari e appoggiati ai muri.
Fig. 3 e 4 — Spaccati e sagome di
Sul muro meridionale, in corrispondenza cioè del-
l’altare maggiore era dipinto un bel quadro dell’An-
nunziata, su quello orientale era l’altare della Candelora
o di Santa Maria delle Grazie, e nel muro occidentale
era l’immagine vetusta del Crocifisso che insieme agli
altri dipinti fu trasportato nella moderna chiesa del-
l’Itria.
La nave maggiore e quelle laterali in origine eb-
bero maggiore lunghezza, poiché D. Garzia di Toledo,
per il tracciato dell’ultimo tratto della via del Cassaro,
1 Essi sono invece poco più della larghezza delle navi laterali,
uguali ciascuno a m. 7.81.
chiesa la quale, da figura rettangolare, divenne riqua-
drata, e come infatti ebbe a rilevare personalmente
l’Inveges nel 1648, dopo cioè la demolizione di parte
della chiesa della Pinta.
« La pianta della chiesa detta della Pinta, dice il
Di Giovanni, 1 anziché farla credere dei tempi di Be-
lisario, persuade essere stato tempio pagano, nel quale
Santa Maria della Pinta. Palermo
fu mutato il pronao in titolo, e dalla parte posteriore
della cella furono aperte le tre porte che ebbe. Questa
mia congettura è sostenuta e dalla pianta di essa e
dall’essere stato il peristilio aperto cioè senza mura,
e chiuso solamente l’edificio da una cinta intorno ».
Queste congetture del Di Giovanni dovranno, per ra-
gioni che si andranno esponendo, accogliersi con un
certo riserbo.
Gli alzati delle basiliche pagane si presentavano
munite di coperto a tetto, ma qualche autore afferma
che, per la massima parte, segnatamente la basilica
1 Opera cit., pag. 27.