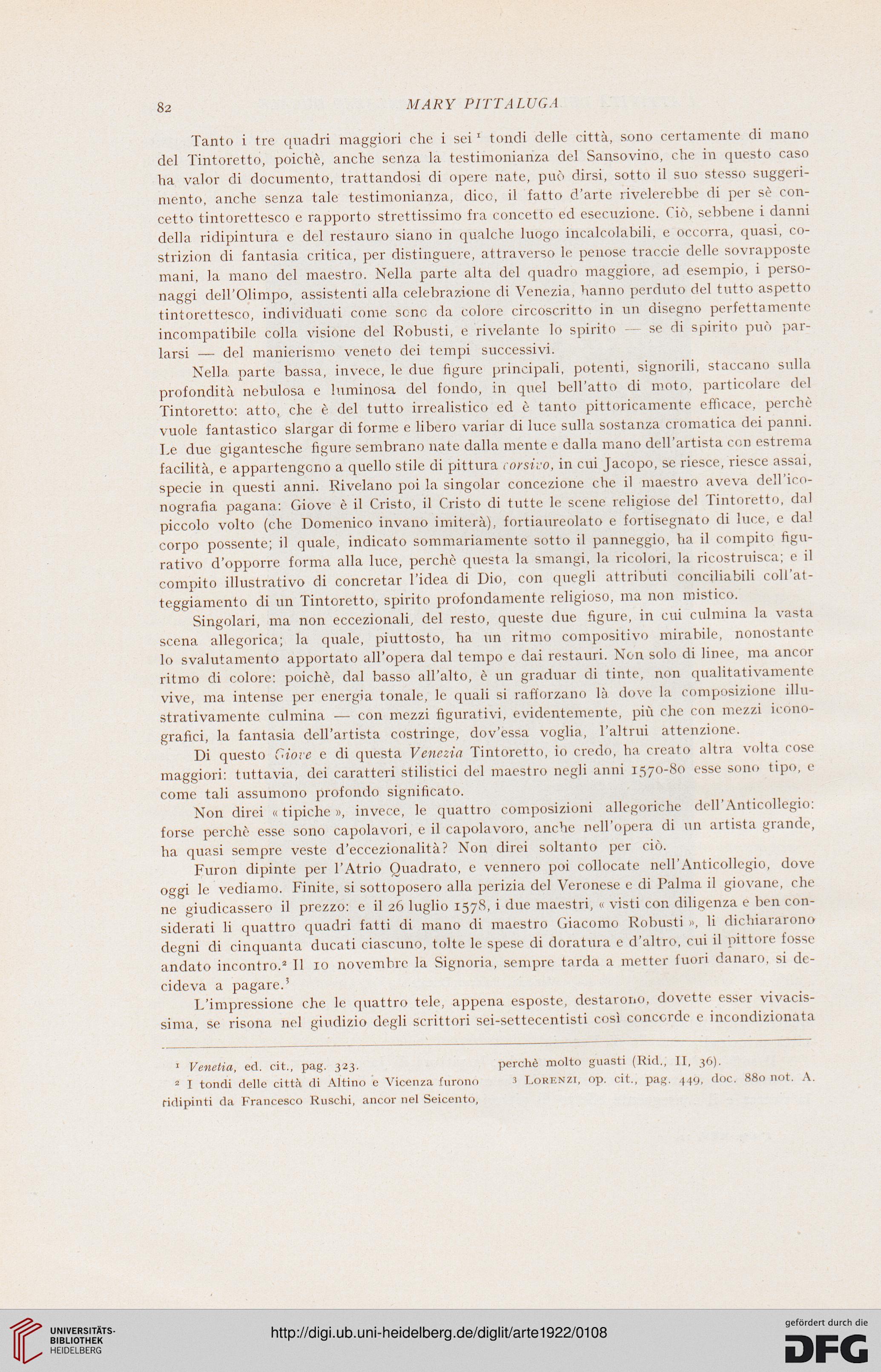82
MARY PITTA LUCA
Tanto i tre quadri maggiori che i sei1 tondi delle città, sono certamente di mano
del Tintoretto, poiché, anche senza la testimonianza del Sansovino, che in questo caso
ha valor di documento, trattandosi di opere nate, può dirsi, sotto il suo stesso suggeri-
ménto, anche senza tale testimonianza, dico, il fatto d'arte rivelerebbe di per sè con-
cetto tintorettesco e rapporto strettissimo fra concetto ed esecuzione. Ciò, sebbene i danni
della ridipintura e del restauro siano in qualche luògo incalcolabili, e occorra, quasi, co-
strizion di fantasia critica, per distinguere, attraverso le penose traccie delle sovrapposte
mani, la mano del maestro. Nella parte alta del quadro maggiore, ad esempio, i perso-
naggi dell'Olimpo, assistenti alla celebrazione di Venezia, hanno perduto del tutto aspetto
tintorettesco, individuati come seno da colore circoscritto in un disegno perfettamente
incompatibile colla visione del Robusti, e rivelante lo spirito — se di spirito può par-
larsi — del manierismo veneto dei tempi successivi.
Nella parte bassa, invece, le due figure principali, potenti, signorili, staccano sulla
profondità nebulosa e luminosa del fondo, in quel bell'atto di moto, particolare del
Tintoretto: atto, che è del tutto irrealistico ed è tanto pittoricamente efficace, perchè
vuole fantastico slargar di forme e libero variar di luce sulla sostanza cromatica dei panni,
he due gigantesche figure sembrano nate dalla mente e dalla mano dell'artista con estrema
facilità, e appartengono a quello stile di pittura corsivo, in cui Jacopo, se riesce, riesce assai,
specie in questi anni. Rivelano poi la singoiar concezione che il maestro aveva dell'ico-
nografia pagana: Giove è il Cristo, il Cristo di tutte le scene u ligiose del Tintoretto, dal
piccolo volto (che Domenico invano imiterà), fortiaureolato e fortisegnato di luce, e da!
corpo possente; il quale, indicato sommariamente sotto il panneggio, ha il compito figu-
rativo d'opporre forma alla luce, perchè questa la smangi, la ricolori, la ricostruisca; e il
compito illustrativo di concretar l'idea di Dio, con quegli attributi conciliabili coll'at-
teggiamento di un Tintoretto, spirito profondamente religioso, ma non mistico.
Singolari, ma non eccezionali, del resto, queste due figure, in cui culmina la vasta
si-ena allegorica; la quale, piuttosto, ha un ritmo compositivo mirabile, nonostante
lo svalutamento apportato all'opera dal tempo e dai restauri. Non solo di linee, ma ancor
ritmo di colore: poiché, dal basso all'alto, è un graduar di tinte, non qualitativamente
vive, ma intense per energia tonale, le quali si rafforzano là dove la composizione illu-
strativamente culmina — con mezzi figurativi, evidentemente, più che con mezzi icono-
grafici, la fantasia dell'artista costringe, dov'essa voglia, l'altrui attenzione.
Di questo Giove e di questa Venezia Tintoretto, io credo, ha creato altra volta cose
maggiori: tuttavia, dei caratteri stilistici del maestro negli anni 1570-80 esse sono tipo, e
come tali assumono profondo significato.
Non direi «tipiche», invece, le quattro composizioni allegoriche dell'Anticollegio:
forse perchè esse sono capolavori, e il capolavoro, anche nell'opera di un artista grande,
ha quasi sempre veste d'eccezionalità? Non direi soltanto per ciò.
Furon dipinte per l'Atrio Quadrato, e vennero poi collocate nelTAnticollegio, dove
oggi le vediamo. Finite, si sottoposero alla perizia del Veronese e di Palma il giovane, che
ne giudicassero il prezzo: e il 26 luglio 1578, i due maestri, « visti con diligenza e ben con-
siderati li quattro quadri fatti di mano di maestro Giacomo Robusti », li dichiararono
degni di cinquanta ducati ciascuno, tolte le spese di doratura e d'altro, cui il pittore fosse
andato incontro.1 Il 10 novembre la Signoria, sempre tarda a metter fuori danaro, si de-
cideva a pagare.'
L'impressione che le quattro tele, appena esposte, destarono, dovette esser vivacis-
sima, se risona nel giudizio degli scrittori sei-settecentisti così concorde e incondizionata
perchè molto guasti (Riti., II, 36).
J Lorenzi, op. cit., pag. 449, (loc. 880 not. A.
MARY PITTA LUCA
Tanto i tre quadri maggiori che i sei1 tondi delle città, sono certamente di mano
del Tintoretto, poiché, anche senza la testimonianza del Sansovino, che in questo caso
ha valor di documento, trattandosi di opere nate, può dirsi, sotto il suo stesso suggeri-
ménto, anche senza tale testimonianza, dico, il fatto d'arte rivelerebbe di per sè con-
cetto tintorettesco e rapporto strettissimo fra concetto ed esecuzione. Ciò, sebbene i danni
della ridipintura e del restauro siano in qualche luògo incalcolabili, e occorra, quasi, co-
strizion di fantasia critica, per distinguere, attraverso le penose traccie delle sovrapposte
mani, la mano del maestro. Nella parte alta del quadro maggiore, ad esempio, i perso-
naggi dell'Olimpo, assistenti alla celebrazione di Venezia, hanno perduto del tutto aspetto
tintorettesco, individuati come seno da colore circoscritto in un disegno perfettamente
incompatibile colla visione del Robusti, e rivelante lo spirito — se di spirito può par-
larsi — del manierismo veneto dei tempi successivi.
Nella parte bassa, invece, le due figure principali, potenti, signorili, staccano sulla
profondità nebulosa e luminosa del fondo, in quel bell'atto di moto, particolare del
Tintoretto: atto, che è del tutto irrealistico ed è tanto pittoricamente efficace, perchè
vuole fantastico slargar di forme e libero variar di luce sulla sostanza cromatica dei panni,
he due gigantesche figure sembrano nate dalla mente e dalla mano dell'artista con estrema
facilità, e appartengono a quello stile di pittura corsivo, in cui Jacopo, se riesce, riesce assai,
specie in questi anni. Rivelano poi la singoiar concezione che il maestro aveva dell'ico-
nografia pagana: Giove è il Cristo, il Cristo di tutte le scene u ligiose del Tintoretto, dal
piccolo volto (che Domenico invano imiterà), fortiaureolato e fortisegnato di luce, e da!
corpo possente; il quale, indicato sommariamente sotto il panneggio, ha il compito figu-
rativo d'opporre forma alla luce, perchè questa la smangi, la ricolori, la ricostruisca; e il
compito illustrativo di concretar l'idea di Dio, con quegli attributi conciliabili coll'at-
teggiamento di un Tintoretto, spirito profondamente religioso, ma non mistico.
Singolari, ma non eccezionali, del resto, queste due figure, in cui culmina la vasta
si-ena allegorica; la quale, piuttosto, ha un ritmo compositivo mirabile, nonostante
lo svalutamento apportato all'opera dal tempo e dai restauri. Non solo di linee, ma ancor
ritmo di colore: poiché, dal basso all'alto, è un graduar di tinte, non qualitativamente
vive, ma intense per energia tonale, le quali si rafforzano là dove la composizione illu-
strativamente culmina — con mezzi figurativi, evidentemente, più che con mezzi icono-
grafici, la fantasia dell'artista costringe, dov'essa voglia, l'altrui attenzione.
Di questo Giove e di questa Venezia Tintoretto, io credo, ha creato altra volta cose
maggiori: tuttavia, dei caratteri stilistici del maestro negli anni 1570-80 esse sono tipo, e
come tali assumono profondo significato.
Non direi «tipiche», invece, le quattro composizioni allegoriche dell'Anticollegio:
forse perchè esse sono capolavori, e il capolavoro, anche nell'opera di un artista grande,
ha quasi sempre veste d'eccezionalità? Non direi soltanto per ciò.
Furon dipinte per l'Atrio Quadrato, e vennero poi collocate nelTAnticollegio, dove
oggi le vediamo. Finite, si sottoposero alla perizia del Veronese e di Palma il giovane, che
ne giudicassero il prezzo: e il 26 luglio 1578, i due maestri, « visti con diligenza e ben con-
siderati li quattro quadri fatti di mano di maestro Giacomo Robusti », li dichiararono
degni di cinquanta ducati ciascuno, tolte le spese di doratura e d'altro, cui il pittore fosse
andato incontro.1 Il 10 novembre la Signoria, sempre tarda a metter fuori danaro, si de-
cideva a pagare.'
L'impressione che le quattro tele, appena esposte, destarono, dovette esser vivacis-
sima, se risona nel giudizio degli scrittori sei-settecentisti così concorde e incondizionata
perchè molto guasti (Riti., II, 36).
J Lorenzi, op. cit., pag. 449, (loc. 880 not. A.