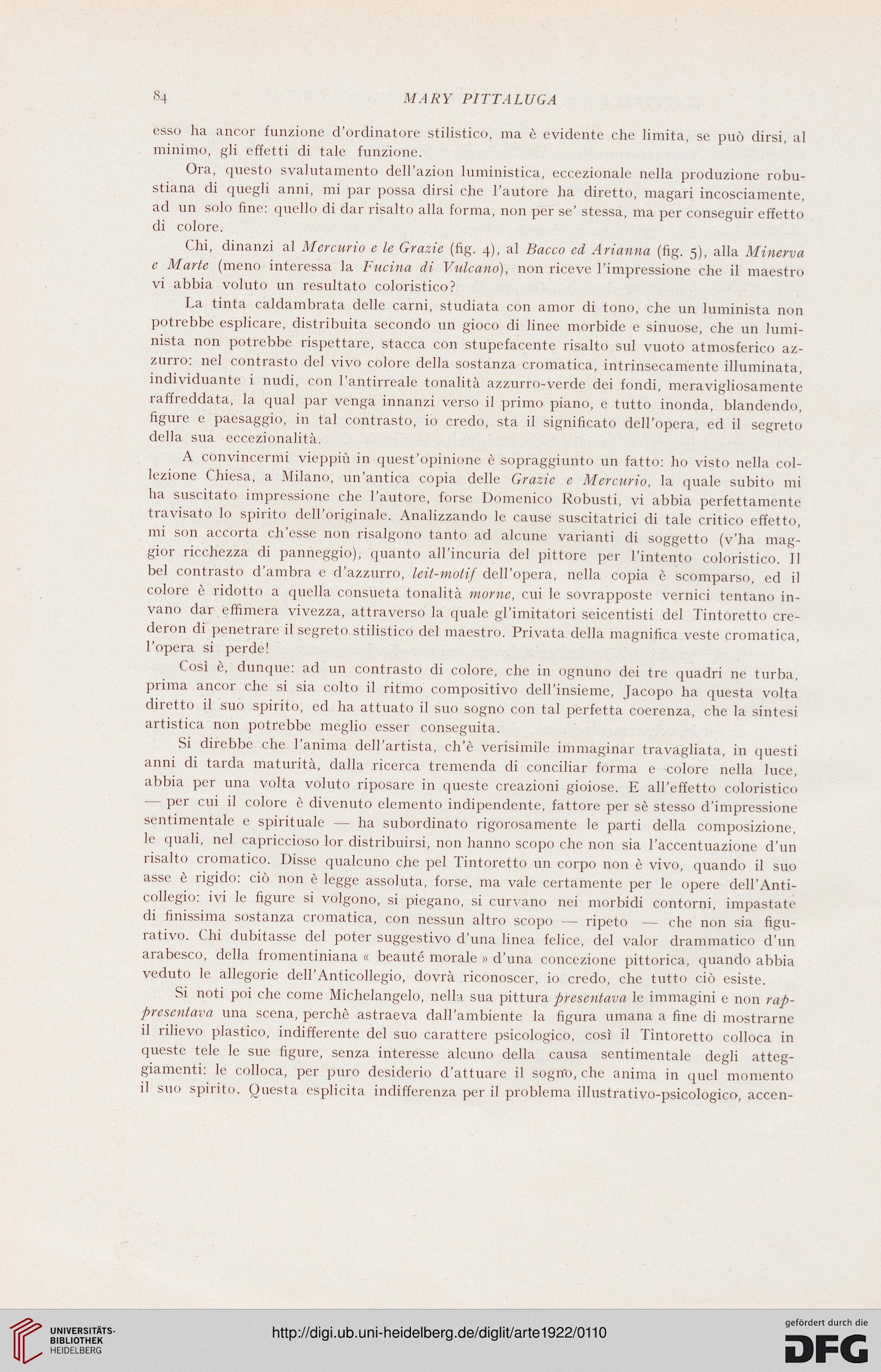84
MARY PITTALUGA
esso ha ancor funzione d'ordinatore stilistico, ma è evidente che limita, se può dirsi, al
minimo, gli effetti di tale funzione.
Ora, questo svalutamento dell'azion luministica, eccezionale nella produzione robu-
stiana di quegli anni, mi par possa dirsi che l'autore ha diretto, magari incosciamente,
ad un solo fine: (niello di dar risalto alla forma, non per se' stessa, ma per conseguir effetto
di colore.
Chi, dinanzi al Mercurio e le Grazie (fig. 4), al Bacco ed Arianna (fig. 5), alla Minerva
e Marte (meno interessa la Fucina di Vulcano), non riceve l'impressione che il maestro
vi abbia voluto un resultato coloristico?
La tinta caldambrata delle carni, studiata con amor di tono, che un luminista non
potrebbe esplicare, distribuita secondo un gioco di linee morbide e sinuose, che un lumi-
nista non potrebbe rispettare, stacca con stupefacente risalto sul vuoto atmosferico az-
zurro: nel contrasto del vivo colore della sostanza cromatica, intrinsecamente illuminata,
individuante i nudi, con l'antirrcale tonalità azzurro-verde dei fondi, meravigliosamente
raffreddata, la (piai par venga innanzi verso il primo piano, e tutto inonda, blandendo,
figure e paesaggio, in tal contrasto, io credo, sta il significato dell'opera, ed il segreto
della sua eccezionalità.
A convincermi vieppiù in quest'opinione è sopraggiunto un fatto: ho visto nella col-
lezione Chiesa, a Milano, un'antica copia delle Grazie e Mercurio, la quale subito mi
ha suscitato impressione che l'autore, forse Domenico Robusti, vi abbia perfettamente
travisato lo spirito dell'originale. Analizzando le cause suscitatrici di tale critico effetto,
mi son accorta ch'esse non risalgono tanto ad alcune varianti di soggetto (v'ha mag-
gior ricchezza di panneggio), (pianto all'incuria del pittore per l'intento coloristico. Il
bel contrasto d'ambra e d'azzurro, leit-motif dell'opera, nella copia è scomparso, ed il
colore è ridotto a quella consueta tonalità mome, cui le sovrapposte vernici tentano in-
vano dar effimera vivezza, attraverso la (piale gl'imitatori seicentisti del Tintoretto crc-
deron di penetrare il segreto stilistico del maestro. Privata della magnifica veste cromatica,
l'opera si perde!
Così è, dunque: ad un contrasto di colore, che in ognuno dei tre quadri ne turba,
prima ancor che si sia colto il ritmo compositivo dell'insieme, Jacopo ha questa volta
diretto il suo spirito, ed ha attuato il suo sogno con tal perfetta coerenza, che la sintesi
artistica non potrebbe meglio esser conseguita.
Si direbbe che l'anima dell'artista, ch'è verisimile immaginar travagliata, in questi
anni di tarda maturità, dalla ricerca tremenda di conciliar forma e colore nella luce,
abbia per una volta voluto riposare in queste creazioni gioiose. E all'effetto coloristico
per cui il colore è divenuto elemento indipendente, fattore per sè stesso d'impressione
sentimentale e spirituale — ha subordinato rigorosamente le parti della composizione,
le quali, nel capriccioso lor distribuirsi, non hanno scopo che non sia l'accentuazione d'un
risalto cromatico. Disse qualcuno che pel Tintoretto un corpo non è vivo, quando il suo
asse è rigido: ciò non è legge assoluta, forse, ma vale certamente per le opere dell'Anta
collegio: ivi le ligure si volgono, si piegano, si curvano nei morbidi contorni, impastate
di finissima sostanza cromatica, con nessun altro scopo — ripeto — che non sia figu-
rativo. Chi dubitasse del poter suggestivo d'una linea felice, del valor drammatico d'un
arabesco, della fromentiniana « beauté morale » d'una concezione pittorica, (piando abbia
veduto le allegorie dell'Anticollegio, dovrà riconoscer, io credo, che tutto ciò esiste.
Si noti poi che come Michelangelo, nella sua pittura presentava le immagini e non rap-
presentava una scena, perchè astraeva dall'ambiente la figura umana a fine di mostrarne
il rilievo plastico, indifferente del suo carattere psicologico, così il Tintoretto colloca in
queste tele le sue figure, senza interesse alcuno della causa sentimentale degli atteg-
giamenti: le colloca, per puro desiderio d'attuare il sogn'o, che anima in quel momento
il suo spirito. Onesta esplicita indifferenza per il problema illustrativo-psicologico, accen-
MARY PITTALUGA
esso ha ancor funzione d'ordinatore stilistico, ma è evidente che limita, se può dirsi, al
minimo, gli effetti di tale funzione.
Ora, questo svalutamento dell'azion luministica, eccezionale nella produzione robu-
stiana di quegli anni, mi par possa dirsi che l'autore ha diretto, magari incosciamente,
ad un solo fine: (niello di dar risalto alla forma, non per se' stessa, ma per conseguir effetto
di colore.
Chi, dinanzi al Mercurio e le Grazie (fig. 4), al Bacco ed Arianna (fig. 5), alla Minerva
e Marte (meno interessa la Fucina di Vulcano), non riceve l'impressione che il maestro
vi abbia voluto un resultato coloristico?
La tinta caldambrata delle carni, studiata con amor di tono, che un luminista non
potrebbe esplicare, distribuita secondo un gioco di linee morbide e sinuose, che un lumi-
nista non potrebbe rispettare, stacca con stupefacente risalto sul vuoto atmosferico az-
zurro: nel contrasto del vivo colore della sostanza cromatica, intrinsecamente illuminata,
individuante i nudi, con l'antirrcale tonalità azzurro-verde dei fondi, meravigliosamente
raffreddata, la (piai par venga innanzi verso il primo piano, e tutto inonda, blandendo,
figure e paesaggio, in tal contrasto, io credo, sta il significato dell'opera, ed il segreto
della sua eccezionalità.
A convincermi vieppiù in quest'opinione è sopraggiunto un fatto: ho visto nella col-
lezione Chiesa, a Milano, un'antica copia delle Grazie e Mercurio, la quale subito mi
ha suscitato impressione che l'autore, forse Domenico Robusti, vi abbia perfettamente
travisato lo spirito dell'originale. Analizzando le cause suscitatrici di tale critico effetto,
mi son accorta ch'esse non risalgono tanto ad alcune varianti di soggetto (v'ha mag-
gior ricchezza di panneggio), (pianto all'incuria del pittore per l'intento coloristico. Il
bel contrasto d'ambra e d'azzurro, leit-motif dell'opera, nella copia è scomparso, ed il
colore è ridotto a quella consueta tonalità mome, cui le sovrapposte vernici tentano in-
vano dar effimera vivezza, attraverso la (piale gl'imitatori seicentisti del Tintoretto crc-
deron di penetrare il segreto stilistico del maestro. Privata della magnifica veste cromatica,
l'opera si perde!
Così è, dunque: ad un contrasto di colore, che in ognuno dei tre quadri ne turba,
prima ancor che si sia colto il ritmo compositivo dell'insieme, Jacopo ha questa volta
diretto il suo spirito, ed ha attuato il suo sogno con tal perfetta coerenza, che la sintesi
artistica non potrebbe meglio esser conseguita.
Si direbbe che l'anima dell'artista, ch'è verisimile immaginar travagliata, in questi
anni di tarda maturità, dalla ricerca tremenda di conciliar forma e colore nella luce,
abbia per una volta voluto riposare in queste creazioni gioiose. E all'effetto coloristico
per cui il colore è divenuto elemento indipendente, fattore per sè stesso d'impressione
sentimentale e spirituale — ha subordinato rigorosamente le parti della composizione,
le quali, nel capriccioso lor distribuirsi, non hanno scopo che non sia l'accentuazione d'un
risalto cromatico. Disse qualcuno che pel Tintoretto un corpo non è vivo, quando il suo
asse è rigido: ciò non è legge assoluta, forse, ma vale certamente per le opere dell'Anta
collegio: ivi le ligure si volgono, si piegano, si curvano nei morbidi contorni, impastate
di finissima sostanza cromatica, con nessun altro scopo — ripeto — che non sia figu-
rativo. Chi dubitasse del poter suggestivo d'una linea felice, del valor drammatico d'un
arabesco, della fromentiniana « beauté morale » d'una concezione pittorica, (piando abbia
veduto le allegorie dell'Anticollegio, dovrà riconoscer, io credo, che tutto ciò esiste.
Si noti poi che come Michelangelo, nella sua pittura presentava le immagini e non rap-
presentava una scena, perchè astraeva dall'ambiente la figura umana a fine di mostrarne
il rilievo plastico, indifferente del suo carattere psicologico, così il Tintoretto colloca in
queste tele le sue figure, senza interesse alcuno della causa sentimentale degli atteg-
giamenti: le colloca, per puro desiderio d'attuare il sogn'o, che anima in quel momento
il suo spirito. Onesta esplicita indifferenza per il problema illustrativo-psicologico, accen-