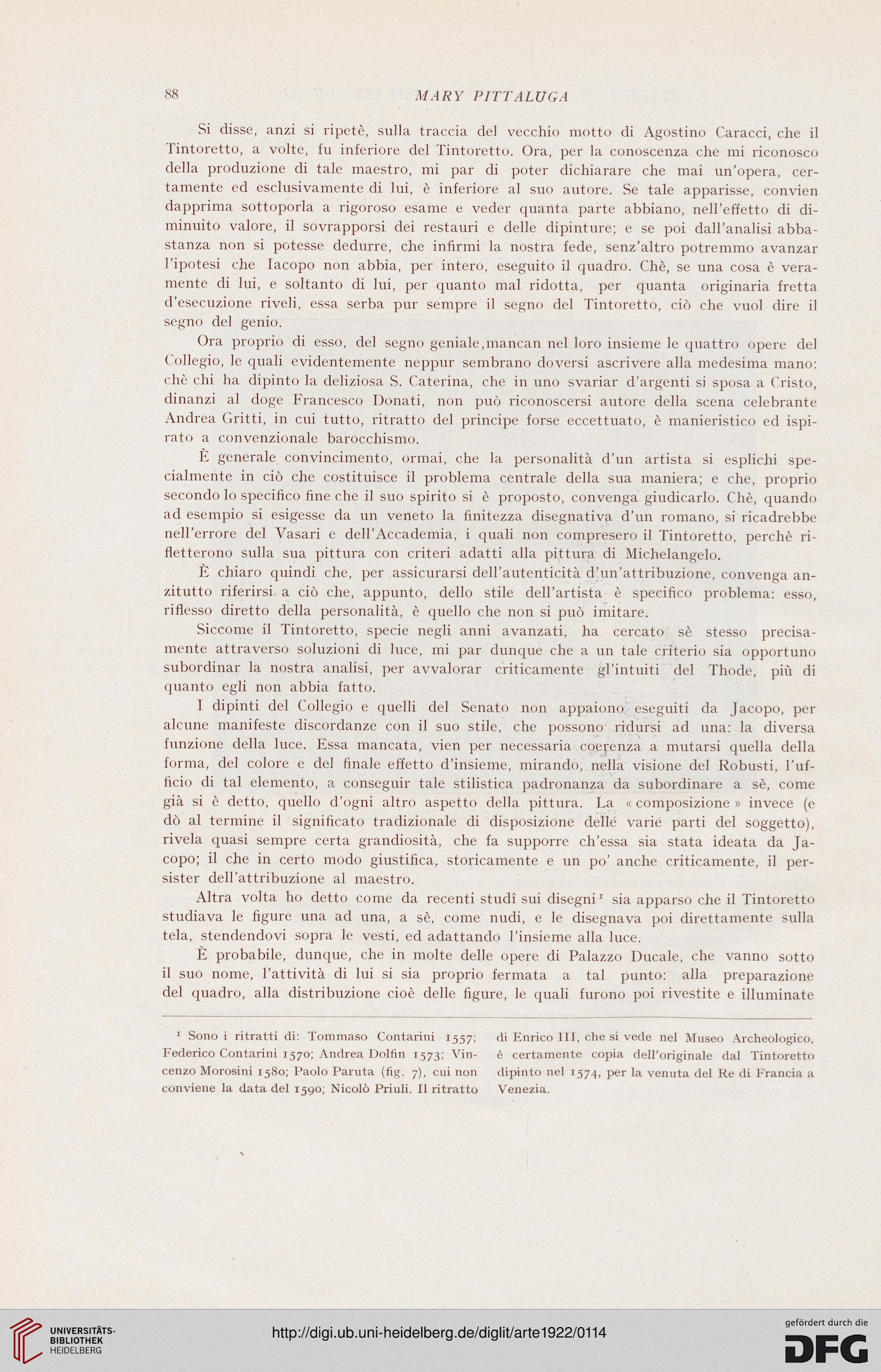88
MARY PITTALUdA
Si disse, anzi si ripetè, sulla traccia del vecchio motto di Agostino Caracci, che il
Tintoretto, a volte, fu inferiore del Tintoretto. Ora, per la conoscenza che mi riconosco
della produzione di tale maestro, mi par di poter dichiarare che mai un'opera, cer-
tamente ed esclusivamente di lui, è inferiore al suo autore. Se tale apparisse, convien
dapprima sottoporla a rigoroso esame e veder quanta parte abbiano, nell'effetto di di-
minuito valore, il sovrapporsi dei restauri e delle dipinture; e se poi dall'analisi abba-
stanza non si potesse dedurre, che infirmi la nostra fede, senz'altro potremmo avanzar
l'ipotesi che Iacopo non abbia, per intero, eseguito il quadro. Chè, se una cosa è vera-
mente di lui, e soltanto di lui, per quanto mal ridotta, per quanta originaria fretta
d'esecuzione riveli, essa serba pur sempre il segno del Tintoretto, ciò che vuol dire il
segno del genio.
Ora proprio di esso, del segno geniale,mancan nel loro insieme le quattro opere del
Collegio, le (piali evidentemente neppur sembrano doversi ascrivere alla medesima mano:
chè chi ha dipinto la deliziosa S. ('aterina, che in uno svariar d'argenti si sposa a Cristo,
dinanzi al doge Francesco Donati, non può riconoscersi autori' della scena celebrante
Andrea Gritti, in cui tutto, ritratto del principe forse eccettuato, è manieristico ed ispi-
rato a convenzionale barocchismo.
È generale convincimento, ormai, che la personalità d'un artista si esplichi spe-
cialmente in ciò che costituisce il problema centrale della sua maniera; e che, proprio
secondo lo specifico fine che il suo spirito si è proposto, convenga giudicarlo. Chè, quando
ad esempio si esigesse da un veneto la finitezza disegnativa d'un romano, si ricadrebbe
nell'errore del Vasari e dell'Accademia, i quali non compresero il Tintoretto, perchè ri-
fletterono sulla sua pittura con criteri adatti alla pittura di Michelangelo.
È chiaro quindi che, per assicurarsi dell'autenticità d'un'attribuzione, convenga an-
zitutto riferirsi a ciò che, appunto, dello stile dell'artista è specifico problema: esso,
riflesso diretto della personalità, è quello che non si può imitare.
Siccome il Tintoretto, specie negli anni avanzati, ha cercato sè stesso precisa-
mente attraverso soluzioni di luce, mi par dunque che a un tale criterio sia opportuno
subordinar la nostra analisi, per avvalorar criticamente gl'intuiti del Thode, più di
(pianto egli non abbia fatto.
1 dipinti del Collegio e quelli del Senato non appaiono eseguiti da Jacopo, per
alcune manifeste discordanze con il suo stile, che possono ridursi ad una: la diversa
funzione della luce. Essa mancata, vien per necessaria coerenza a mutarsi quella della
forma, del colore e del finale effetto d'insieme, mirando, nella visione del Robusti, l'uf-
ficio di tal elemento, a conseguir tale stilistica padronanza da subordinare a sè, come
già si è detto, quello d'ogni altro aspetto della pittura. La « composizione » invece (e
dò al termine il significato tradizionale di disposizione delle varie parti del soggetto),
rivela quasi sempre certa grandiosità, che fa supporre ch'essa sia stata ideata da Ja-
copo; il che in certo modo giustifica, storicamente e un po' anche criticamente, il per-
sister dell'attribuzione al maestro.
Altra volta ho detto come da recenti studi sui disegni1 sia apparso che il Tintoretto
studiava le figure una ad una, a sè, come nudi, e le disegnava poi direttamente sulla
tela, stendendovi sopra le vesti, ed adattando l'insieme alla luce.
È probabile, dunque, che in molte delle opere di Palazzo Ducale, che vanno sotto
il suo nome, l'attività di lui si sia proprio fermata a tal punto: alla preparazione
del quadro, alla distribuzione cioè delle figure, le quali furono poi rivestite e illuminate
1 Sono i ritratti di: Tommaso Contarmi 1557;
Federico Contarmi 1570; Andrea Dolfln 1573; Yin
cenzo Morosini 1580; Paolo Paruta (fig. 7), cui non
conviene la data del 1590; Nicolò Priuli. Il ritratto
di Enrico III, che si vede nel Museo Archeologico,
è certamente copia dell'originale dal Tintoretto
dipinto nel 1574, per la venuta del Re di Francia a
Venezia.
MARY PITTALUdA
Si disse, anzi si ripetè, sulla traccia del vecchio motto di Agostino Caracci, che il
Tintoretto, a volte, fu inferiore del Tintoretto. Ora, per la conoscenza che mi riconosco
della produzione di tale maestro, mi par di poter dichiarare che mai un'opera, cer-
tamente ed esclusivamente di lui, è inferiore al suo autore. Se tale apparisse, convien
dapprima sottoporla a rigoroso esame e veder quanta parte abbiano, nell'effetto di di-
minuito valore, il sovrapporsi dei restauri e delle dipinture; e se poi dall'analisi abba-
stanza non si potesse dedurre, che infirmi la nostra fede, senz'altro potremmo avanzar
l'ipotesi che Iacopo non abbia, per intero, eseguito il quadro. Chè, se una cosa è vera-
mente di lui, e soltanto di lui, per quanto mal ridotta, per quanta originaria fretta
d'esecuzione riveli, essa serba pur sempre il segno del Tintoretto, ciò che vuol dire il
segno del genio.
Ora proprio di esso, del segno geniale,mancan nel loro insieme le quattro opere del
Collegio, le (piali evidentemente neppur sembrano doversi ascrivere alla medesima mano:
chè chi ha dipinto la deliziosa S. ('aterina, che in uno svariar d'argenti si sposa a Cristo,
dinanzi al doge Francesco Donati, non può riconoscersi autori' della scena celebrante
Andrea Gritti, in cui tutto, ritratto del principe forse eccettuato, è manieristico ed ispi-
rato a convenzionale barocchismo.
È generale convincimento, ormai, che la personalità d'un artista si esplichi spe-
cialmente in ciò che costituisce il problema centrale della sua maniera; e che, proprio
secondo lo specifico fine che il suo spirito si è proposto, convenga giudicarlo. Chè, quando
ad esempio si esigesse da un veneto la finitezza disegnativa d'un romano, si ricadrebbe
nell'errore del Vasari e dell'Accademia, i quali non compresero il Tintoretto, perchè ri-
fletterono sulla sua pittura con criteri adatti alla pittura di Michelangelo.
È chiaro quindi che, per assicurarsi dell'autenticità d'un'attribuzione, convenga an-
zitutto riferirsi a ciò che, appunto, dello stile dell'artista è specifico problema: esso,
riflesso diretto della personalità, è quello che non si può imitare.
Siccome il Tintoretto, specie negli anni avanzati, ha cercato sè stesso precisa-
mente attraverso soluzioni di luce, mi par dunque che a un tale criterio sia opportuno
subordinar la nostra analisi, per avvalorar criticamente gl'intuiti del Thode, più di
(pianto egli non abbia fatto.
1 dipinti del Collegio e quelli del Senato non appaiono eseguiti da Jacopo, per
alcune manifeste discordanze con il suo stile, che possono ridursi ad una: la diversa
funzione della luce. Essa mancata, vien per necessaria coerenza a mutarsi quella della
forma, del colore e del finale effetto d'insieme, mirando, nella visione del Robusti, l'uf-
ficio di tal elemento, a conseguir tale stilistica padronanza da subordinare a sè, come
già si è detto, quello d'ogni altro aspetto della pittura. La « composizione » invece (e
dò al termine il significato tradizionale di disposizione delle varie parti del soggetto),
rivela quasi sempre certa grandiosità, che fa supporre ch'essa sia stata ideata da Ja-
copo; il che in certo modo giustifica, storicamente e un po' anche criticamente, il per-
sister dell'attribuzione al maestro.
Altra volta ho detto come da recenti studi sui disegni1 sia apparso che il Tintoretto
studiava le figure una ad una, a sè, come nudi, e le disegnava poi direttamente sulla
tela, stendendovi sopra le vesti, ed adattando l'insieme alla luce.
È probabile, dunque, che in molte delle opere di Palazzo Ducale, che vanno sotto
il suo nome, l'attività di lui si sia proprio fermata a tal punto: alla preparazione
del quadro, alla distribuzione cioè delle figure, le quali furono poi rivestite e illuminate
1 Sono i ritratti di: Tommaso Contarmi 1557;
Federico Contarmi 1570; Andrea Dolfln 1573; Yin
cenzo Morosini 1580; Paolo Paruta (fig. 7), cui non
conviene la data del 1590; Nicolò Priuli. Il ritratto
di Enrico III, che si vede nel Museo Archeologico,
è certamente copia dell'originale dal Tintoretto
dipinto nel 1574, per la venuta del Re di Francia a
Venezia.