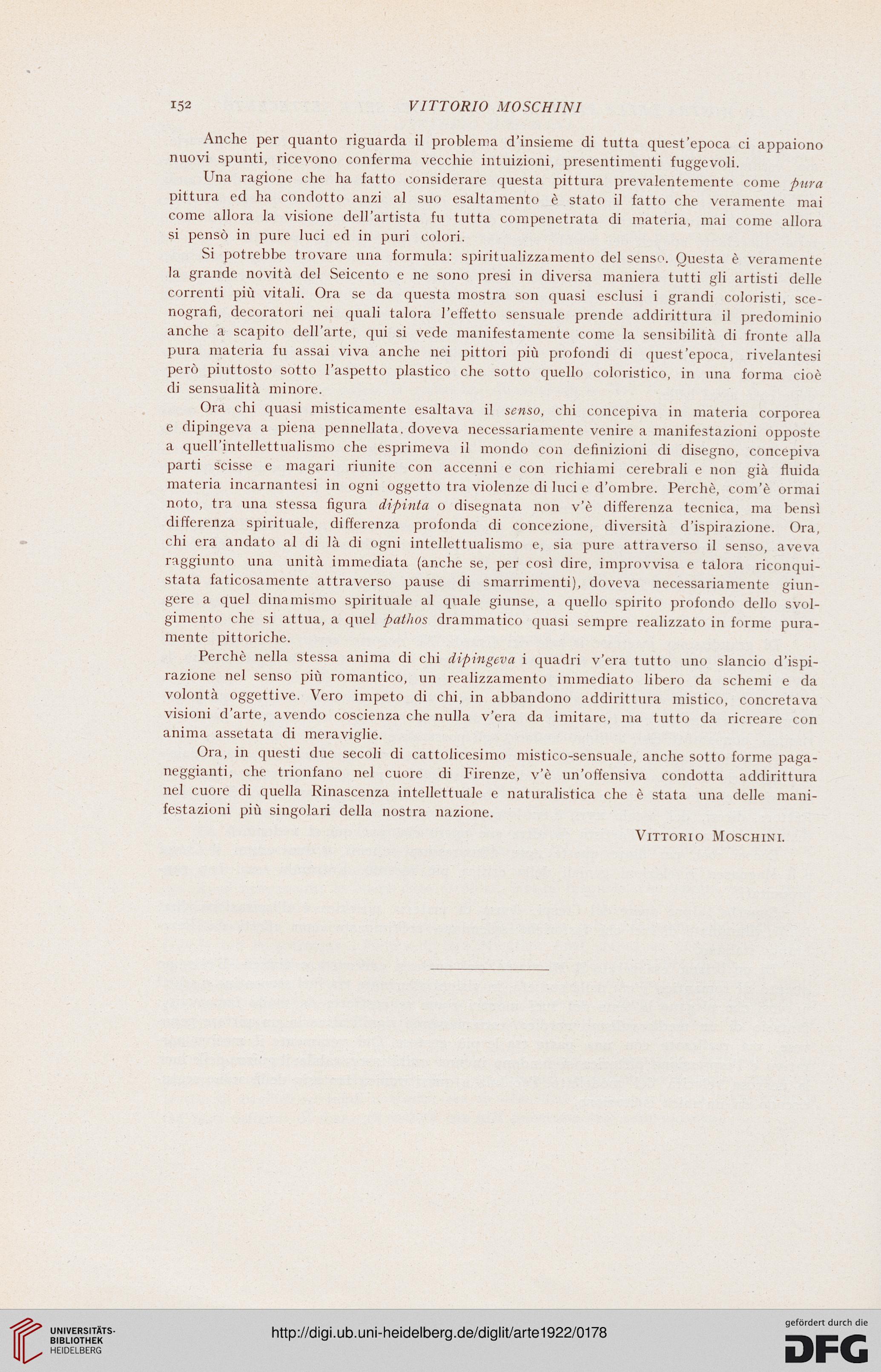152
VITTORIO MOSCHINI
Anche per quanto riguarda il problema d'insieme di tutta quest'epoca ci appaiono
nuovi spunti, ricevono conferma vecchie intuizioni, presentimenti fuggevoli.
Una ragione che ha fatto considerare questa pittura prevalentemente come pura
pittura ed ha condotto anzi al suo esaltamento è stato il fatto che veramente mai
come allora la visione dell'artista fu tutta compenetrata di materia, mai come allora
si pensò in pure luci ed in puri colori.
Si potrebbe trovare una formula: spiritualizzamento del senso. Questa è veramente
la grande novità del Seicento e ne sono presi in diversa maniera tutti gli artisti delle
correnti più vitali. Ora se da questa mostra son (masi esclusi i grandi coloristi, sce-
nografi, decoratori nei quali talora l'effetto sensuale prende addirittura il predominio
anche a scapito dell'arte, qui si vede manifestamente come la sensibilità di fronte alla
pura materia fu assai viva anche nei pittori più profondi di quest'epoca, rivelantesi
però piuttosto sotto l'aspetto plastico che sotto quello coloristico, in una forma cioè
di sensualità minore.
Ora chi quasi misticamente esaltava il senso, ehi concepiva in materia corporea
e dipingeva a piena pennellata, doveva necessariamente venire a manifestazioni opposte
a quell'intellettualismo che esprimeva il mondo con definizioni di disegno, concepiva
parti scisse e magari riunite con accenni e con richiami cerebrali e non già fluida
materia incarnantesi in ogni oggetto tra violenze di luci e d'ombre. Perchè, com'è ormai
noto, tra una stessa figura dipinta o disegnata non v'è differenza tecnica, ma bensì
differenza spirituale, differenza profonda di concezione, diversità d'ispirazione. Ora,
chi era andato al di là di ogni intellettualismo e, sia pure attraverso il senso, aveva
raggiunto una unità immediata (anche se, per così dire, improvvisa e talora riconqui-
stata faticosamente attraverso pause di smarrimenti), doveva necessariamente giun-
gere a quel dinamismo spirituale al quale giunse, a quello spirito profondo dello svol-
gimento che si attua, a quel pathos drammatico quasi sempre realizzato in forme pura-
mente pittoriche.
Perchè nella stessa anima di chi dipingeva i quadri v'era tutto uno slancio d'ispi-
razione nel senso più romantico, un realizzamento immediato libero da schemi e da
volontà oggettive. Vero impeto di chi, in abbandono addirittura mistico, concretava
visioni d'arte, avendo coscienza che nulla v'era da imitare, ma tutto da ricreare con
anima assetata di meraviglie.
Ora, in questi due secoli di cattolicesimo mistico-sensuale, anche sotto forme paga-
neggianti, che trionfano nel cuore di Firenze, v'è un'offensiva condotta addirittura
nel cuore di quella Rinascenza intellettuale e naturalistica che è stata una delle mani-
festazioni più singolari della nostra nazione.
Vittorio Moschini.
VITTORIO MOSCHINI
Anche per quanto riguarda il problema d'insieme di tutta quest'epoca ci appaiono
nuovi spunti, ricevono conferma vecchie intuizioni, presentimenti fuggevoli.
Una ragione che ha fatto considerare questa pittura prevalentemente come pura
pittura ed ha condotto anzi al suo esaltamento è stato il fatto che veramente mai
come allora la visione dell'artista fu tutta compenetrata di materia, mai come allora
si pensò in pure luci ed in puri colori.
Si potrebbe trovare una formula: spiritualizzamento del senso. Questa è veramente
la grande novità del Seicento e ne sono presi in diversa maniera tutti gli artisti delle
correnti più vitali. Ora se da questa mostra son (masi esclusi i grandi coloristi, sce-
nografi, decoratori nei quali talora l'effetto sensuale prende addirittura il predominio
anche a scapito dell'arte, qui si vede manifestamente come la sensibilità di fronte alla
pura materia fu assai viva anche nei pittori più profondi di quest'epoca, rivelantesi
però piuttosto sotto l'aspetto plastico che sotto quello coloristico, in una forma cioè
di sensualità minore.
Ora chi quasi misticamente esaltava il senso, ehi concepiva in materia corporea
e dipingeva a piena pennellata, doveva necessariamente venire a manifestazioni opposte
a quell'intellettualismo che esprimeva il mondo con definizioni di disegno, concepiva
parti scisse e magari riunite con accenni e con richiami cerebrali e non già fluida
materia incarnantesi in ogni oggetto tra violenze di luci e d'ombre. Perchè, com'è ormai
noto, tra una stessa figura dipinta o disegnata non v'è differenza tecnica, ma bensì
differenza spirituale, differenza profonda di concezione, diversità d'ispirazione. Ora,
chi era andato al di là di ogni intellettualismo e, sia pure attraverso il senso, aveva
raggiunto una unità immediata (anche se, per così dire, improvvisa e talora riconqui-
stata faticosamente attraverso pause di smarrimenti), doveva necessariamente giun-
gere a quel dinamismo spirituale al quale giunse, a quello spirito profondo dello svol-
gimento che si attua, a quel pathos drammatico quasi sempre realizzato in forme pura-
mente pittoriche.
Perchè nella stessa anima di chi dipingeva i quadri v'era tutto uno slancio d'ispi-
razione nel senso più romantico, un realizzamento immediato libero da schemi e da
volontà oggettive. Vero impeto di chi, in abbandono addirittura mistico, concretava
visioni d'arte, avendo coscienza che nulla v'era da imitare, ma tutto da ricreare con
anima assetata di meraviglie.
Ora, in questi due secoli di cattolicesimo mistico-sensuale, anche sotto forme paga-
neggianti, che trionfano nel cuore di Firenze, v'è un'offensiva condotta addirittura
nel cuore di quella Rinascenza intellettuale e naturalistica che è stata una delle mani-
festazioni più singolari della nostra nazione.
Vittorio Moschini.