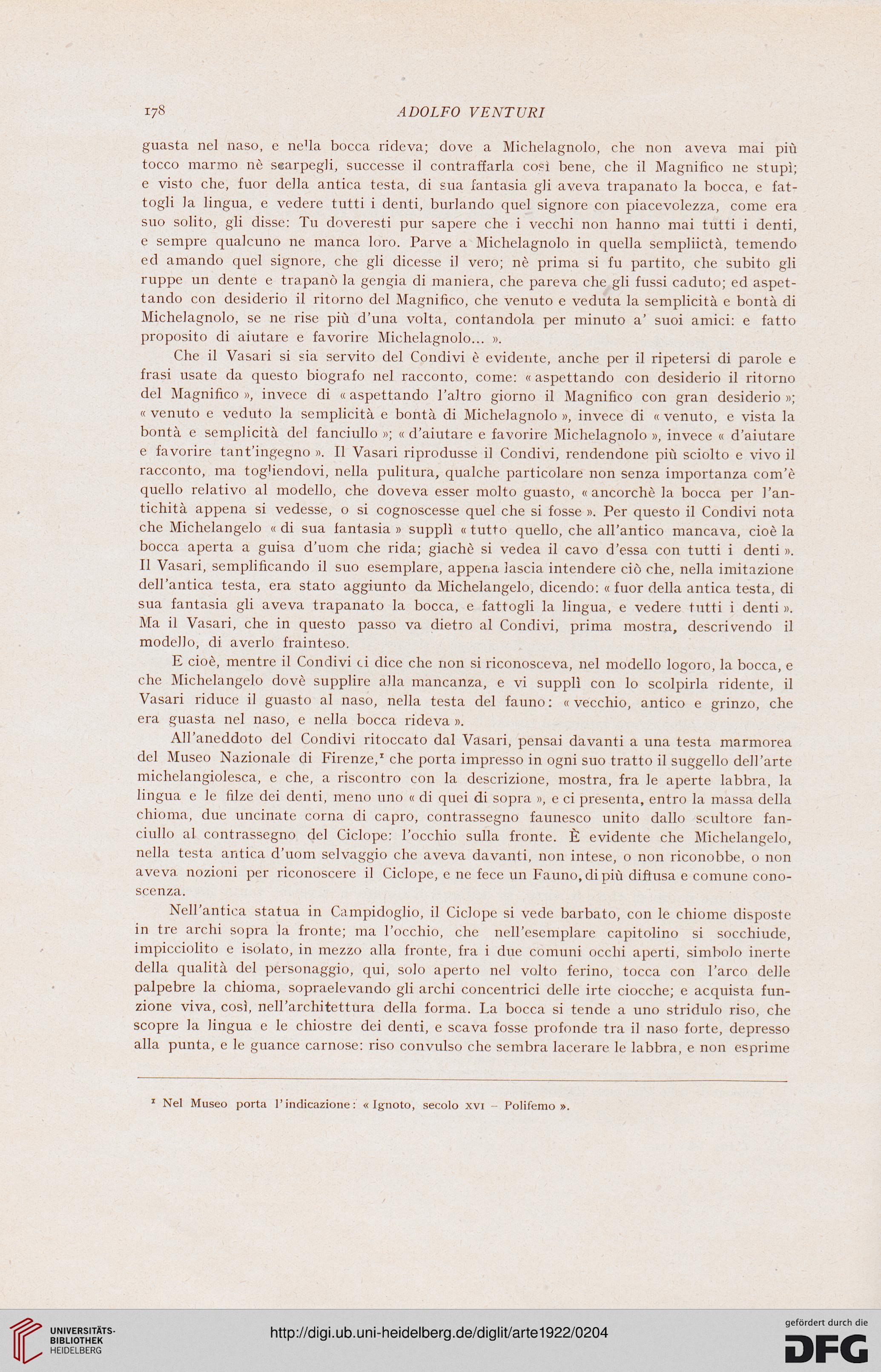178
ADOLFO VENTURI
guasta nel naso, e netta bocca rideva; dove a Michelagnolo, che non aveva mai più
tocco marmo nò s«arpegli, successe il contraffarla cosi bene, che il Magnifico ne stupì;
e visto che, fuor della antica testa, di sua fantasia gli aveva trapanato la bocca, e fat-
togli la lingua, c vedere tutti i denti, burlando quel signore con piacevolezza, come era
suo solito, gli disse: Tu doveresti pur sapere che i vecchi non hanno mai tutti i denti,
e sempre qualcuno ne manca loro. Parve a Michelagnolo in quella sempliictà, temendo
ed amando quel signore, che gli dicesse il vero; nè prima si fu partito, che subito gli
ruppe un dente e trapanò la gengia di maniera, che pareva che gli fussi caduto; ed aspet-
tando con desiderio il ritorno del Magnifico, che venuto e veduta la semplicità e bontà di
Michelagnolo, se ne rise più d'una volta, contandola per minuto a' suoi amici: e fatto
proposito di aiutare e favorire Michelagnolo... ».
Che il Vasari si sia servito del Condivi è evidente, anche per il ripetersi di parole e
frasi usate da questo biografo nel racconto, come: « aspettando con desiderio il ritorno
del Magnifico », invece di « aspettando l'altro giorno il Magnifico con gran desiderio »;
« venuto e veduto la semplicità e bontà di Michelagnolo », invece di « venuto, e vista la
bontà e semplicità del fanciullo »; « d'aiutare e favorire Michelagnolo », invece « d'aiutare
e favorire tant'ingegno ». Il Vasari riprodusse il Condivi, rendendone più sciolto e vivo il
racconto, ma tog'iendovi, nella pulitura, qualche particolare non senza importanza com'è
quello relativo al modello, che doveva esser molto guasto, «ancorché la bocca per l'an-
tichità appena si vedesse, o si cognoscesse quel che si fosse ». Per questo il Condivi nota
che Michelangelo « di sua fantasia » supplì « tutto quello, che all'antico mancava, cioè la
bocca aperta a guisa d'uom che rida; giachè si vedea il cavo d'essa con tutti i denti ».
Il Vasari, semplificando il suo esemplare, appena lascia intendere ciò che, nella imitazione
dell'antica testa, era stato aggiunto da Michelangelo, dicendo: « fuor della antica testa, di
sua fantasia gli aveva trapanato la bocca, e fattogli la lingua, e vedere tutti i denti ».
Ma il Vasari, che in questo passo va dietro al Condivi, prima mostra, descrivendo il
modello, di averlo frainteso.
E cioè, mentre il Condivi ci dice che non si riconosceva, nel modello logoro, la bocca, e
che Michelangelo dovè supplire alla mancanza, e vi supplì con lo scolpirla ridente, il
Vasari riduce il guasto al naso, nella testa del fauno: «vecchio, antico e grinzo, che
era guasta nel naso, e nella bocca rideva ».
All'aneddoto del Condivi ritoccato dal Vasari, pensai davanti a una testa marmorea
del Museo Nazionale di Firenze,1 che porta impresso in ogni suo tratto il suggello dell'arte
michelangiolesca, e che, a riscontro con la descrizione, mostra, fra le aperte labbra, la
lingua e le filze dei denti, meno uno « di quei di sopra », e ci presenta, entro la massa della
chioma, due uncinate corna di capro, contrassegno faunesco unito dallo scultore fan-
ciullo al contrassegno del Ciclope: l'occhio sulla fronte. È evidente che Michelangelo,
nella testa antica d'uom selvaggio che aveva davanti, non intese, o non riconobbe, o non
aveva nozioni per riconoscere il Ciclope, e ne fece un Fauno, di più diffusa e comune cono-
scenza.
Nell'antica statua in Campidoglio, il Ciclope si vede barbato, con le chiome disposte
in tre archi sopra la fronte; ma l'occhio, che nell'esemplare capitolino si socchiude,
impicciolito e isolato, in mezzo alla fronte, fra i due comuni occhi aperti, simbolo inerte
della qualità del personaggio, qui, solo aperto nel volto ferino, tocca con l'arco delle
palpebre la chioma, sopraelevando gli archi concentrici delle irte ciocche; e acquista fun-
zione viva, così, nell'architettura della forma. La bocca si tende a uno stridulo riso, che
scopre la lingua e le chiostre dei denti, e scava fosse profonde tra il naso forte, depresso
alla punta, e le guance carnose: riso convulso che sembra lacerare le labbra, e non esprime
1 Nel Museo porta l'indicazione: «Ignoto, secolo xvi - Polifemo ».
ADOLFO VENTURI
guasta nel naso, e netta bocca rideva; dove a Michelagnolo, che non aveva mai più
tocco marmo nò s«arpegli, successe il contraffarla cosi bene, che il Magnifico ne stupì;
e visto che, fuor della antica testa, di sua fantasia gli aveva trapanato la bocca, e fat-
togli la lingua, c vedere tutti i denti, burlando quel signore con piacevolezza, come era
suo solito, gli disse: Tu doveresti pur sapere che i vecchi non hanno mai tutti i denti,
e sempre qualcuno ne manca loro. Parve a Michelagnolo in quella sempliictà, temendo
ed amando quel signore, che gli dicesse il vero; nè prima si fu partito, che subito gli
ruppe un dente e trapanò la gengia di maniera, che pareva che gli fussi caduto; ed aspet-
tando con desiderio il ritorno del Magnifico, che venuto e veduta la semplicità e bontà di
Michelagnolo, se ne rise più d'una volta, contandola per minuto a' suoi amici: e fatto
proposito di aiutare e favorire Michelagnolo... ».
Che il Vasari si sia servito del Condivi è evidente, anche per il ripetersi di parole e
frasi usate da questo biografo nel racconto, come: « aspettando con desiderio il ritorno
del Magnifico », invece di « aspettando l'altro giorno il Magnifico con gran desiderio »;
« venuto e veduto la semplicità e bontà di Michelagnolo », invece di « venuto, e vista la
bontà e semplicità del fanciullo »; « d'aiutare e favorire Michelagnolo », invece « d'aiutare
e favorire tant'ingegno ». Il Vasari riprodusse il Condivi, rendendone più sciolto e vivo il
racconto, ma tog'iendovi, nella pulitura, qualche particolare non senza importanza com'è
quello relativo al modello, che doveva esser molto guasto, «ancorché la bocca per l'an-
tichità appena si vedesse, o si cognoscesse quel che si fosse ». Per questo il Condivi nota
che Michelangelo « di sua fantasia » supplì « tutto quello, che all'antico mancava, cioè la
bocca aperta a guisa d'uom che rida; giachè si vedea il cavo d'essa con tutti i denti ».
Il Vasari, semplificando il suo esemplare, appena lascia intendere ciò che, nella imitazione
dell'antica testa, era stato aggiunto da Michelangelo, dicendo: « fuor della antica testa, di
sua fantasia gli aveva trapanato la bocca, e fattogli la lingua, e vedere tutti i denti ».
Ma il Vasari, che in questo passo va dietro al Condivi, prima mostra, descrivendo il
modello, di averlo frainteso.
E cioè, mentre il Condivi ci dice che non si riconosceva, nel modello logoro, la bocca, e
che Michelangelo dovè supplire alla mancanza, e vi supplì con lo scolpirla ridente, il
Vasari riduce il guasto al naso, nella testa del fauno: «vecchio, antico e grinzo, che
era guasta nel naso, e nella bocca rideva ».
All'aneddoto del Condivi ritoccato dal Vasari, pensai davanti a una testa marmorea
del Museo Nazionale di Firenze,1 che porta impresso in ogni suo tratto il suggello dell'arte
michelangiolesca, e che, a riscontro con la descrizione, mostra, fra le aperte labbra, la
lingua e le filze dei denti, meno uno « di quei di sopra », e ci presenta, entro la massa della
chioma, due uncinate corna di capro, contrassegno faunesco unito dallo scultore fan-
ciullo al contrassegno del Ciclope: l'occhio sulla fronte. È evidente che Michelangelo,
nella testa antica d'uom selvaggio che aveva davanti, non intese, o non riconobbe, o non
aveva nozioni per riconoscere il Ciclope, e ne fece un Fauno, di più diffusa e comune cono-
scenza.
Nell'antica statua in Campidoglio, il Ciclope si vede barbato, con le chiome disposte
in tre archi sopra la fronte; ma l'occhio, che nell'esemplare capitolino si socchiude,
impicciolito e isolato, in mezzo alla fronte, fra i due comuni occhi aperti, simbolo inerte
della qualità del personaggio, qui, solo aperto nel volto ferino, tocca con l'arco delle
palpebre la chioma, sopraelevando gli archi concentrici delle irte ciocche; e acquista fun-
zione viva, così, nell'architettura della forma. La bocca si tende a uno stridulo riso, che
scopre la lingua e le chiostre dei denti, e scava fosse profonde tra il naso forte, depresso
alla punta, e le guance carnose: riso convulso che sembra lacerare le labbra, e non esprime
1 Nel Museo porta l'indicazione: «Ignoto, secolo xvi - Polifemo ».