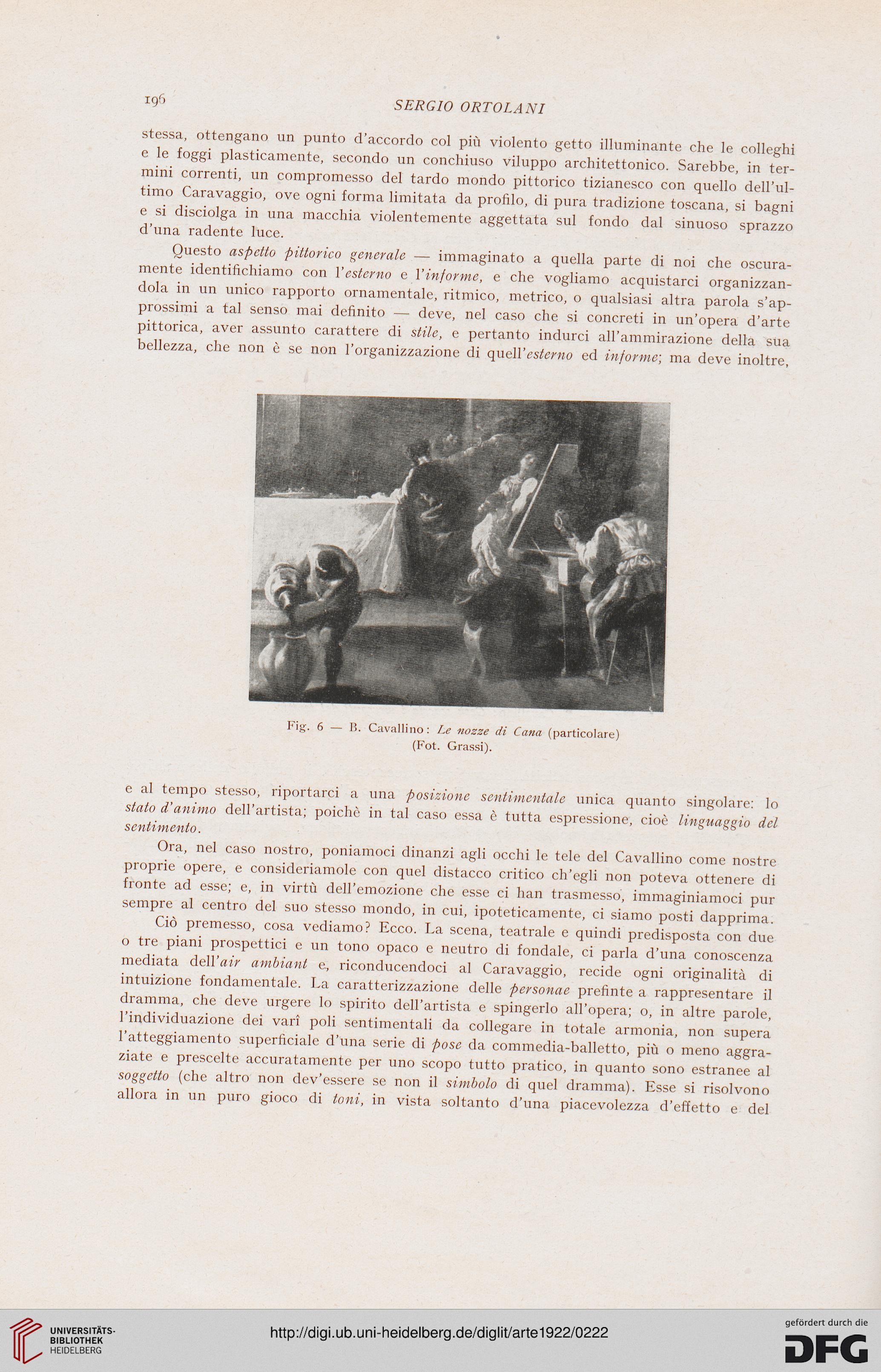SERGIO ORTOLANI
stessa, ottengano un punto d'accordo col più violento getto illuminante che le colleghi
e le foggi plasticamente, secondo un conchiuso viluppo architettonico. Sarebbe, in ter-
mini correnti, un compromesso del tardo mondo pittorico tizianesco con quello dell'ul-
timo Caravaggio, ove ogni forma limitata da profilo, di pura tradizione toscana, si bagni
e si disciolga in una macchia violentemente aggettata sul fondo dal sinuoso sprazzo
d'una radente luce.
Questo aspetto pittorico generale — immaginato a quella parte di noi che oscura-
mente identifichiamo con Yesterno e l'informe, e che vogliamo acquistarci organizzan-
dola in un unico rapporto ornamentale, ritmico, metrico, o qualsiasi altra parola s'ap-
prossimi a tal senso mai definito — deve, nel caso che si concreti in un'opera d'arte
pittorica, aver assunto carattere di stile, e pertanto indurci all'ammirazione della sua
bellezza, che non è se non l'organizzazione di quell'esterno ed in/orine; ma deve inoltre,
FÌ£. 6 — I?. Cavallino: Le nozze di Cuna (particolare)
(Fot. Grassi).
e al tempo stesso, riportarci a una posizione sentimentale unica quanto singolare: lo
stato d'animo dell'artista; poiché in tal caso essa è tutta espressione, cioè linguaggio del
sentimento.
Ora, nel caso nostro, poniamoci dinanzi agli occhi te tele del Cavallino come nostre
proprie opere, e consideriamole con quel distacco critico ch'egli non poteva ottenere di
fronte ad esse; e, in virtù dell'emozione che esse ci han trasmesso, immaginiamoci pur
sempre al centro del suo stesso mondo, in cui, ipoteticamente, ci siamo posti dapprima.
Ciò premesso, cosa vediamo? Ecco, ha scena, teatrale e quindi predisposta con due
o tre piani prospettici e un tono opaco e neutro di fondale, ci parla d'una conoscenza
mediata dell'air ambiant e, riconducendoci al Caravaggio, recide ogni originalità di
intuizione fondamentale. La caratterizzazione delle personae prefinte a rappresentare il
dramma, che deve urgere lo spirito dell'artista e spingerlo all'opera; o, in altre parole,
l'individuazione dei vari poli sentimentali da collegarc in totale armonia, non supera
l'atteggiamento superficiale d'una serie di pose da commedia-balletto, più o meno aggra-
ziate e prescelte accuratamente per uno scopo tutto pratico, in quanto sono estranee al
soggetto (che altro non dev'essere se non il simbolo di quel dramma). Esse si risolvono
allora in un puro gioco di toni, in vista soltanto d'una piacevolezza d'effetto e del
stessa, ottengano un punto d'accordo col più violento getto illuminante che le colleghi
e le foggi plasticamente, secondo un conchiuso viluppo architettonico. Sarebbe, in ter-
mini correnti, un compromesso del tardo mondo pittorico tizianesco con quello dell'ul-
timo Caravaggio, ove ogni forma limitata da profilo, di pura tradizione toscana, si bagni
e si disciolga in una macchia violentemente aggettata sul fondo dal sinuoso sprazzo
d'una radente luce.
Questo aspetto pittorico generale — immaginato a quella parte di noi che oscura-
mente identifichiamo con Yesterno e l'informe, e che vogliamo acquistarci organizzan-
dola in un unico rapporto ornamentale, ritmico, metrico, o qualsiasi altra parola s'ap-
prossimi a tal senso mai definito — deve, nel caso che si concreti in un'opera d'arte
pittorica, aver assunto carattere di stile, e pertanto indurci all'ammirazione della sua
bellezza, che non è se non l'organizzazione di quell'esterno ed in/orine; ma deve inoltre,
FÌ£. 6 — I?. Cavallino: Le nozze di Cuna (particolare)
(Fot. Grassi).
e al tempo stesso, riportarci a una posizione sentimentale unica quanto singolare: lo
stato d'animo dell'artista; poiché in tal caso essa è tutta espressione, cioè linguaggio del
sentimento.
Ora, nel caso nostro, poniamoci dinanzi agli occhi te tele del Cavallino come nostre
proprie opere, e consideriamole con quel distacco critico ch'egli non poteva ottenere di
fronte ad esse; e, in virtù dell'emozione che esse ci han trasmesso, immaginiamoci pur
sempre al centro del suo stesso mondo, in cui, ipoteticamente, ci siamo posti dapprima.
Ciò premesso, cosa vediamo? Ecco, ha scena, teatrale e quindi predisposta con due
o tre piani prospettici e un tono opaco e neutro di fondale, ci parla d'una conoscenza
mediata dell'air ambiant e, riconducendoci al Caravaggio, recide ogni originalità di
intuizione fondamentale. La caratterizzazione delle personae prefinte a rappresentare il
dramma, che deve urgere lo spirito dell'artista e spingerlo all'opera; o, in altre parole,
l'individuazione dei vari poli sentimentali da collegarc in totale armonia, non supera
l'atteggiamento superficiale d'una serie di pose da commedia-balletto, più o meno aggra-
ziate e prescelte accuratamente per uno scopo tutto pratico, in quanto sono estranee al
soggetto (che altro non dev'essere se non il simbolo di quel dramma). Esse si risolvono
allora in un puro gioco di toni, in vista soltanto d'una piacevolezza d'effetto e del