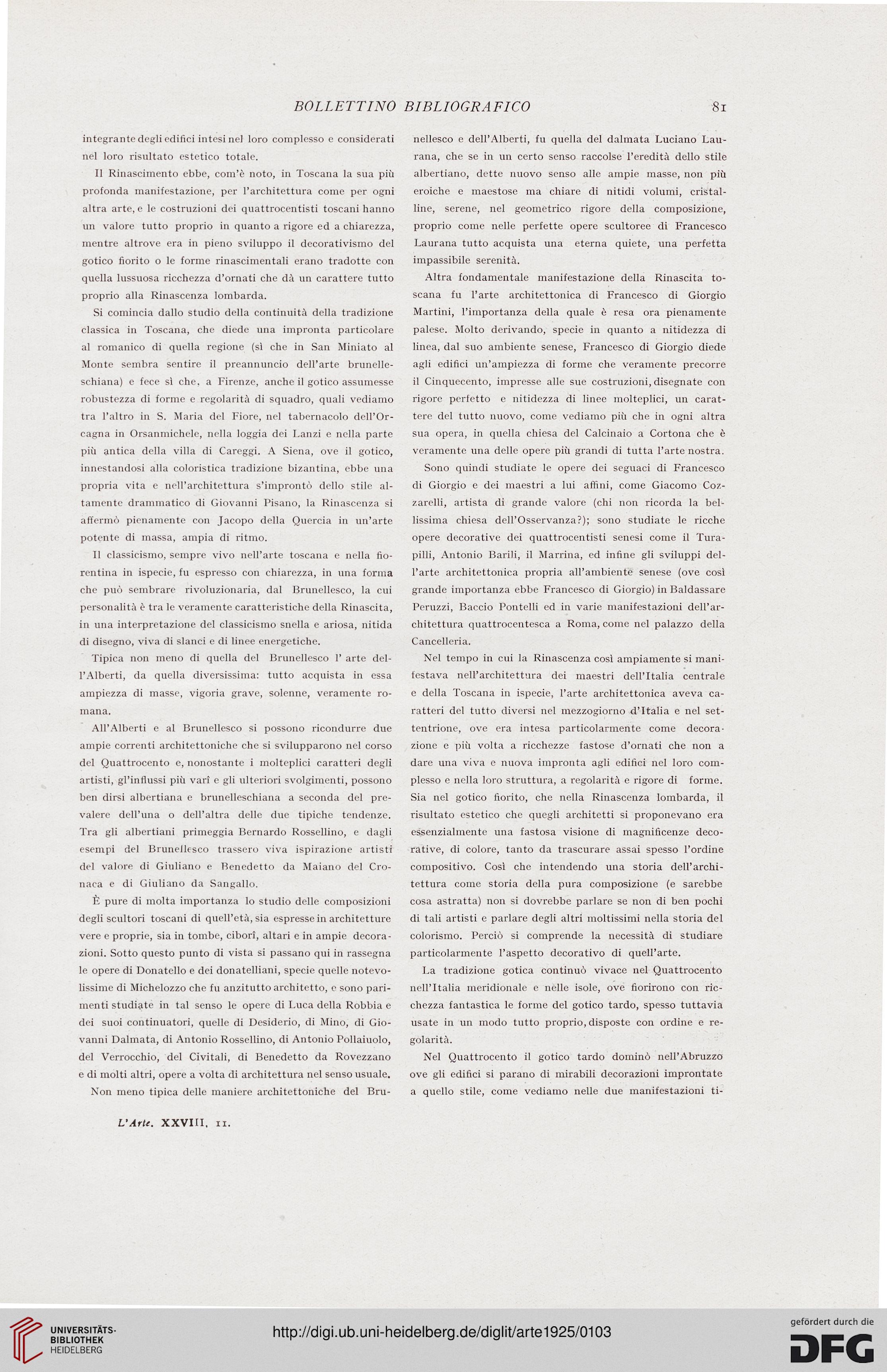BOLLETTINO BIBLLOGRAFICO
8l
integrante degli edifici intesine! loro complesso e considerati
nel loro risultato estetico totale.
Il Rinascimento ebbe, com'è noto, in Toscana la sua più
profonda manifestazione, per l'architettura come per ogni
altra arte, e le costruzioni dei quattrocentisti toscani hanno
un valore tutto proprio in quanto a rigore ed a chiarezza,
mentre altrove era in pieno sviluppo il decorativismo del
gotico fiorito o le forme rinascimentali erano tradotte con
quella lussuosa ricchezza d'ornati che dà un carattere tutto
proprio alla Rinascenza lombarda.
Si comincia dallo studio della continuità della tradizione
classica in Toscana, che diede una impronta particolare
al romanico di quella regione (si che in San Miniato al
Monte sembra sentire il preannuncio dell'arte brunelle-
schiana) e fece sì che. a Firenze, anche il gotico assumesse
robustezza di forme e regolarità di squadro, quali vediamo
tra l'altro in S. Maria del Fiore, nel tabernacolo dell'Or-
cagna in Orsanmichele, nella loggia dei Lanzi e nella parte
più antica della villa di Careggi. A Siena, ove il gotico,
innestandosi alla coloristica tradizione bizantina, ebbe una
propria vita e nell'architettura s'improntò dello stile al-
tamente drammatico di Giovanni Pisano, la Rinascenza si
affermò pienamente con Jacopo della Quercia in un'arte
potente di massa, ampia di ritmo.
Il classicismo, sempre vivo nell'arte toscana e nella fio-
rentina in ispecic, fu espresso con chiarezza, in una forma
che può sembrare rivoluzionaria, dal Brunellesco, la cui
personalità è tra le veramente caratteristiche della Rinascita,
in una interpretazione del classicismo snella e ariosa, nitida
di disegno, viva di slanci e di linee energetiche.
Tipica non meno di quella del Brunellesco 1' arte del-
l'Alberti, da quella diversissima: tutto acquista in essa
ampiezza di masse, vigoria grave, solenne, veramente ro-
mana.
All'Alberti e al Brunellesco si possono ricondurre due
ampie correnti architettoniche che si svilupparono nel corso
del Quattrocento e, nonostante i molteplici caratteri degli
artisti, gl'influssi più vari e gli ulteriori svolgimenti, possono
ben dirsi albertiana e brunelleschiana a seconda del pre-
valere dell'una o dell'altra delle due tipiche tendenze.
Tra gli albertiani primeggia Bernardo Rossellino, e dagli
esempi del Brunellesco trassero viva ispirazione artisti
del valore di Giuliano e Benedetto da Maiano del Cro-
naca e di Giuliano da Sangallo.
È pure di molta importanza lo studio delle composizioni
degli scultori toscani di quell'età, sia espresse in architetture
vere e proprie, sia in tombe, cibori, altari e in ampie decora-
zioni. Sotto questo punto di vista si passano qui in rassegna
le opere di Donatello e dei donatelliani, specie quelle notevo-
lissime di Michelozzo che fu anzitutto architetto, e sono pari-
menti studiate in tal senso le opere di Luca della Robbia e
dei suoi continuatori, quelle di Desiderio, di Mino, di Gio-
vanni Dalmata, di Antonio Rossellino, di Antonio Poliamolo,
del Verrocchio, del Civitali, di Benedetto da Rovezzano
e di molti altri, opere a volta di architettura nel senso usuale.
Non meno tipica delle maniere architettoniche del Bru-
nellesco e dell'Alberti, fu quella del dalmata Luciano Lau-
rana, che se in un certo senso raccolse l'eredità dello stile
albertiano, dette nuovo senso alle ampie masse, non più
eroiche e maestose ma chiare di nitidi volumi, cristal-
line, serene, nel geometrico rigore della composizione,
proprio come nelle perfette opere scultoree di Francesco
Laurana tutto acquista una eterna quiete, una perfetta
impassibile serenità.
Altra fondamentale manifestazione della Rinascita to-
scana fu l'arte architettonica di Francesco di Giorgio
Martini, l'importanza della quale è resa ora pienamente
palese. Molto derivando, specie in quanto a nitidezza di
linea, dal suo ambiente senese, Francesco di Giorgio diede
agli edifici un'ampiezza di forme che veramente precorre
il Cinquecento, impresse alle sue costruzioni, disegnate con
rigore perfetto e nitidezza di linee molteplici, un carat-
tere del tutto nuovo, come vediamo più che in ogni altra
sua opera, in quella chiesa del Calcinaio a Cortona che è
veramente una delle opere più grandi di tutta l'arte nostra.
Sono quindi studiate le opere dei seguaci di Francesco
di Giorgio e dei maestri a lui affini, come Giacomo Coz-
zarelli, artista di grande valore (chi non ricorda la bel-
lissima chiesa dell'Osservanza?); sono studiate le ricche
opere decorative dei quattrocentisti senesi come il Tura-
pilli, Antonio Barili, il Marrina, ed infine gli sviluppi del-
l'arte architettonica propria all'ambiente senese (ove così
grande importanza ebbe Francesco di Giorgio) in Baldassare
Peruzzi, Baccio Pontelli ed in varie manifestazioni dell'ar-
chitettura quattrocentesca a Roma, come nel palazzo della
Cancelleria.
Nel tempo in cui la Rinascenza così ampiamente si mani-
festava nell'architettura dei maestri dell'Italia centrale
e della Toscana in ispecie, l'arte architettonica aveva ca-
ratteri del tutto diversi nel mezzogiorno d'Italia e nel set-
tentrione, ove era intesa particolarmente come decora-
zione e più volta a ricchezze fastose d'ornati che non a
dare una viva e nuova impronta agli edifici nel loro com-
plesso e nella loro struttura, a regolarità e rigore di forme.
Sia nel gotico fiorito, che nella Rinascenza lombarda, il
risultato estetico che quegli architetti si proponevano era
essenzialmente una fastosa visione di magnificenze deco-
rative, di colore, tanto da trascurare assai spesso l'ordine
compositivo. Così che intendendo una storia dell'archi-
tettura come storia della pura composizione (e sarebbe
cosa astratta) non si dovrebbe parlare se non di ben pochi
di tali artisti e parlare degli altri moltissimi nella storia del
colorismo. Perciò si comprende la necessità di studiare
particolarmente l'aspetto decorativo di quell'arte.
La tradizione gotica continuò vivace nel Quattrocento
nell'Italia meridionale e nelle isole, ove fiorirono con ric-
chezza fantastica le forme del gotico tardo, spesso tuttavia
usate in un modo tutto proprio, disposte con ordine e re-
golarità.
Nel Quattrocento il gotico tardo dominò nell'Abruzzo
ove gli edifici si parano di mirabili decorazioni improntate
a quello stile, come vediamo nelle due manifestazioni ti-
VArte. XXVIII, 11.
8l
integrante degli edifici intesine! loro complesso e considerati
nel loro risultato estetico totale.
Il Rinascimento ebbe, com'è noto, in Toscana la sua più
profonda manifestazione, per l'architettura come per ogni
altra arte, e le costruzioni dei quattrocentisti toscani hanno
un valore tutto proprio in quanto a rigore ed a chiarezza,
mentre altrove era in pieno sviluppo il decorativismo del
gotico fiorito o le forme rinascimentali erano tradotte con
quella lussuosa ricchezza d'ornati che dà un carattere tutto
proprio alla Rinascenza lombarda.
Si comincia dallo studio della continuità della tradizione
classica in Toscana, che diede una impronta particolare
al romanico di quella regione (si che in San Miniato al
Monte sembra sentire il preannuncio dell'arte brunelle-
schiana) e fece sì che. a Firenze, anche il gotico assumesse
robustezza di forme e regolarità di squadro, quali vediamo
tra l'altro in S. Maria del Fiore, nel tabernacolo dell'Or-
cagna in Orsanmichele, nella loggia dei Lanzi e nella parte
più antica della villa di Careggi. A Siena, ove il gotico,
innestandosi alla coloristica tradizione bizantina, ebbe una
propria vita e nell'architettura s'improntò dello stile al-
tamente drammatico di Giovanni Pisano, la Rinascenza si
affermò pienamente con Jacopo della Quercia in un'arte
potente di massa, ampia di ritmo.
Il classicismo, sempre vivo nell'arte toscana e nella fio-
rentina in ispecic, fu espresso con chiarezza, in una forma
che può sembrare rivoluzionaria, dal Brunellesco, la cui
personalità è tra le veramente caratteristiche della Rinascita,
in una interpretazione del classicismo snella e ariosa, nitida
di disegno, viva di slanci e di linee energetiche.
Tipica non meno di quella del Brunellesco 1' arte del-
l'Alberti, da quella diversissima: tutto acquista in essa
ampiezza di masse, vigoria grave, solenne, veramente ro-
mana.
All'Alberti e al Brunellesco si possono ricondurre due
ampie correnti architettoniche che si svilupparono nel corso
del Quattrocento e, nonostante i molteplici caratteri degli
artisti, gl'influssi più vari e gli ulteriori svolgimenti, possono
ben dirsi albertiana e brunelleschiana a seconda del pre-
valere dell'una o dell'altra delle due tipiche tendenze.
Tra gli albertiani primeggia Bernardo Rossellino, e dagli
esempi del Brunellesco trassero viva ispirazione artisti
del valore di Giuliano e Benedetto da Maiano del Cro-
naca e di Giuliano da Sangallo.
È pure di molta importanza lo studio delle composizioni
degli scultori toscani di quell'età, sia espresse in architetture
vere e proprie, sia in tombe, cibori, altari e in ampie decora-
zioni. Sotto questo punto di vista si passano qui in rassegna
le opere di Donatello e dei donatelliani, specie quelle notevo-
lissime di Michelozzo che fu anzitutto architetto, e sono pari-
menti studiate in tal senso le opere di Luca della Robbia e
dei suoi continuatori, quelle di Desiderio, di Mino, di Gio-
vanni Dalmata, di Antonio Rossellino, di Antonio Poliamolo,
del Verrocchio, del Civitali, di Benedetto da Rovezzano
e di molti altri, opere a volta di architettura nel senso usuale.
Non meno tipica delle maniere architettoniche del Bru-
nellesco e dell'Alberti, fu quella del dalmata Luciano Lau-
rana, che se in un certo senso raccolse l'eredità dello stile
albertiano, dette nuovo senso alle ampie masse, non più
eroiche e maestose ma chiare di nitidi volumi, cristal-
line, serene, nel geometrico rigore della composizione,
proprio come nelle perfette opere scultoree di Francesco
Laurana tutto acquista una eterna quiete, una perfetta
impassibile serenità.
Altra fondamentale manifestazione della Rinascita to-
scana fu l'arte architettonica di Francesco di Giorgio
Martini, l'importanza della quale è resa ora pienamente
palese. Molto derivando, specie in quanto a nitidezza di
linea, dal suo ambiente senese, Francesco di Giorgio diede
agli edifici un'ampiezza di forme che veramente precorre
il Cinquecento, impresse alle sue costruzioni, disegnate con
rigore perfetto e nitidezza di linee molteplici, un carat-
tere del tutto nuovo, come vediamo più che in ogni altra
sua opera, in quella chiesa del Calcinaio a Cortona che è
veramente una delle opere più grandi di tutta l'arte nostra.
Sono quindi studiate le opere dei seguaci di Francesco
di Giorgio e dei maestri a lui affini, come Giacomo Coz-
zarelli, artista di grande valore (chi non ricorda la bel-
lissima chiesa dell'Osservanza?); sono studiate le ricche
opere decorative dei quattrocentisti senesi come il Tura-
pilli, Antonio Barili, il Marrina, ed infine gli sviluppi del-
l'arte architettonica propria all'ambiente senese (ove così
grande importanza ebbe Francesco di Giorgio) in Baldassare
Peruzzi, Baccio Pontelli ed in varie manifestazioni dell'ar-
chitettura quattrocentesca a Roma, come nel palazzo della
Cancelleria.
Nel tempo in cui la Rinascenza così ampiamente si mani-
festava nell'architettura dei maestri dell'Italia centrale
e della Toscana in ispecie, l'arte architettonica aveva ca-
ratteri del tutto diversi nel mezzogiorno d'Italia e nel set-
tentrione, ove era intesa particolarmente come decora-
zione e più volta a ricchezze fastose d'ornati che non a
dare una viva e nuova impronta agli edifici nel loro com-
plesso e nella loro struttura, a regolarità e rigore di forme.
Sia nel gotico fiorito, che nella Rinascenza lombarda, il
risultato estetico che quegli architetti si proponevano era
essenzialmente una fastosa visione di magnificenze deco-
rative, di colore, tanto da trascurare assai spesso l'ordine
compositivo. Così che intendendo una storia dell'archi-
tettura come storia della pura composizione (e sarebbe
cosa astratta) non si dovrebbe parlare se non di ben pochi
di tali artisti e parlare degli altri moltissimi nella storia del
colorismo. Perciò si comprende la necessità di studiare
particolarmente l'aspetto decorativo di quell'arte.
La tradizione gotica continuò vivace nel Quattrocento
nell'Italia meridionale e nelle isole, ove fiorirono con ric-
chezza fantastica le forme del gotico tardo, spesso tuttavia
usate in un modo tutto proprio, disposte con ordine e re-
golarità.
Nel Quattrocento il gotico tardo dominò nell'Abruzzo
ove gli edifici si parano di mirabili decorazioni improntate
a quello stile, come vediamo nelle due manifestazioni ti-
VArte. XXVIII, 11.