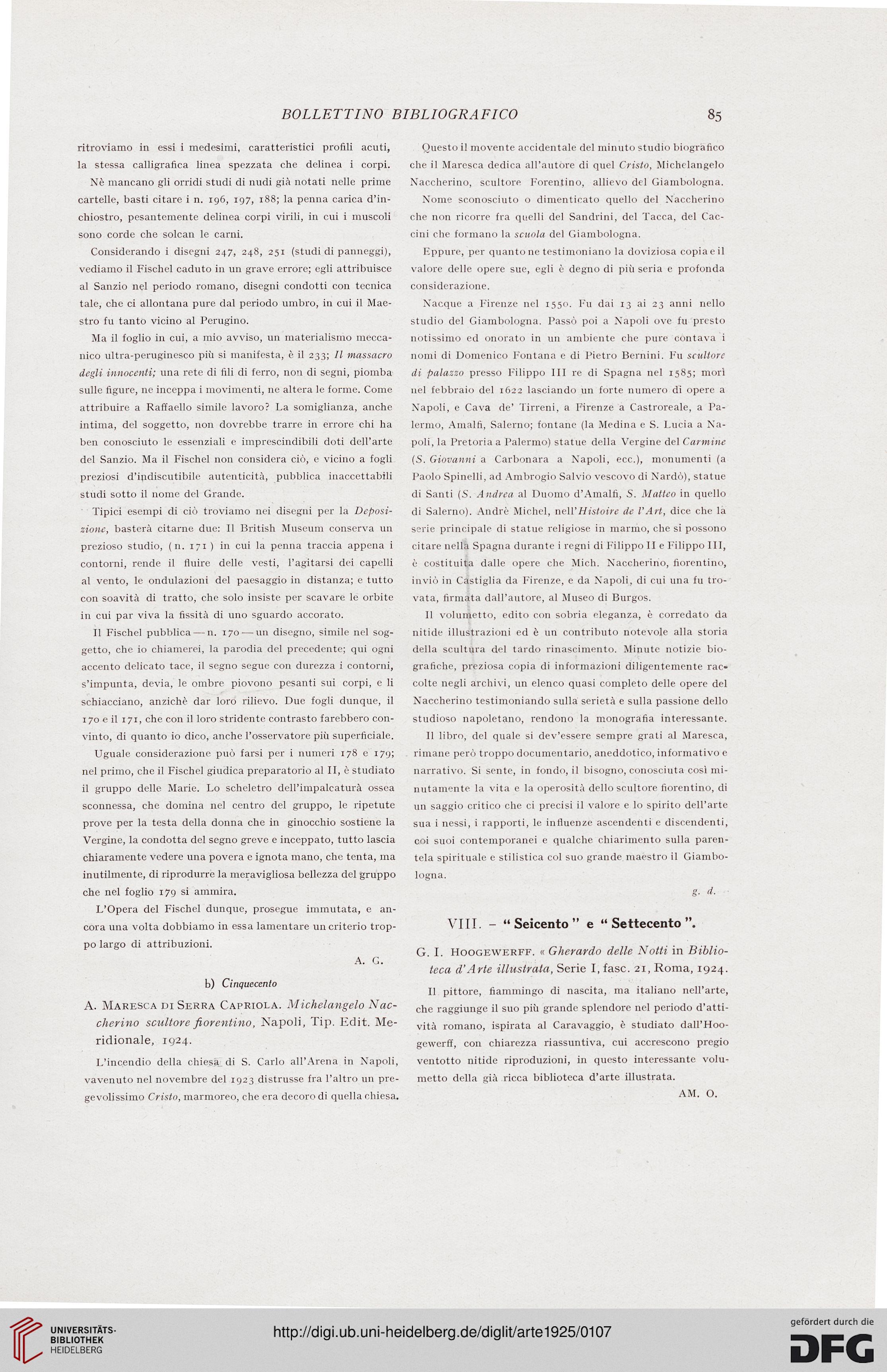BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
85
ritroviamo in essi i medesimi, caratteristici profili acuti,
la stessa calligrafica linea spezzata che delinea i corpi.
Nè mancano gli orridi studi di nudi già notati nelle prime
cartelle, basti citare i n. 196, 197, 188; la penna carica d'in-
chiostro, pesantemente delinea corpi virili, in cui i muscoli
sono corde che solcan le carni.
Considerando i disegni 247, 248, 251 (studi di panneggi),
vediamo il Fischel caduto in un grave errore; egli attribuisce
al Sanzio nel periodo romano, disegni condotti con tecnica
tale, che ci allontana pure dal periodo umbro, in cui il Mae-
stro fu tanto vicino al Perugino.
Ma il foglio in cui, a mio avviso, un materialismo mecca-
nico ultra-peruginesco più si manifesta, è il 233; // massacro
degli innocenti; una rete di fili di ferro, non di segni, piomba
sulle figure, ne inceppa i movimenti, ne altera le forme. Come
attribuire a Raffaello simile lavoro? La somiglianza, anche
intima, del soggetto, non dovrebbe trarre in errore chi ha
ben conosciuto le essenziali e imprescindibili doti dell'arte
del Sanzio. Ma il Fischel non considera ciò, e vicino a fogli
preziosi d'indiscutibile autenticità, pubblica inaccettabili
studi sotto il nome del Grande.
Tipici esempi di ciò troviamo nei disegni per la Deposi-
zione, basterà citarne due: Il British Museum conserva un
prezioso studio, (n. 171 ) in cui la penna traccia appena i
contorni, rende il fluire delle vesti, l'agitarsi dei capelli
al vento, le ondulazioni del paesaggio in distanza; e tutto
con soavità di tratto, che solo insiste per scavare le orbite
in cui par viva la fissità di uno sguardo accorato.
Il Fischel pubblica — n. 170 — un disegno, simile nel sog-
getto, che io chiamerei, la parodia del precedente; qui ogni
accento delicato tace, il segno segue con durezza i contorni,
s'impunta, devia, le ombre piovono pesanti sui corpi, e li
schiacciano, anziché dar loro rilievo. Due fogli dunque, il
170 e il 171, che con il loro stridente contrasto farebbero con-
vinto, di quanto io dico, anche l'osservatore più superficiale.
Uguale considerazione può farsi per i numeri 178 e 179;
nel primo, che il Fischel giudica preparatorio al II, è studiato
il gruppo delle Marie. Lo scheletro dell'impalcaturà ossea
sconnessa, che domina nel centro del gruppo, le ripetute
prove per la testa della donna che in ginocchio sostiene la
Vergine, la condotta del segno greve e inceppato, tutto lascia
chiaramente vedere una povera e ignota mano, che tenta, ma
inutilmente, di riprodurre la meravigliosa bellezza del gruppo
che nel foglio 179 si ammira.
L'Opera del Fischel dunque, prosegue immutata, e an-
cora una volta dobbiamo in essa lamentare un criterio trop-
po largo di attribuzioni.
a. <;.
b) Cinquecento
A. Maresca di Serra Capriola. Michelangelo Nac-
cherino scultore fiorentino, Napoli, Tip. Edit. Me-
ridionale, 1924.
L'incendio della chiesa_ di S. Carlo all'Arena in Napoli,
vavenuto nel novembre del 1923 distrusse fra l'altro un pre-
gevolissimo Cristo, marmoreo, che era decoro di quella chiesa.
Questo il movente accidentale del minuto studio biografico
che il Maresca dedica all'autóre di quel Cristo, Michelangelo
Naccherino, scultore Forentino, allievo del Giambologna.
Nome sconosciuto o dimenticato quello del Naccherino
che non ricorre fra quelli del Sandrini, del Tacca, del Cac-
cini che formano la scitola del Giambologna.
Eppure, per quanto ne testimoniano la doviziosa copia e il
valore delle opere sue, egli è degno di più seria e profonda
considerazione.
Nacque a Firenze nel 1550. Fu dai 13 ai 23 anni nello
studio del Giambologna. Passò poi a Napoli ove fu presto
untissimo ed (inorato in un ambiente che pure contava i
nomi di Domenico Fontana e di Pietro Bernini. Fu scultore
di palazzo presso Filippo III re di Spagna nel 1585; morì
nel febbraio del 1622 lasciando un forte numero di opere a
Napoli, e Cava de' Tirreni, a Firenze a Castroreale, a Pa-
lermo, Amalfi, Salerno; fontane (la Medina e S. Lucia a Na-
poli, la Pretoria a Palermo) statue della Vergine del Carmine
(S. Giovanni a Carbonara a Napoli, ecc.), monumenti (a
Paolo Spinelli, ad Ambrogio Salvio vescovo di Nardo), statue
di Santi (S. Andrea al Dui uno d'Amalfi, S. Matteo in quello
di Salerno). Andrò Michel, nvll'Histoire de l'Art, dice che la
serie principale di statue religiose in marmo, che si possono
citare nella Spagna durante i regni di Filippo Ile Filippo III,
è costituita dalle opere che Mich. Naccherino, fiorentino,
inviò in Castiglia da Firenze, e da Napoli, di cui una fu tro-
vata, firmata dall'autore, al Museo di Burgos.
Il volumetto, edito con sobria eleganza, è corredato da
nitide illustrazioni ed è un contributo notevole alla storia
della scultura del tardo rinascimento. Minute notizie bio-
grafiche, preziosa copia di informazioni diligentemente rac-
colte negli archivi, un elenco quasi completo delle opere del
Naccherino testimoniando sulla serietà e sulla passione dello
studioso napoletano, rendono la monografia interessante.
11 libro, del quale si dev'essere sempre grati al Maresca,
rimane però troppo documentario, aneddotico, informativo e
narrativo. Si sente, in fondo, il bisogno, conosciuta così mi-
nutamente la vita e la operosità dello scultore fiorentino, di
un saggio critico che ci precisi il valore e lo spirito dell'arte
sua i nessi, i rapporti, le influenze ascendenti e discendenti,
coi suoi contemporanei e qualche chiarimento sulla paren-
tela spirituale e stilistica col suo grande maestro il Giambo-
logna.
g. d.
Vili. - "Seicento" e "Settecento".
G. I. Hoogewerff. « Gherardo delle Notti in Biblio-
teca d'Arte illustrata, Serie I, fase. 21, Roma, 1924.
Il pittore, fiammingo di nascita, ma italiano nell'arte,
che raggiunge il suo più grande splendore nel periodo d'atti-
vità romano, ispirata al Caravaggio, è studiato dall'Hoo-
gewerff, con chiarezza riassuntiva, cui accrescono pregio
ventotto nitide riproduzioni, in questo interessante, volu-
metto della già ricca biblioteca d'arte illustrata.
AM. O.
85
ritroviamo in essi i medesimi, caratteristici profili acuti,
la stessa calligrafica linea spezzata che delinea i corpi.
Nè mancano gli orridi studi di nudi già notati nelle prime
cartelle, basti citare i n. 196, 197, 188; la penna carica d'in-
chiostro, pesantemente delinea corpi virili, in cui i muscoli
sono corde che solcan le carni.
Considerando i disegni 247, 248, 251 (studi di panneggi),
vediamo il Fischel caduto in un grave errore; egli attribuisce
al Sanzio nel periodo romano, disegni condotti con tecnica
tale, che ci allontana pure dal periodo umbro, in cui il Mae-
stro fu tanto vicino al Perugino.
Ma il foglio in cui, a mio avviso, un materialismo mecca-
nico ultra-peruginesco più si manifesta, è il 233; // massacro
degli innocenti; una rete di fili di ferro, non di segni, piomba
sulle figure, ne inceppa i movimenti, ne altera le forme. Come
attribuire a Raffaello simile lavoro? La somiglianza, anche
intima, del soggetto, non dovrebbe trarre in errore chi ha
ben conosciuto le essenziali e imprescindibili doti dell'arte
del Sanzio. Ma il Fischel non considera ciò, e vicino a fogli
preziosi d'indiscutibile autenticità, pubblica inaccettabili
studi sotto il nome del Grande.
Tipici esempi di ciò troviamo nei disegni per la Deposi-
zione, basterà citarne due: Il British Museum conserva un
prezioso studio, (n. 171 ) in cui la penna traccia appena i
contorni, rende il fluire delle vesti, l'agitarsi dei capelli
al vento, le ondulazioni del paesaggio in distanza; e tutto
con soavità di tratto, che solo insiste per scavare le orbite
in cui par viva la fissità di uno sguardo accorato.
Il Fischel pubblica — n. 170 — un disegno, simile nel sog-
getto, che io chiamerei, la parodia del precedente; qui ogni
accento delicato tace, il segno segue con durezza i contorni,
s'impunta, devia, le ombre piovono pesanti sui corpi, e li
schiacciano, anziché dar loro rilievo. Due fogli dunque, il
170 e il 171, che con il loro stridente contrasto farebbero con-
vinto, di quanto io dico, anche l'osservatore più superficiale.
Uguale considerazione può farsi per i numeri 178 e 179;
nel primo, che il Fischel giudica preparatorio al II, è studiato
il gruppo delle Marie. Lo scheletro dell'impalcaturà ossea
sconnessa, che domina nel centro del gruppo, le ripetute
prove per la testa della donna che in ginocchio sostiene la
Vergine, la condotta del segno greve e inceppato, tutto lascia
chiaramente vedere una povera e ignota mano, che tenta, ma
inutilmente, di riprodurre la meravigliosa bellezza del gruppo
che nel foglio 179 si ammira.
L'Opera del Fischel dunque, prosegue immutata, e an-
cora una volta dobbiamo in essa lamentare un criterio trop-
po largo di attribuzioni.
a. <;.
b) Cinquecento
A. Maresca di Serra Capriola. Michelangelo Nac-
cherino scultore fiorentino, Napoli, Tip. Edit. Me-
ridionale, 1924.
L'incendio della chiesa_ di S. Carlo all'Arena in Napoli,
vavenuto nel novembre del 1923 distrusse fra l'altro un pre-
gevolissimo Cristo, marmoreo, che era decoro di quella chiesa.
Questo il movente accidentale del minuto studio biografico
che il Maresca dedica all'autóre di quel Cristo, Michelangelo
Naccherino, scultore Forentino, allievo del Giambologna.
Nome sconosciuto o dimenticato quello del Naccherino
che non ricorre fra quelli del Sandrini, del Tacca, del Cac-
cini che formano la scitola del Giambologna.
Eppure, per quanto ne testimoniano la doviziosa copia e il
valore delle opere sue, egli è degno di più seria e profonda
considerazione.
Nacque a Firenze nel 1550. Fu dai 13 ai 23 anni nello
studio del Giambologna. Passò poi a Napoli ove fu presto
untissimo ed (inorato in un ambiente che pure contava i
nomi di Domenico Fontana e di Pietro Bernini. Fu scultore
di palazzo presso Filippo III re di Spagna nel 1585; morì
nel febbraio del 1622 lasciando un forte numero di opere a
Napoli, e Cava de' Tirreni, a Firenze a Castroreale, a Pa-
lermo, Amalfi, Salerno; fontane (la Medina e S. Lucia a Na-
poli, la Pretoria a Palermo) statue della Vergine del Carmine
(S. Giovanni a Carbonara a Napoli, ecc.), monumenti (a
Paolo Spinelli, ad Ambrogio Salvio vescovo di Nardo), statue
di Santi (S. Andrea al Dui uno d'Amalfi, S. Matteo in quello
di Salerno). Andrò Michel, nvll'Histoire de l'Art, dice che la
serie principale di statue religiose in marmo, che si possono
citare nella Spagna durante i regni di Filippo Ile Filippo III,
è costituita dalle opere che Mich. Naccherino, fiorentino,
inviò in Castiglia da Firenze, e da Napoli, di cui una fu tro-
vata, firmata dall'autore, al Museo di Burgos.
Il volumetto, edito con sobria eleganza, è corredato da
nitide illustrazioni ed è un contributo notevole alla storia
della scultura del tardo rinascimento. Minute notizie bio-
grafiche, preziosa copia di informazioni diligentemente rac-
colte negli archivi, un elenco quasi completo delle opere del
Naccherino testimoniando sulla serietà e sulla passione dello
studioso napoletano, rendono la monografia interessante.
11 libro, del quale si dev'essere sempre grati al Maresca,
rimane però troppo documentario, aneddotico, informativo e
narrativo. Si sente, in fondo, il bisogno, conosciuta così mi-
nutamente la vita e la operosità dello scultore fiorentino, di
un saggio critico che ci precisi il valore e lo spirito dell'arte
sua i nessi, i rapporti, le influenze ascendenti e discendenti,
coi suoi contemporanei e qualche chiarimento sulla paren-
tela spirituale e stilistica col suo grande maestro il Giambo-
logna.
g. d.
Vili. - "Seicento" e "Settecento".
G. I. Hoogewerff. « Gherardo delle Notti in Biblio-
teca d'Arte illustrata, Serie I, fase. 21, Roma, 1924.
Il pittore, fiammingo di nascita, ma italiano nell'arte,
che raggiunge il suo più grande splendore nel periodo d'atti-
vità romano, ispirata al Caravaggio, è studiato dall'Hoo-
gewerff, con chiarezza riassuntiva, cui accrescono pregio
ventotto nitide riproduzioni, in questo interessante, volu-
metto della già ricca biblioteca d'arte illustrata.
AM. O.