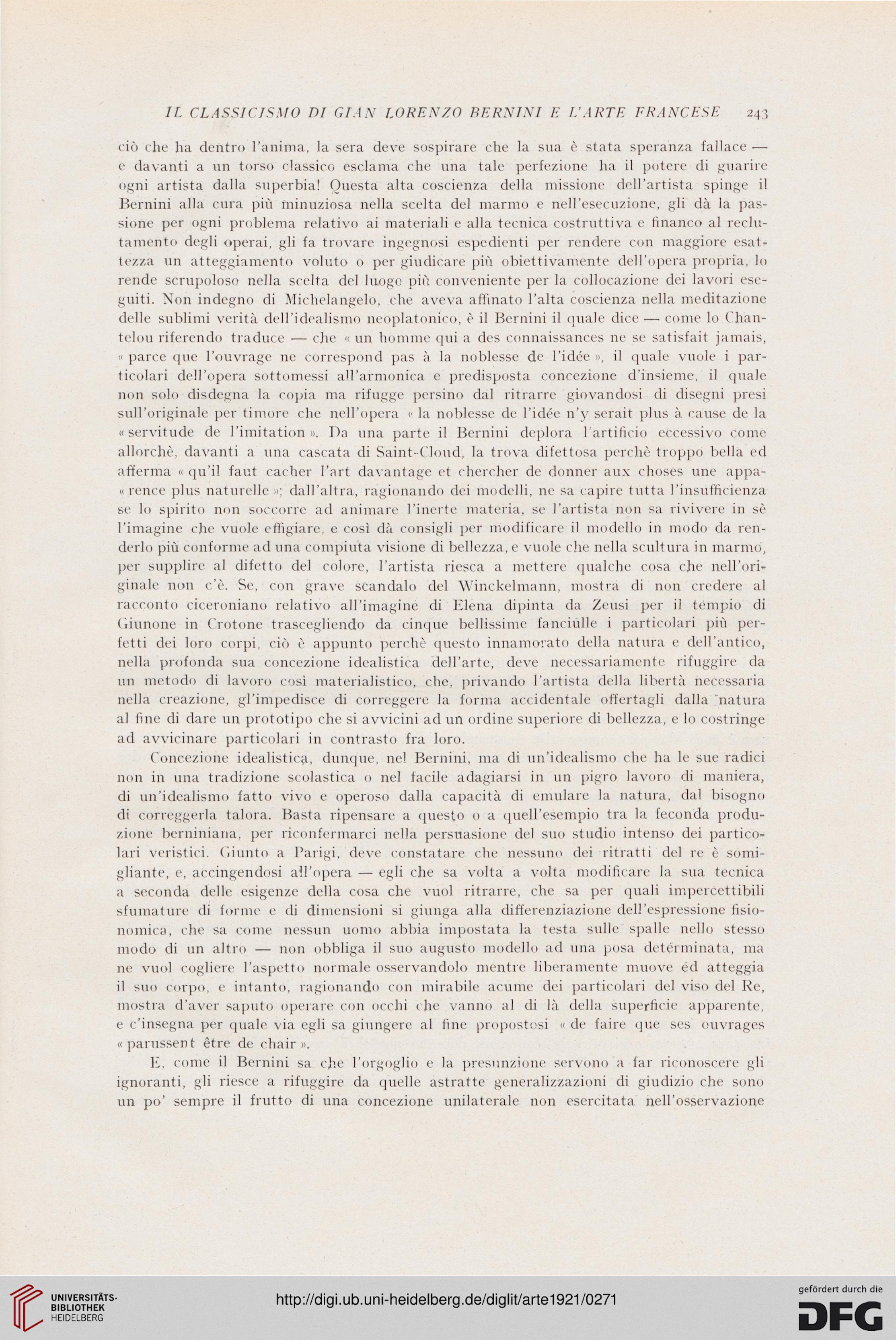IL CLASSICISMO DI GIAN LORENZO BERNINI E L'ARTE FRANCESE 243
ciò che ha dentro l'anima, la sera deve sospirare che la sua è stata speranza fallare —
e davanti a un torso c lassico esclama che una tale perfezione ha il potere di guarire
ogni artista dalla superbia! Onesta alta coscienza della missione dell'artista spinge il
Bernini alla cura più minuziosa nella scelta del marmo e nell'esecuzione, gli dà la pas-
sione per ogni problema relativo ai materiali e alla tecnica costruttiva e (manco al reclu-
tamento degli operai, gli fa trovare ingegnosi espedienti per rendere con maggiore esat-
tezza un atteggiamento voluto 0 per giudicare più obiettivamente dell'opera propria, lo
rende scrupoloso nella scelta del luogo più conveniente per la collocazione dei lavori ese-
guiti. Non indegno di Michelangelo, che aveva affinato l'alta coscienza nella meditazione
delle sublimi verità dell'idealismo neoplatonico, è il Bernini il quale dice — come lo Chàn-
telou riferendo traduce ■— che « un homme qui a des connaissances ne se satisfait jamais,
« parco (pie l'ouvrage ne correspond pas à la noblesse de l'idée », il quale vuole i par-
ticolari dell'opera sottomessi all'armonica e predisposta concezione d'insieme, il quale
non solo disdegna la copia ma rifugge persino dal ritrarre giovandosi di disegni presi
sull'originale per timore che nell'opera e la noblesse de l'idée n'v serait plus à cause de la
« servitude de l'imitation ». Da una parte il Bernini deplora l'artificio eccessivo come
allorché, davanti a una casc ata di Saint-Cloud, la trova difettosa perchè troppo bella ed
afferma « qu'il faut cacher l'art davantage et chercher de donner aux choses une appa-
« ronco plus naturelle <: dall'altra, ragionando dei modelli, ne sa c apire tutta l'insufficienza
se lo spirito non soccorre ad animare l'inerte materia, se l'artista non sa rivivere in sè
l'imagine che vuole effigiare, e così dà consigli per modificare il modello in modo da ren-
derlo più conforme ad una compiuta visione di bellezza, e vuole che nella scultura in marmo
per supplire al difetto del colore, l'artista riesca a mettere qualche cosa che nell'ori-
ginale non c'è. Se, con grave scandalo del Winckelmann, mostra di non credere al
racconto ciceroniano relativo all'indagine di Elena dipinta da Zeusi per il tèmpio di
Giunone in Crotone trascegliendo da cinque bellissime fanciulle i particolari più per-
fetti dei loro corpi, ciò è appunto perchè questo innamorato della natura e dell'antico,
nella profonda sua concezione idealistica dell'arte, deve necessariamente rifuggire da
un metodo di lavoro così materialistico, che. privando l'artista della libertà necessaria
nella creazione, gl'impedisce di correggere la forma accidentale offertagli dalla "natura
al fine di dare un prototipo che si avvicini ad un ordine superiore di bellezza, e lo costringe
ad avvicinare particolari in contrasto fra loro.
Concezione idealistica, dunque, ne' Bernini, ma di un'idealismo che ha le sue radici
non in una tradizione scolastica 0 nel tacile adagiarsi in un pagro lavoro eli manièra,
di un'idealismo fatto vivo e operoso dalla capacità di emulali' la natura, dal bisogno
di correggerla talora. Basta ripensare a questo 0 a quell'esempio tra la feconda produ-
zione berniniana, per riconfermarci nella persuasione del suo studio intenso dei partico-
lari veristici. Giunto a Parigi, deve constatali- che nessuno dei ritratti del re è somi-
gliante, e, accingendosi all'opera — egli che sa volta a volta modificare la sua tecnica
a sei-onda delle esigenze della cosa che vuol ritrarre, che sa per quali impercettibili
sfumature di forme e di dimensioni si giunga alla differenziazione dell'espressioni- fisio-
nomica, che sa come nessun uomo abbia impostata la testa sulle spalle nello stesso
modo di un altro — non obbliga il suo augusto modello ad una -posa determinata, ma
ne vuol cogliere l'aspetto normale osservandolo mentre liberamente muove ed atteggia
il suo corpo, e intanto, ragionando con mirabile acume dei particolari del viso del Re,
mostra d'aver saputo operare con occhi ilio vanno al di là della superficie apparente,
e c'insegna per quale via egli sa giungere al line propostesi « de fai re que ses ouvrages
«parussent ótre de chair».
E, come il Bernini sa che l'orgoglio e la presunzione servono a far riconoscere gli
ignoranti, gli riesce a rifuggire da quelle astratte generalizzazioni di giudizio che sono
un po' sempre il frutto di una concezione unilaterale non esercitata nell'osservazione
ciò che ha dentro l'anima, la sera deve sospirare che la sua è stata speranza fallare —
e davanti a un torso c lassico esclama che una tale perfezione ha il potere di guarire
ogni artista dalla superbia! Onesta alta coscienza della missione dell'artista spinge il
Bernini alla cura più minuziosa nella scelta del marmo e nell'esecuzione, gli dà la pas-
sione per ogni problema relativo ai materiali e alla tecnica costruttiva e (manco al reclu-
tamento degli operai, gli fa trovare ingegnosi espedienti per rendere con maggiore esat-
tezza un atteggiamento voluto 0 per giudicare più obiettivamente dell'opera propria, lo
rende scrupoloso nella scelta del luogo più conveniente per la collocazione dei lavori ese-
guiti. Non indegno di Michelangelo, che aveva affinato l'alta coscienza nella meditazione
delle sublimi verità dell'idealismo neoplatonico, è il Bernini il quale dice — come lo Chàn-
telou riferendo traduce ■— che « un homme qui a des connaissances ne se satisfait jamais,
« parco (pie l'ouvrage ne correspond pas à la noblesse de l'idée », il quale vuole i par-
ticolari dell'opera sottomessi all'armonica e predisposta concezione d'insieme, il quale
non solo disdegna la copia ma rifugge persino dal ritrarre giovandosi di disegni presi
sull'originale per timore che nell'opera e la noblesse de l'idée n'v serait plus à cause de la
« servitude de l'imitation ». Da una parte il Bernini deplora l'artificio eccessivo come
allorché, davanti a una casc ata di Saint-Cloud, la trova difettosa perchè troppo bella ed
afferma « qu'il faut cacher l'art davantage et chercher de donner aux choses une appa-
« ronco plus naturelle <: dall'altra, ragionando dei modelli, ne sa c apire tutta l'insufficienza
se lo spirito non soccorre ad animare l'inerte materia, se l'artista non sa rivivere in sè
l'imagine che vuole effigiare, e così dà consigli per modificare il modello in modo da ren-
derlo più conforme ad una compiuta visione di bellezza, e vuole che nella scultura in marmo
per supplire al difetto del colore, l'artista riesca a mettere qualche cosa che nell'ori-
ginale non c'è. Se, con grave scandalo del Winckelmann, mostra di non credere al
racconto ciceroniano relativo all'indagine di Elena dipinta da Zeusi per il tèmpio di
Giunone in Crotone trascegliendo da cinque bellissime fanciulle i particolari più per-
fetti dei loro corpi, ciò è appunto perchè questo innamorato della natura e dell'antico,
nella profonda sua concezione idealistica dell'arte, deve necessariamente rifuggire da
un metodo di lavoro così materialistico, che. privando l'artista della libertà necessaria
nella creazione, gl'impedisce di correggere la forma accidentale offertagli dalla "natura
al fine di dare un prototipo che si avvicini ad un ordine superiore di bellezza, e lo costringe
ad avvicinare particolari in contrasto fra loro.
Concezione idealistica, dunque, ne' Bernini, ma di un'idealismo che ha le sue radici
non in una tradizione scolastica 0 nel tacile adagiarsi in un pagro lavoro eli manièra,
di un'idealismo fatto vivo e operoso dalla capacità di emulali' la natura, dal bisogno
di correggerla talora. Basta ripensare a questo 0 a quell'esempio tra la feconda produ-
zione berniniana, per riconfermarci nella persuasione del suo studio intenso dei partico-
lari veristici. Giunto a Parigi, deve constatali- che nessuno dei ritratti del re è somi-
gliante, e, accingendosi all'opera — egli che sa volta a volta modificare la sua tecnica
a sei-onda delle esigenze della cosa che vuol ritrarre, che sa per quali impercettibili
sfumature di forme e di dimensioni si giunga alla differenziazione dell'espressioni- fisio-
nomica, che sa come nessun uomo abbia impostata la testa sulle spalle nello stesso
modo di un altro — non obbliga il suo augusto modello ad una -posa determinata, ma
ne vuol cogliere l'aspetto normale osservandolo mentre liberamente muove ed atteggia
il suo corpo, e intanto, ragionando con mirabile acume dei particolari del viso del Re,
mostra d'aver saputo operare con occhi ilio vanno al di là della superficie apparente,
e c'insegna per quale via egli sa giungere al line propostesi « de fai re que ses ouvrages
«parussent ótre de chair».
E, come il Bernini sa che l'orgoglio e la presunzione servono a far riconoscere gli
ignoranti, gli riesce a rifuggire da quelle astratte generalizzazioni di giudizio che sono
un po' sempre il frutto di una concezione unilaterale non esercitata nell'osservazione