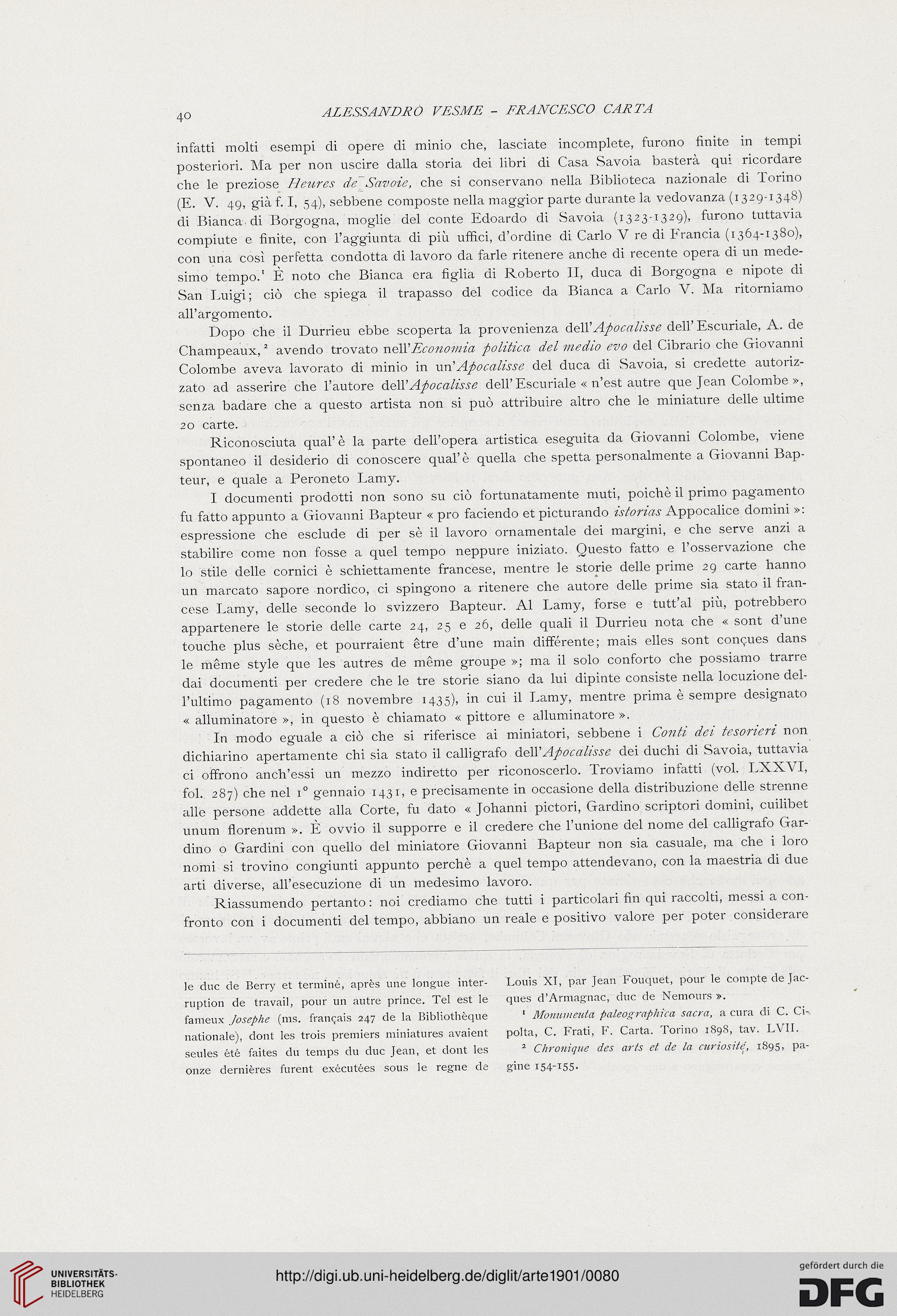4o
ALESSANDRO VESME - FRANCESCO CARTA
infatti molti esempi di opere di minio che, lasciate incomplete, furono finite in tempi
posteriori. Ma per non uscire dalla storia dei libri di Casa Savoia basterà qui ricordare
che le preziose Heures de Savoie, che si conservano nella Biblioteca nazionale di Torino
(E. V. 4Q, già f. I, 54), sebbene composte nella maggior parte durante la vedovanza (1329-1348)
di Bianca di Borgogna, moglie del conte Edoardo di Savoia (1323-1329), furono tuttavia
compiute e finite, con l’aggiunta di più uffici, d’ordine di Carlo V re di Francia (1364-1380),
con una cosi perfetta condotta di lavoro da farle ritenere anche di recente opera di un mede-
simo tempo.' E noto che Bianca era figlia di Roberto II, duca di Borgogna e nipote di
San Luigi ; ciò che spiega il trapasso del codice da Bianca a Carlo V. Ma ritorniamo
all’argomento.
Dopo che il Durrieu ebbe scoperta la provenienza dell’ Apocalisse dell’Escuriale, A. de
Champeaux,2 avendo trovato nell’Economia politica del medio evo del Cibrario che Giovanni
Colombe aveva lavorato di minio in mi Apocalisse del duca di Savoia, si credette autoriz-
zato ad asserire che l’autore dell 'Apocalisse dell’Escuriale « n’eSt autre que Jean Colombe »,
senza badare che a questo artista non si può attribuire altro che le miniature delle ultime
20 carte.
Riconosciuta qual’è la parte dell’opera artistica eseguita da Giovanni Colombe, viene
spontaneo il desiderio di conoscere qual’è quella che spetta personalmente a Giovanni Bap-
teur, e quale a Peroneto Lamy.
I documenti prodotti non sono su ciò fortunatamente muti, poiché il primo pagamento
fu fatto appunto a Giovanni Bapteur « prò faciendo et picturando istorias Appocalice domini »:
espressione che esclude di per sé il lavoro ornamentale dei margini, e che serve anzi a
stabilire come non fosse a quel tempo neppure iniziato. Questo fatto e l’osservazione che
lo stile delle cornici è schiettamente francese, mentre le storie delle prime 29 carte hanno
un marcato sapore nordico, ci spingono a ritenere che autore delle prime sia stato il fran-
cese Lamy, delle seconde lo svizzero Bapteur. Al Lamy, forse e tutt’al più, potrebbero
appartenere le storie delle carte 24, 25 e 26, delle quali il Durrieu nota che « sont d’une
touche plus sèche, et pourraient ètre d’une main differente; mais elles sont con(;ues dans
le mème style que les autres de mème groupe »; ma il solo conforto che possiamo trarre
dai documenti per credere che le tre storie siano da lui dipinte consiste nella locuzione del-
l’ultimo pagamento (18 novembre 1435), in cui il Lamy, mentre prima è sempre designato
« alluminatore », in questo è chiamato « pittore e alluminatore ».
In modo eguale a ciò che si riferisce ai miniatori, sebbene i Conti dei tesorieri non
dichiarino apertamente chi sia stato il calligrafo dell’Apocalisse dei duchi di Savoia, tuttavia
ci offrono anch’essi un mezzo indiretto per riconoscerlo. Troviamo infatti (voi. LXXVI,
foh 287) che nel i° gennaio 1431, e precisamente in occasione della distribuzione delle strenne
alle persone addette alla Corte, fu dato « Johanni pictori, Gardino scriptori domini, cuilibet
unum florenum ». E ovvio il supporre e il credere che l’unione del nome del calligrafo Gar-
dino o Gardini con quello del miniatore Giovanni Bapteur non sia casuale, ma che i loro
nomi si trovino congiunti appunto perchè a quel tempo attendevano, con la maestria di due
arti diverse, all’esecuzione di un medesimo lavoro.
Riassumendo pertanto : noi crediamo che tutti i particolari fin qui raccolti, messi a con-
fronto con i documenti del tempo, abbiano un reale e positivo valore per poter considerare
le due de Berry et termine, après une longue inter-
ruption de travail, polir un autre prince. Tel est le
fameux Josephe (ms. frangais 247 de la Bibliothèque
nationale), dont les trois premiers miniatures avaient
seules été faites du temps du due Jean, et dont les
onze dernières furent exécutées sous le regne de
Louis XI, par Jean Fouquet, pour le compte de Jac-
ques d’Armagnac, due de Nemours ».
1 Monumenta paleographica sacra, a cura di C. Ci-
polta, C. Frati, F. Carta. Torino 1898, tav. LVII.
2 Chronique des arts et de la curiosite', 1895, pa-
gine 154-155-
ALESSANDRO VESME - FRANCESCO CARTA
infatti molti esempi di opere di minio che, lasciate incomplete, furono finite in tempi
posteriori. Ma per non uscire dalla storia dei libri di Casa Savoia basterà qui ricordare
che le preziose Heures de Savoie, che si conservano nella Biblioteca nazionale di Torino
(E. V. 4Q, già f. I, 54), sebbene composte nella maggior parte durante la vedovanza (1329-1348)
di Bianca di Borgogna, moglie del conte Edoardo di Savoia (1323-1329), furono tuttavia
compiute e finite, con l’aggiunta di più uffici, d’ordine di Carlo V re di Francia (1364-1380),
con una cosi perfetta condotta di lavoro da farle ritenere anche di recente opera di un mede-
simo tempo.' E noto che Bianca era figlia di Roberto II, duca di Borgogna e nipote di
San Luigi ; ciò che spiega il trapasso del codice da Bianca a Carlo V. Ma ritorniamo
all’argomento.
Dopo che il Durrieu ebbe scoperta la provenienza dell’ Apocalisse dell’Escuriale, A. de
Champeaux,2 avendo trovato nell’Economia politica del medio evo del Cibrario che Giovanni
Colombe aveva lavorato di minio in mi Apocalisse del duca di Savoia, si credette autoriz-
zato ad asserire che l’autore dell 'Apocalisse dell’Escuriale « n’eSt autre que Jean Colombe »,
senza badare che a questo artista non si può attribuire altro che le miniature delle ultime
20 carte.
Riconosciuta qual’è la parte dell’opera artistica eseguita da Giovanni Colombe, viene
spontaneo il desiderio di conoscere qual’è quella che spetta personalmente a Giovanni Bap-
teur, e quale a Peroneto Lamy.
I documenti prodotti non sono su ciò fortunatamente muti, poiché il primo pagamento
fu fatto appunto a Giovanni Bapteur « prò faciendo et picturando istorias Appocalice domini »:
espressione che esclude di per sé il lavoro ornamentale dei margini, e che serve anzi a
stabilire come non fosse a quel tempo neppure iniziato. Questo fatto e l’osservazione che
lo stile delle cornici è schiettamente francese, mentre le storie delle prime 29 carte hanno
un marcato sapore nordico, ci spingono a ritenere che autore delle prime sia stato il fran-
cese Lamy, delle seconde lo svizzero Bapteur. Al Lamy, forse e tutt’al più, potrebbero
appartenere le storie delle carte 24, 25 e 26, delle quali il Durrieu nota che « sont d’une
touche plus sèche, et pourraient ètre d’une main differente; mais elles sont con(;ues dans
le mème style que les autres de mème groupe »; ma il solo conforto che possiamo trarre
dai documenti per credere che le tre storie siano da lui dipinte consiste nella locuzione del-
l’ultimo pagamento (18 novembre 1435), in cui il Lamy, mentre prima è sempre designato
« alluminatore », in questo è chiamato « pittore e alluminatore ».
In modo eguale a ciò che si riferisce ai miniatori, sebbene i Conti dei tesorieri non
dichiarino apertamente chi sia stato il calligrafo dell’Apocalisse dei duchi di Savoia, tuttavia
ci offrono anch’essi un mezzo indiretto per riconoscerlo. Troviamo infatti (voi. LXXVI,
foh 287) che nel i° gennaio 1431, e precisamente in occasione della distribuzione delle strenne
alle persone addette alla Corte, fu dato « Johanni pictori, Gardino scriptori domini, cuilibet
unum florenum ». E ovvio il supporre e il credere che l’unione del nome del calligrafo Gar-
dino o Gardini con quello del miniatore Giovanni Bapteur non sia casuale, ma che i loro
nomi si trovino congiunti appunto perchè a quel tempo attendevano, con la maestria di due
arti diverse, all’esecuzione di un medesimo lavoro.
Riassumendo pertanto : noi crediamo che tutti i particolari fin qui raccolti, messi a con-
fronto con i documenti del tempo, abbiano un reale e positivo valore per poter considerare
le due de Berry et termine, après une longue inter-
ruption de travail, polir un autre prince. Tel est le
fameux Josephe (ms. frangais 247 de la Bibliothèque
nationale), dont les trois premiers miniatures avaient
seules été faites du temps du due Jean, et dont les
onze dernières furent exécutées sous le regne de
Louis XI, par Jean Fouquet, pour le compte de Jac-
ques d’Armagnac, due de Nemours ».
1 Monumenta paleographica sacra, a cura di C. Ci-
polta, C. Frati, F. Carta. Torino 1898, tav. LVII.
2 Chronique des arts et de la curiosite', 1895, pa-
gine 154-155-