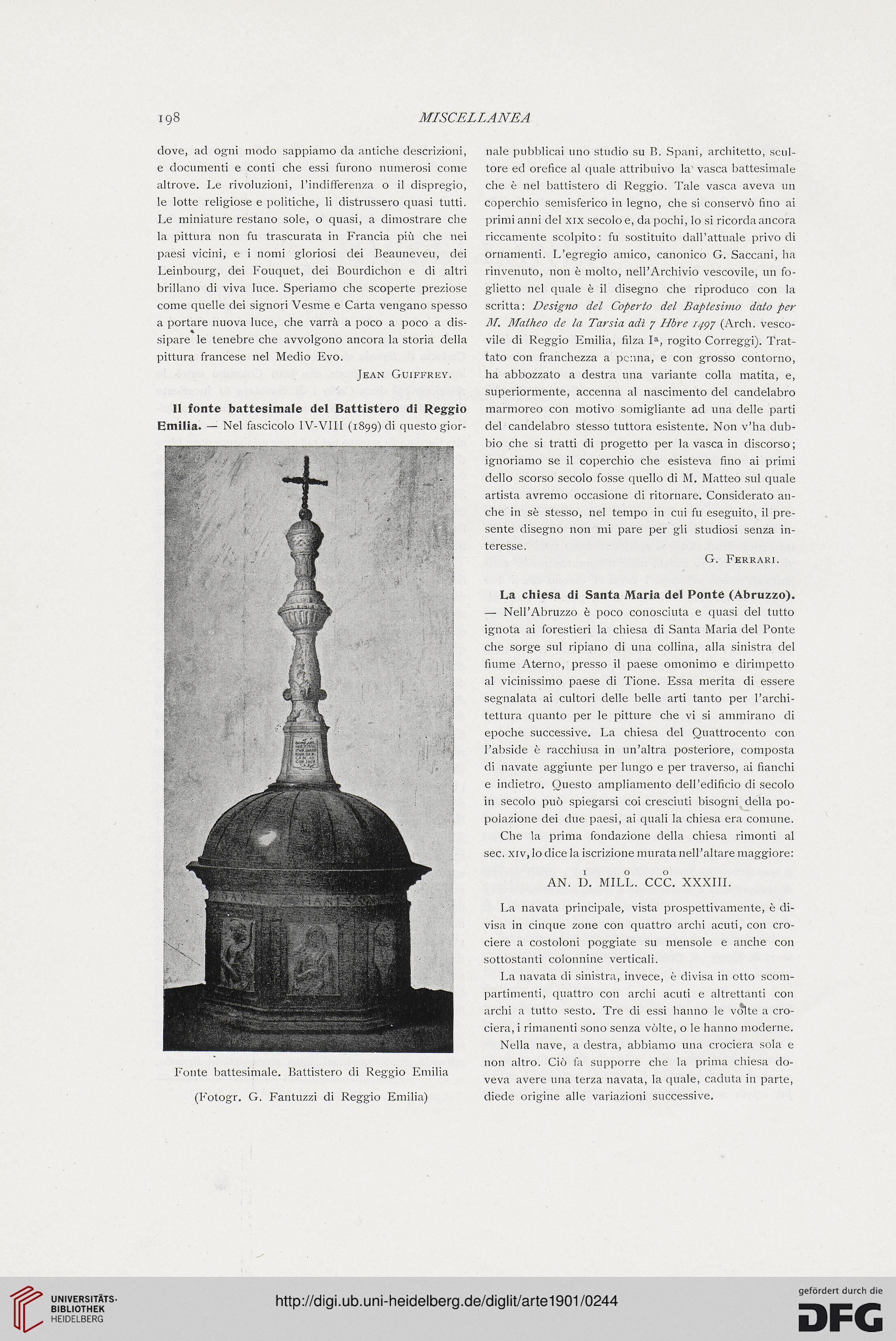MISCELLANEA
198
dove, ad ogni modo sappiamo da antiche descrizioni,
e documenti e conti che essi furono numerosi come
altrove. Le rivoluzioni, l’indifferenza o il dispregio,
le lotte religiose e politiche, li distrussero quasi tutti.
Le miniature restano sole, o quasi, a dimostrare che
la pittura non fu trascurata in Francia più che nei
paesi vicini, e i nomi gloriosi dei Beauneveu, dei
Leinbourg, dei Fouquet, dei Bourdichon e di altri
brillano di viva luce. Speriamo che scoperte preziose
come quelle dei signori Vesme e Carta vengano spesso
a portare nuova luce, che varrà a poco a poco a dis-
sipare le tenebre che avvolgono ancora la storia della
pittura francese nel Medio Evo.
Jean Guiffrey.
Il fonte battesimale del Battistero di Reggio
Emilia. — Nel fascicolo 1V-VIII (1899) di questo gior-
Fonte battesimale. Battistero di Reggio Emilia
(Fotogr. G. Fantuzzi di Reggio Emilia)
naie pubblicai uno studio su B. Spani, architetto, scul-
tore ed orefice al quale attribuivo la' vasca battesimale
che è nel battistero di Reggio. Tale vasca aveva un
coperchio semisferico in legno, che si conservò fino ai
primi anni del xix secolo e, da pochi, lo si ricorda ancora
riccamente scolpito: fu sostituito dall'attuale privo di
ornamenti. L’egregio amico, canonico G. Saccani, ha
rinvenuto, non è molto, nell’Archivio vescovile, un fo-
glietto nel quale è il disegno che riproduco con la
scritta : Designo del Coperto del Baptesìmo dato per
M. Matheo de la Tarsia adì 7 Hbre 1497 (Arch. vesco-
vile di Reggio Emilia, filza Ia, rogito Correggi). Trat-
tato con franchezza a penna, e con grosso contorno,
ha abbozzato a destra una variante colla matita, e,
superiormente, accenna al nascimento del candelabro
marmoreo con motivo somigliante ad una delle parti
del candelabro stesso tuttora esistente. Non v’ha dub-
bio che si tratti di progetto per la vasca in discorso ;
ignoriamo se il coperchio che esisteva fino ai primi
dello scorso secolo fosse quello di M. Matteo sul quale
artista avremo occasione di ritornare. Considerato an-
che in sè stesso, nel tempo in cui fu eseguito, il pre-
sente disegno non mi pare per gli studiosi senza in-
teresse.
G. Ferrari.
La chiesa di Santa Maria del Ponte (Abruzzo).
— Nell’Abruzzo è poco conosciuta e quasi del tutto
ignota ai forestieri la chiesa di Santa Maria del Ponte
che sorge sul ripiano di una collina, alla sinistra del
fiume Aterno, presso il paese omonimo e dirimpetto
al vicinissimo paese di Tione. Essa merita di essere
segnalata ai cultori delle belle arti tanto per l’archi-
tettura quanto per le pitture che vi si ammirano di
epoche successive. La chiesa del Quattrocento con
l’abside è racchiusa in un’altra posteriore, composta
di navate aggiunte per lungo e per traverso, ai fianchi
e indietro. Questo ampliamento dell’edificio di secolo
in secolo può spiegarsi coi cresciuti bisogni della po-
polazione dei due paesi, ai quali la chiesa era comune.
Che la prima fondazione della chiesa rimonti al
sec. xiv, lo dice la iscrizione murata nell’altare maggiore:
AN. D. MILL. CCC. XXXIII.
La navata principale, vista prospettivamente, è di-
visa in cinque zone con quattro archi acuti, con cro-
ciere a costoloni poggiate su mensole e anche con
sottostanti colonnine verticali.
La navata di sinistra, invece, è divisa in otto scom-
partimenti, quattro con archi acuti e altrettanti con
archi a tutto sesto. Tre di essi hanno le volte a cro-
ciera, i rimanenti sono senza vòlte, o le hanno moderne.
Nella nave, a destra, abbiamo una crociera sola e
non altro. Ciò fa supporre che la prima chiesa do-
veva avere una terza navata, la quale, caduta in parte,
diede origine alle variazioni successive.
198
dove, ad ogni modo sappiamo da antiche descrizioni,
e documenti e conti che essi furono numerosi come
altrove. Le rivoluzioni, l’indifferenza o il dispregio,
le lotte religiose e politiche, li distrussero quasi tutti.
Le miniature restano sole, o quasi, a dimostrare che
la pittura non fu trascurata in Francia più che nei
paesi vicini, e i nomi gloriosi dei Beauneveu, dei
Leinbourg, dei Fouquet, dei Bourdichon e di altri
brillano di viva luce. Speriamo che scoperte preziose
come quelle dei signori Vesme e Carta vengano spesso
a portare nuova luce, che varrà a poco a poco a dis-
sipare le tenebre che avvolgono ancora la storia della
pittura francese nel Medio Evo.
Jean Guiffrey.
Il fonte battesimale del Battistero di Reggio
Emilia. — Nel fascicolo 1V-VIII (1899) di questo gior-
Fonte battesimale. Battistero di Reggio Emilia
(Fotogr. G. Fantuzzi di Reggio Emilia)
naie pubblicai uno studio su B. Spani, architetto, scul-
tore ed orefice al quale attribuivo la' vasca battesimale
che è nel battistero di Reggio. Tale vasca aveva un
coperchio semisferico in legno, che si conservò fino ai
primi anni del xix secolo e, da pochi, lo si ricorda ancora
riccamente scolpito: fu sostituito dall'attuale privo di
ornamenti. L’egregio amico, canonico G. Saccani, ha
rinvenuto, non è molto, nell’Archivio vescovile, un fo-
glietto nel quale è il disegno che riproduco con la
scritta : Designo del Coperto del Baptesìmo dato per
M. Matheo de la Tarsia adì 7 Hbre 1497 (Arch. vesco-
vile di Reggio Emilia, filza Ia, rogito Correggi). Trat-
tato con franchezza a penna, e con grosso contorno,
ha abbozzato a destra una variante colla matita, e,
superiormente, accenna al nascimento del candelabro
marmoreo con motivo somigliante ad una delle parti
del candelabro stesso tuttora esistente. Non v’ha dub-
bio che si tratti di progetto per la vasca in discorso ;
ignoriamo se il coperchio che esisteva fino ai primi
dello scorso secolo fosse quello di M. Matteo sul quale
artista avremo occasione di ritornare. Considerato an-
che in sè stesso, nel tempo in cui fu eseguito, il pre-
sente disegno non mi pare per gli studiosi senza in-
teresse.
G. Ferrari.
La chiesa di Santa Maria del Ponte (Abruzzo).
— Nell’Abruzzo è poco conosciuta e quasi del tutto
ignota ai forestieri la chiesa di Santa Maria del Ponte
che sorge sul ripiano di una collina, alla sinistra del
fiume Aterno, presso il paese omonimo e dirimpetto
al vicinissimo paese di Tione. Essa merita di essere
segnalata ai cultori delle belle arti tanto per l’archi-
tettura quanto per le pitture che vi si ammirano di
epoche successive. La chiesa del Quattrocento con
l’abside è racchiusa in un’altra posteriore, composta
di navate aggiunte per lungo e per traverso, ai fianchi
e indietro. Questo ampliamento dell’edificio di secolo
in secolo può spiegarsi coi cresciuti bisogni della po-
polazione dei due paesi, ai quali la chiesa era comune.
Che la prima fondazione della chiesa rimonti al
sec. xiv, lo dice la iscrizione murata nell’altare maggiore:
AN. D. MILL. CCC. XXXIII.
La navata principale, vista prospettivamente, è di-
visa in cinque zone con quattro archi acuti, con cro-
ciere a costoloni poggiate su mensole e anche con
sottostanti colonnine verticali.
La navata di sinistra, invece, è divisa in otto scom-
partimenti, quattro con archi acuti e altrettanti con
archi a tutto sesto. Tre di essi hanno le volte a cro-
ciera, i rimanenti sono senza vòlte, o le hanno moderne.
Nella nave, a destra, abbiamo una crociera sola e
non altro. Ciò fa supporre che la prima chiesa do-
veva avere una terza navata, la quale, caduta in parte,
diede origine alle variazioni successive.