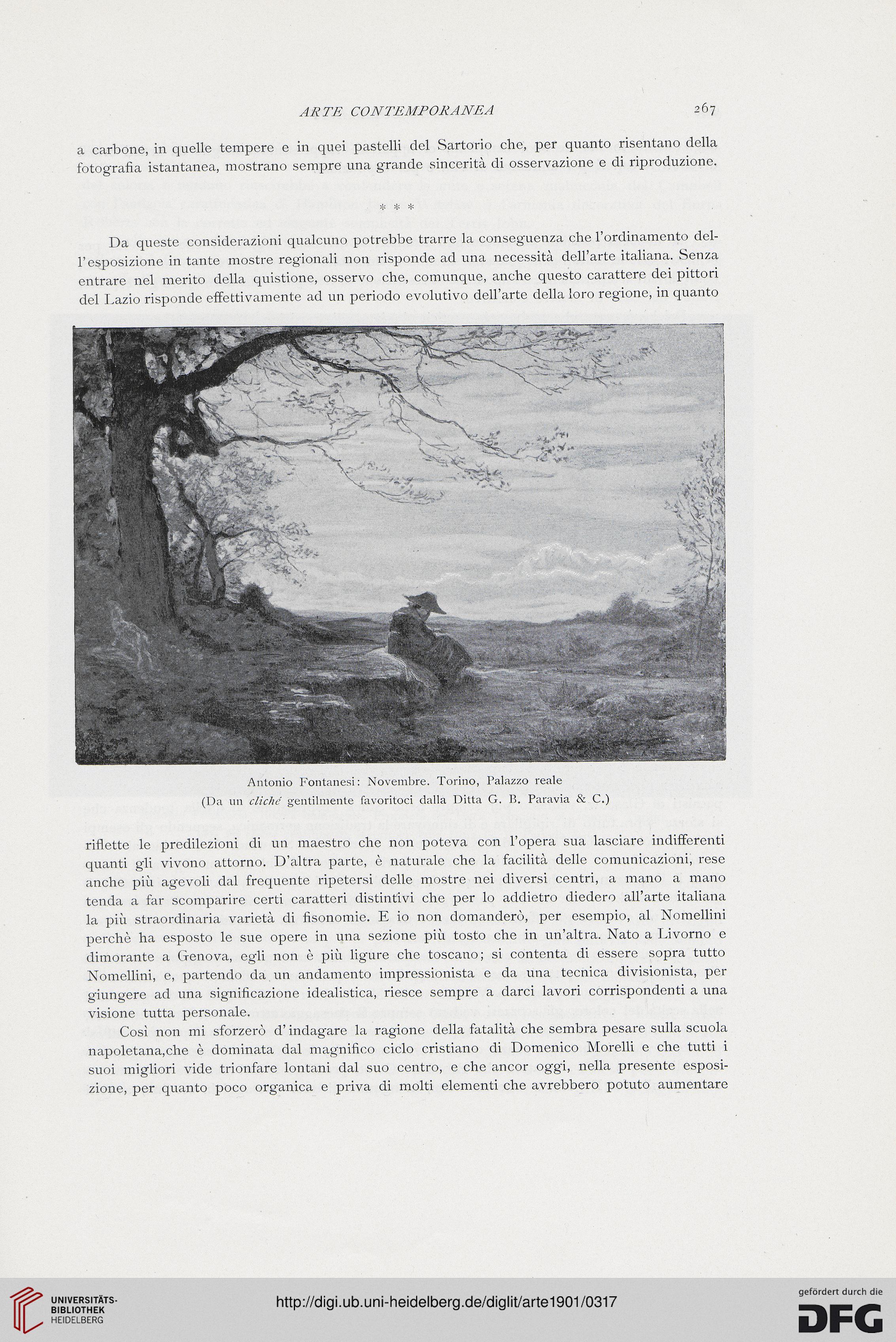ARTE CONTEMPORANEA
267
a carbone, in quelle tempere e in quei pastelli del Sartorio che, per quanto risentano della
fotografia istantanea, mostrano sempre una grande sincerità di osservazione e di riproduzione.
* * *
Da queste considerazioni qualcuno potrebbe trarre la conseguenza che l’ordinamento del-
l’esposizione in tante mostre regionali non risponde ad una necessità dell’arte italiana. Senza
entrare nel merito della quistione, osservo che, comunque, anche questo carattere dei pittori
del Lazio risponde effettivamente ad un periodo evolutivo dell’arte della loro regione, in quanto
Antonio Fontanesi: Novembre. Torino, Palazzo reale
(Da un cliché gentilmente favoritoci dalla Ditta G, B. Paravia & C.)
riflette le predilezioni di un maestro che non poteva con l’opera sua lasciare indifferenti
quanti gli vivono attorno. D’altra parte, è naturale che la facilità delle comunicazioni, rese
anche più agevoli dal frequente ripetersi delle mostre nei diversi centri, a mano a mano
tenda a far scomparire certi caratteri distintivi che per lo addietro diedero all’arte italiana
la più straordinaria varietà di fisonomie. E io non domanderò, per esempio, al Nomellini
perchè ha esposto le sue opere in una sezione più tosto che in un’altra. Nato a Livorno e
dimorante a Genova, egli non è più ligure che toscano; si contenta di essere sopra tutto
Nomellini, e, partendo da un andamento impressionista e da una tecnica divisionista, per
giungere ad una significazione idealistica, riesce sempre a darci lavori corrispondenti a una
visione tutta personale.
Così non mi sforzerò d’indagare la ragione della fatalità che sembra pesare sulla scuola
napoletana,che è dominata dal magnifico ciclo cristiano di Domenico Morelli e che tutti i
suoi migliori vide trionfare lontani dal suo centro, e che ancor oggi, nella presente esposi-
zione, per quanto poco organica e priva di molti elementi che avrebbero potuto aumentare
267
a carbone, in quelle tempere e in quei pastelli del Sartorio che, per quanto risentano della
fotografia istantanea, mostrano sempre una grande sincerità di osservazione e di riproduzione.
* * *
Da queste considerazioni qualcuno potrebbe trarre la conseguenza che l’ordinamento del-
l’esposizione in tante mostre regionali non risponde ad una necessità dell’arte italiana. Senza
entrare nel merito della quistione, osservo che, comunque, anche questo carattere dei pittori
del Lazio risponde effettivamente ad un periodo evolutivo dell’arte della loro regione, in quanto
Antonio Fontanesi: Novembre. Torino, Palazzo reale
(Da un cliché gentilmente favoritoci dalla Ditta G, B. Paravia & C.)
riflette le predilezioni di un maestro che non poteva con l’opera sua lasciare indifferenti
quanti gli vivono attorno. D’altra parte, è naturale che la facilità delle comunicazioni, rese
anche più agevoli dal frequente ripetersi delle mostre nei diversi centri, a mano a mano
tenda a far scomparire certi caratteri distintivi che per lo addietro diedero all’arte italiana
la più straordinaria varietà di fisonomie. E io non domanderò, per esempio, al Nomellini
perchè ha esposto le sue opere in una sezione più tosto che in un’altra. Nato a Livorno e
dimorante a Genova, egli non è più ligure che toscano; si contenta di essere sopra tutto
Nomellini, e, partendo da un andamento impressionista e da una tecnica divisionista, per
giungere ad una significazione idealistica, riesce sempre a darci lavori corrispondenti a una
visione tutta personale.
Così non mi sforzerò d’indagare la ragione della fatalità che sembra pesare sulla scuola
napoletana,che è dominata dal magnifico ciclo cristiano di Domenico Morelli e che tutti i
suoi migliori vide trionfare lontani dal suo centro, e che ancor oggi, nella presente esposi-
zione, per quanto poco organica e priva di molti elementi che avrebbero potuto aumentare