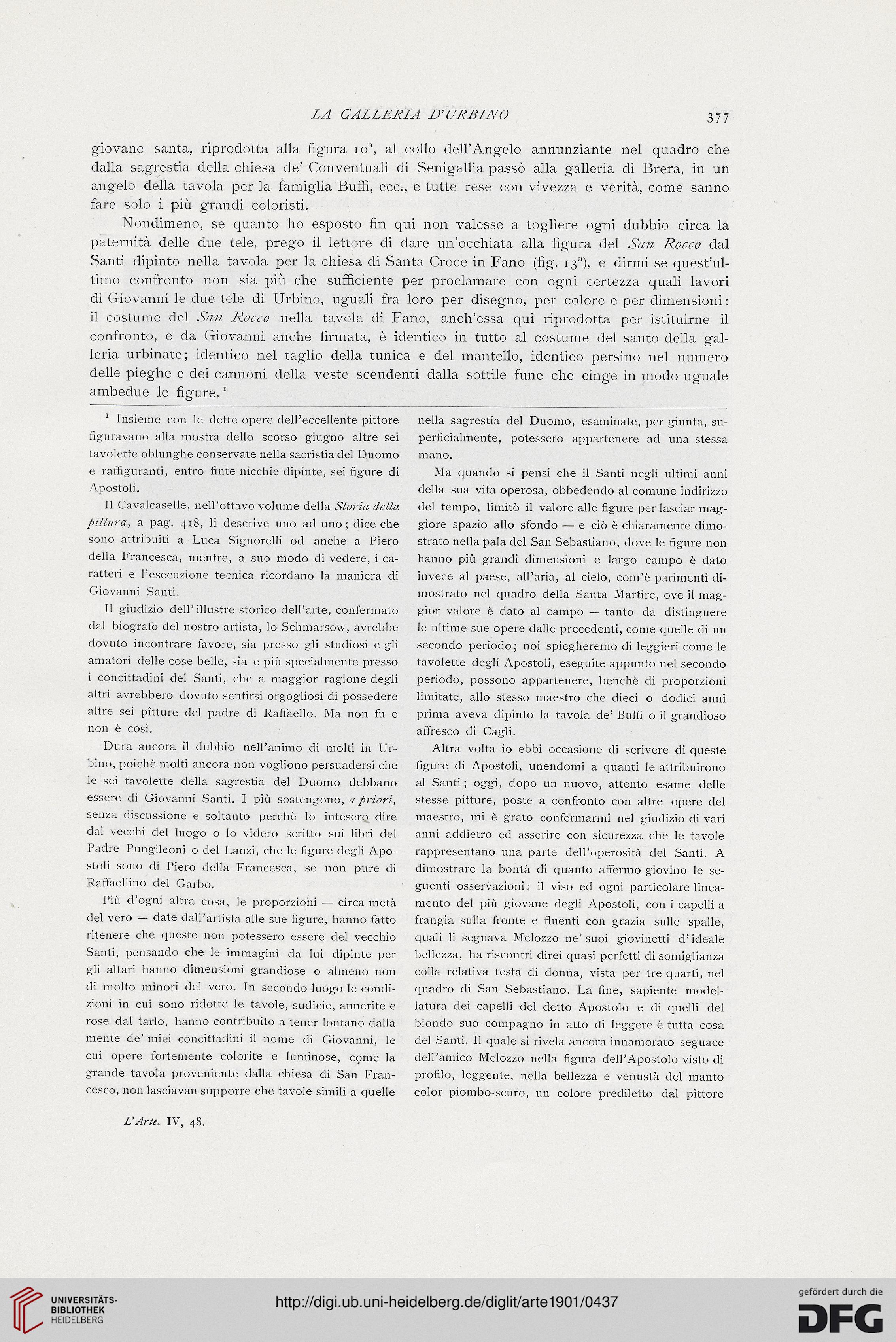LA GALLERIA D’URBINO
377
giovane santa, riprodotta alla figura ioa, al collo dell’Angelo annunziante nel quadro che
dalla sagrestia della chiesa de’ Conventuali di Senigallia passò alla galleria di Brera, in un
angelo della tavola per la famiglia Buffi, ecc., e tutte rese con vivezza e verità, come sanno
fare solo i più grandi coloristi.
Nondimeno, se quanto ho esposto fin qui non valesse a togliere ogni dubbio circa la
paternità delle due tele, prego il lettore di dare un’occhiata alla figura del San Rocco dal
Santi dipinto nella tavola per la chiesa di Santa Croce in Fano (fig. 13*'*), e dirmi se quest’ul-
timo confronto non sia più che sufficiente per proclamare con ogni certezza quali lavori
di Giovanni le due tele di Urbino, uguali fra loro per disegno, per colore e per dimensioni:
il costume del San Rocco nella tavola di Fano, anch’essa qui riprodotta per istituirne il
confronto, e da Giovanni anche firmata, è identico in tutto al costume del santo della gal-
leria urbinate; identico nel taglio della tunica e del mantello, identico persino nel numero
delle pieghe e dei cannoni della veste scendenti dalla sottile fune che cinge in modo uguale
ambedue le figure.1
I Insieme con le dette opere dell’eccellente pittore
figuravano alla mostra dello scorso giugno altre sei
tavolette oblunghe conservate nella sacristia del Duomo
e raffiguranti, entro finte nicchie dipinte, sei figure di
Apostoli.
II Cavalcasene, nell’ottavo volume della Storia della
pittura, a pag. 418, li descrive uno ad uno ; dice che
sono attribuiti a Luca Signorelli od anche a Piero
della Francesca, mentre, a suo modo di vedere, i ca-
ratteri e l’esecuzione tecnica ricordano la maniera di
Giovanni Santi.
Il giudizio dell’illustre storico dell’arte, confermato
dal biografo del nostro artista, lo Schmarsow, avrebbe
dovuto incontrare favore, sia presso gli studiosi e gli
amatori delle cose belle, sia e più specialmente presso
i concittadini del Santi, che a maggior ragione degli
altri avrebbero dovuto sentirsi orgogliosi di possedere
altre sei pitture del padre di Raffaello. Ma non fu e
non è così.
Dura ancora il dubbio nell’animo di molti in Ur-
bino, poiché molti ancora non vogliono persuadersi che
le sei tavolette della sagrestia del Duomo debbano
essere di Giovanni Santi. I più sostengono, a priori,
senza discussione e soltanto perchè lo intesero dire
dai vecchi del luogo o lo videro scritto sui libri del
Padre Pungileoni o del Lanzi, che le figure degli Apo-
stoli sono di Piero della Francesca, se non pure di
Raffaellino del Garbo.
Più d’ogni altra cosa, le proporzioni — circa metà
del vero — date dall’artista alle sue figure, hanno fatto
ritenere che queste non potessero essere del vecchio
Santi, pensando che le immagini da lui dipinte per
gli altari hanno dimensioni grandiose o almeno non
di molto minori del vero. In secondo luogo le condi-
zioni in cui sono ridotte le tavole, sudicie, annerite e
rose dal tarlo, hanno contribuito a tener lontano dalla
mente de’ miei concittadini il nome di Giovanni, le
cui opere fortemente colorite e luminose, come la
grande tavola proveniente dalla chiesa di San Fran-
cesco, non lasciava!! supporre che tavole simili a quelle
nella sagrestia del Duomo, esaminate, per giunta, su-
perficialmente, potessero appartenere ad una stessa
mano.
Ma quando si pensi che il Santi negli ultimi anni
della sua vita operosa, obbedendo al comune indirizzo
del tempo, limitò il valore alle figure per lasciar mag-
giore spazio allo sfondo — e ciò è chiaramente dimo-
strato nella pala del San Sebastiano, dove le figure non
hanno più grandi dimensioni e largo campo è dato
invece al paese, all’aria, al cielo, com’è parimenti di-
mostrato nel quadro della Santa Martire, ove il mag-
gior valore è dato al campo — tanto da distinguere
le ultime sue opere dalle precedenti, come quelle di un
secondo periodo ; noi spiegheremo di leggieri come le
tavolette degli Apostoli, eseguite appunto nel secondo
periodo, possono appartenere, benché di proporzioni
limitate, allo stesso maestro che dieci o dodici anni
prima aveva dipinto la tavola de’ Buffi o il grandioso
affresco di Cagli.
Altra volta io ebbi occasione di scrivere di queste
figure di Apostoli, unendomi a quanti le attribuirono
al Santi; oggi, dopo un nuovo, attento esame delle
stesse pitture, poste a confronto con altre opere del
maestro, mi è grato confermarmi nel giudizio di vari
anni addietro ed asserire con sicurezza che le tavole
rappresentano una parte dell’operosità del Santi. A
dimostrare la bontà di quanto affermo giovino le se-
guenti osservazioni : il viso ed ogni particolare linea-
mento del più giovane degli Apostoli, con i capelli a
frangia sulla fronte e fluenti con grazia sulle spalle,
quali li segnava Melozzo ne’suoi giovinetti d’ideale
bellezza, ha riscontri direi quasi perfetti di somiglianza
colla relativa testa di donna, vista per tre quarti, nel
quadro di San Sebastiano. La fine, sapiente model-
latura dei capelli del detto Apostolo e di quelli del
biondo suo compagno in atto di leggere è tutta cosa
del Santi. Il quale si rivela ancora innamorato seguace
dell’amico Melozzo nella figura dell’Apostolo visto di
profilo, leggente, nella bellezza e venustà del manto
color piombo-scuro, un colore prediletto dal pittore
L'Arte. IV, 48.
377
giovane santa, riprodotta alla figura ioa, al collo dell’Angelo annunziante nel quadro che
dalla sagrestia della chiesa de’ Conventuali di Senigallia passò alla galleria di Brera, in un
angelo della tavola per la famiglia Buffi, ecc., e tutte rese con vivezza e verità, come sanno
fare solo i più grandi coloristi.
Nondimeno, se quanto ho esposto fin qui non valesse a togliere ogni dubbio circa la
paternità delle due tele, prego il lettore di dare un’occhiata alla figura del San Rocco dal
Santi dipinto nella tavola per la chiesa di Santa Croce in Fano (fig. 13*'*), e dirmi se quest’ul-
timo confronto non sia più che sufficiente per proclamare con ogni certezza quali lavori
di Giovanni le due tele di Urbino, uguali fra loro per disegno, per colore e per dimensioni:
il costume del San Rocco nella tavola di Fano, anch’essa qui riprodotta per istituirne il
confronto, e da Giovanni anche firmata, è identico in tutto al costume del santo della gal-
leria urbinate; identico nel taglio della tunica e del mantello, identico persino nel numero
delle pieghe e dei cannoni della veste scendenti dalla sottile fune che cinge in modo uguale
ambedue le figure.1
I Insieme con le dette opere dell’eccellente pittore
figuravano alla mostra dello scorso giugno altre sei
tavolette oblunghe conservate nella sacristia del Duomo
e raffiguranti, entro finte nicchie dipinte, sei figure di
Apostoli.
II Cavalcasene, nell’ottavo volume della Storia della
pittura, a pag. 418, li descrive uno ad uno ; dice che
sono attribuiti a Luca Signorelli od anche a Piero
della Francesca, mentre, a suo modo di vedere, i ca-
ratteri e l’esecuzione tecnica ricordano la maniera di
Giovanni Santi.
Il giudizio dell’illustre storico dell’arte, confermato
dal biografo del nostro artista, lo Schmarsow, avrebbe
dovuto incontrare favore, sia presso gli studiosi e gli
amatori delle cose belle, sia e più specialmente presso
i concittadini del Santi, che a maggior ragione degli
altri avrebbero dovuto sentirsi orgogliosi di possedere
altre sei pitture del padre di Raffaello. Ma non fu e
non è così.
Dura ancora il dubbio nell’animo di molti in Ur-
bino, poiché molti ancora non vogliono persuadersi che
le sei tavolette della sagrestia del Duomo debbano
essere di Giovanni Santi. I più sostengono, a priori,
senza discussione e soltanto perchè lo intesero dire
dai vecchi del luogo o lo videro scritto sui libri del
Padre Pungileoni o del Lanzi, che le figure degli Apo-
stoli sono di Piero della Francesca, se non pure di
Raffaellino del Garbo.
Più d’ogni altra cosa, le proporzioni — circa metà
del vero — date dall’artista alle sue figure, hanno fatto
ritenere che queste non potessero essere del vecchio
Santi, pensando che le immagini da lui dipinte per
gli altari hanno dimensioni grandiose o almeno non
di molto minori del vero. In secondo luogo le condi-
zioni in cui sono ridotte le tavole, sudicie, annerite e
rose dal tarlo, hanno contribuito a tener lontano dalla
mente de’ miei concittadini il nome di Giovanni, le
cui opere fortemente colorite e luminose, come la
grande tavola proveniente dalla chiesa di San Fran-
cesco, non lasciava!! supporre che tavole simili a quelle
nella sagrestia del Duomo, esaminate, per giunta, su-
perficialmente, potessero appartenere ad una stessa
mano.
Ma quando si pensi che il Santi negli ultimi anni
della sua vita operosa, obbedendo al comune indirizzo
del tempo, limitò il valore alle figure per lasciar mag-
giore spazio allo sfondo — e ciò è chiaramente dimo-
strato nella pala del San Sebastiano, dove le figure non
hanno più grandi dimensioni e largo campo è dato
invece al paese, all’aria, al cielo, com’è parimenti di-
mostrato nel quadro della Santa Martire, ove il mag-
gior valore è dato al campo — tanto da distinguere
le ultime sue opere dalle precedenti, come quelle di un
secondo periodo ; noi spiegheremo di leggieri come le
tavolette degli Apostoli, eseguite appunto nel secondo
periodo, possono appartenere, benché di proporzioni
limitate, allo stesso maestro che dieci o dodici anni
prima aveva dipinto la tavola de’ Buffi o il grandioso
affresco di Cagli.
Altra volta io ebbi occasione di scrivere di queste
figure di Apostoli, unendomi a quanti le attribuirono
al Santi; oggi, dopo un nuovo, attento esame delle
stesse pitture, poste a confronto con altre opere del
maestro, mi è grato confermarmi nel giudizio di vari
anni addietro ed asserire con sicurezza che le tavole
rappresentano una parte dell’operosità del Santi. A
dimostrare la bontà di quanto affermo giovino le se-
guenti osservazioni : il viso ed ogni particolare linea-
mento del più giovane degli Apostoli, con i capelli a
frangia sulla fronte e fluenti con grazia sulle spalle,
quali li segnava Melozzo ne’suoi giovinetti d’ideale
bellezza, ha riscontri direi quasi perfetti di somiglianza
colla relativa testa di donna, vista per tre quarti, nel
quadro di San Sebastiano. La fine, sapiente model-
latura dei capelli del detto Apostolo e di quelli del
biondo suo compagno in atto di leggere è tutta cosa
del Santi. Il quale si rivela ancora innamorato seguace
dell’amico Melozzo nella figura dell’Apostolo visto di
profilo, leggente, nella bellezza e venustà del manto
color piombo-scuro, un colore prediletto dal pittore
L'Arte. IV, 48.