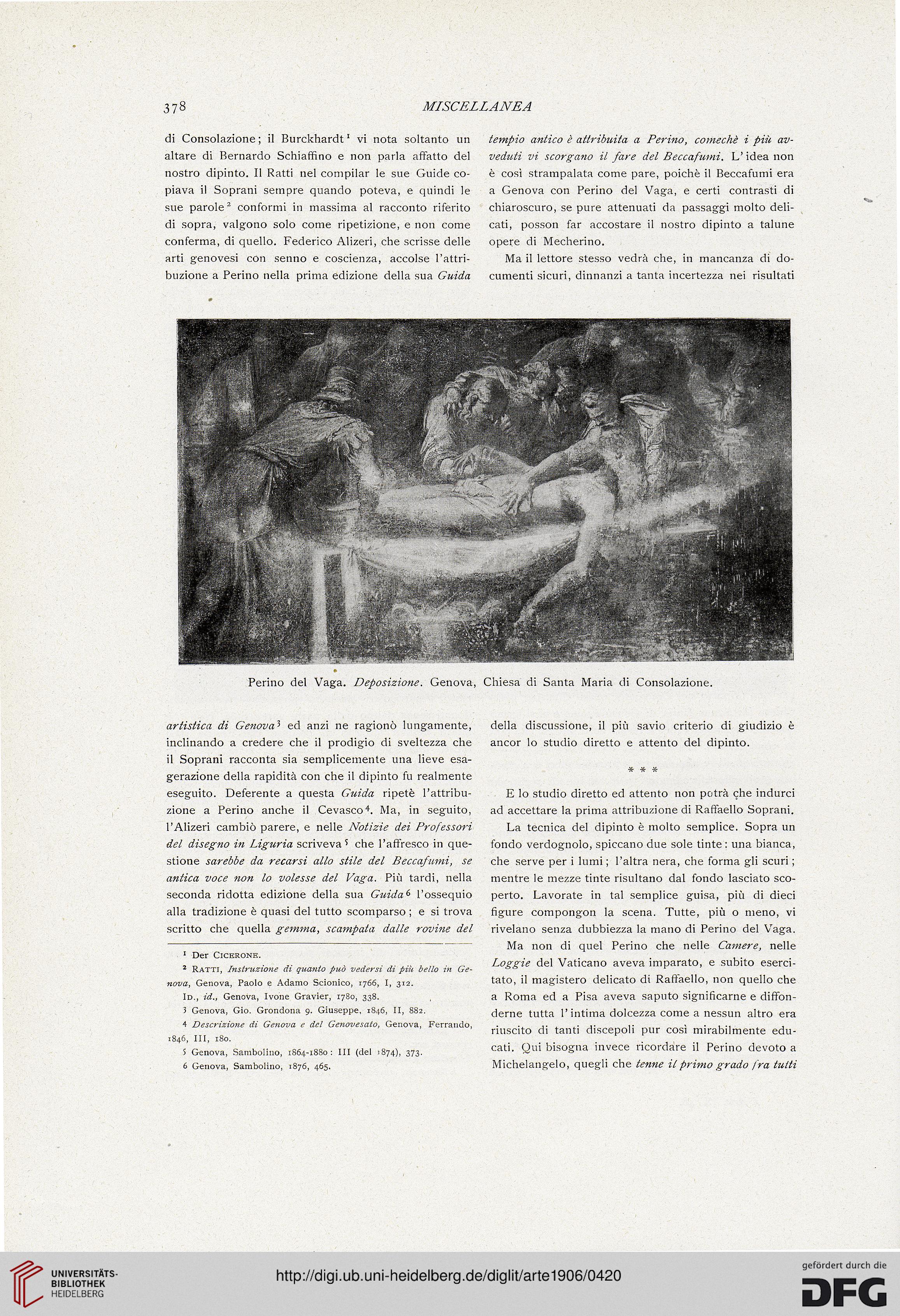378
MISCELLANEA
di Consolazione ; il Burckhardt1 vi nota soltanto un
altare di Bernardo Schiaffino e non parla affatto del
nostro dipinto. Il Ratti nel compilar le sue Guide co-
piava il Soprani sempre quando poteva, e quindi le
sue parole2 3 conformi in massima al racconto riferito
di sopra, valgono solo come ripetizione, e non come
conferma, di quello. Federico Alizeri, che scrisse delle
arti genovesi con senno e coscienza, accolse l’attri-
buzione a Perino nella prima edizione della sua Guida
tempio antico è attribuita a Perino, comechè i più av-
veduti vi scorgano il fare del Beccafumi. L’idea non
è così strampalata come pare, poiché il Beccafumi era
a Genova con Perino del Vaga, e certi contrasti di
chiaroscuro, se pure attenuati da passaggi molto deli-
cati, posson far accostare il nostro dipinto a talune
opere di Mecherino.
Ma il lettore stesso vedrà che, in mancanza di do-
cumenti sicuri, dinnanzi a tanta incertezza nei risultati
Perino del Vaga. Deposizione. Genova, Chiesa di Santa Maria di Consolazione.
artistica dì Genova5 ed anzi ne ragionò lungamente,
inclinando a credere che il prodigio di sveltezza che
il Soprani racconta sia semplicemente una lieve esa-
gerazione della rapidità con che il dipinto fu realmente
eseguito. Deferente a questa Guida ripetè l’attribu-
zione a Perino anche il Cevasco4. Ma, in seguito,
l’Alizeri cambiò parere, e nelle Notizie dei Professori
del disegno in Liguria scriveva 5 6 che l’affresco in que-
stione sarebbe da recarsi allo stile del Beccafumi, se
antica voce non lo volesse del Vaga. Più tardi, nella
seconda ridotta edizione della sua Guidai l’ossequio
alla tradizione è quasi del tutto scomparso ; e si trova
scritto che quella gemma, scampata dalle rovine del
1 Der Cicerone.
2 Ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Ge-
nova, Genova, Paolo e Adamo Scionico, 1766, I, 312.
Id., id., Genova, Ivone Gravier, 1780, 338.
3 Genova, Gio. Grondona 9. Giuseppe, 1846, II, 882.
4 Descrizione di Genova e del Genovesato, Genova, Ferrando,
1846, III, 180.
5 Genova, Sambolino, 1864-1880: III (del 3874), 373.
6 Genova, Sambolino, 1876, 465.
della discussione, il più savio criterio di giudizio è
ancor lo studio diretto e attento del dipinto.
* * *
E lo studio diretto ed attento non potrà che indurci
ad accettare la prima attribuzione di Raffaello Soprani.
La tecnica del dipinto è molto semplice. Sopra un
fondo verdognolo, spiccano due sole tinte : una bianca,
che serve per i lumi ; l’altra nera, che forma gli scuri ;
mentre le mezze tinte risultano dal fondo lasciato sco-
perto. Lavorate in tal semplice guisa, più di dieci
figure compongon la scena. Tutte, più o meno, vi
rivelano senza dubbiezza la mano di Perino del Vaga.
Ma non di quel Perino che nelle Camere, nelle
Loggìe del Vaticano aveva imparato, e subito eserci-
tato, il magistero delicato di Raffaello, non quello che
a Roma ed a Pisa aveva saputo significarne e diffon-
derne tutta l’intima dolcezza come a nessun altro era
riuscito di tanti discepoli pur così mirabilmente edu-
cati. Qui bisogna invece ricordare il Perino devoto a
Michelangelo, quegli che tenne il primo grado fra tuiti
MISCELLANEA
di Consolazione ; il Burckhardt1 vi nota soltanto un
altare di Bernardo Schiaffino e non parla affatto del
nostro dipinto. Il Ratti nel compilar le sue Guide co-
piava il Soprani sempre quando poteva, e quindi le
sue parole2 3 conformi in massima al racconto riferito
di sopra, valgono solo come ripetizione, e non come
conferma, di quello. Federico Alizeri, che scrisse delle
arti genovesi con senno e coscienza, accolse l’attri-
buzione a Perino nella prima edizione della sua Guida
tempio antico è attribuita a Perino, comechè i più av-
veduti vi scorgano il fare del Beccafumi. L’idea non
è così strampalata come pare, poiché il Beccafumi era
a Genova con Perino del Vaga, e certi contrasti di
chiaroscuro, se pure attenuati da passaggi molto deli-
cati, posson far accostare il nostro dipinto a talune
opere di Mecherino.
Ma il lettore stesso vedrà che, in mancanza di do-
cumenti sicuri, dinnanzi a tanta incertezza nei risultati
Perino del Vaga. Deposizione. Genova, Chiesa di Santa Maria di Consolazione.
artistica dì Genova5 ed anzi ne ragionò lungamente,
inclinando a credere che il prodigio di sveltezza che
il Soprani racconta sia semplicemente una lieve esa-
gerazione della rapidità con che il dipinto fu realmente
eseguito. Deferente a questa Guida ripetè l’attribu-
zione a Perino anche il Cevasco4. Ma, in seguito,
l’Alizeri cambiò parere, e nelle Notizie dei Professori
del disegno in Liguria scriveva 5 6 che l’affresco in que-
stione sarebbe da recarsi allo stile del Beccafumi, se
antica voce non lo volesse del Vaga. Più tardi, nella
seconda ridotta edizione della sua Guidai l’ossequio
alla tradizione è quasi del tutto scomparso ; e si trova
scritto che quella gemma, scampata dalle rovine del
1 Der Cicerone.
2 Ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Ge-
nova, Genova, Paolo e Adamo Scionico, 1766, I, 312.
Id., id., Genova, Ivone Gravier, 1780, 338.
3 Genova, Gio. Grondona 9. Giuseppe, 1846, II, 882.
4 Descrizione di Genova e del Genovesato, Genova, Ferrando,
1846, III, 180.
5 Genova, Sambolino, 1864-1880: III (del 3874), 373.
6 Genova, Sambolino, 1876, 465.
della discussione, il più savio criterio di giudizio è
ancor lo studio diretto e attento del dipinto.
* * *
E lo studio diretto ed attento non potrà che indurci
ad accettare la prima attribuzione di Raffaello Soprani.
La tecnica del dipinto è molto semplice. Sopra un
fondo verdognolo, spiccano due sole tinte : una bianca,
che serve per i lumi ; l’altra nera, che forma gli scuri ;
mentre le mezze tinte risultano dal fondo lasciato sco-
perto. Lavorate in tal semplice guisa, più di dieci
figure compongon la scena. Tutte, più o meno, vi
rivelano senza dubbiezza la mano di Perino del Vaga.
Ma non di quel Perino che nelle Camere, nelle
Loggìe del Vaticano aveva imparato, e subito eserci-
tato, il magistero delicato di Raffaello, non quello che
a Roma ed a Pisa aveva saputo significarne e diffon-
derne tutta l’intima dolcezza come a nessun altro era
riuscito di tanti discepoli pur così mirabilmente edu-
cati. Qui bisogna invece ricordare il Perino devoto a
Michelangelo, quegli che tenne il primo grado fra tuiti