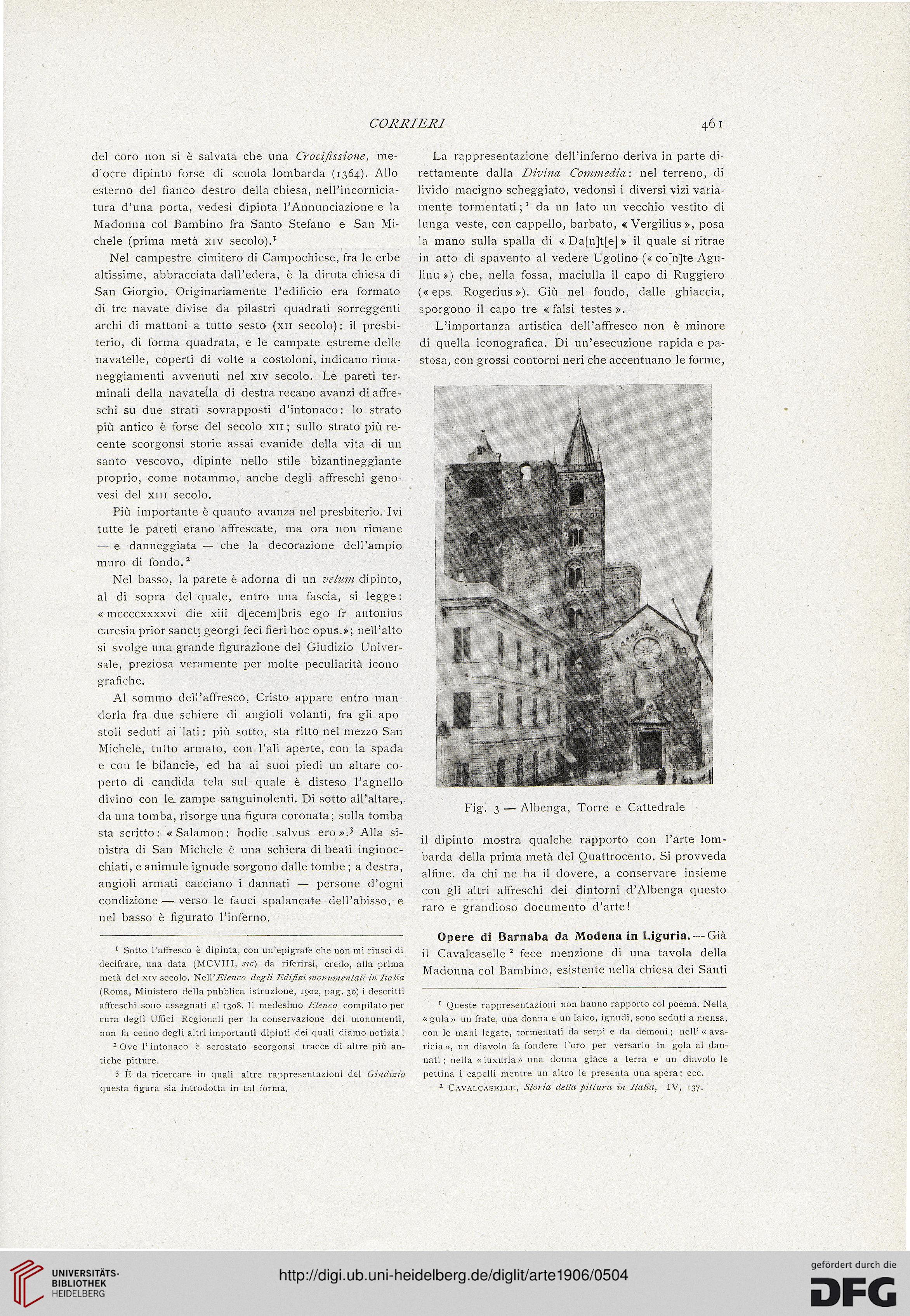CORRIERI
del coro non si è salvata che una Crocifissione, me-
d'ocre dipinto forse di scuola lombarda (1364). Allo
esterno del fianco destro della chiesa, nell’incornicia-
tura d’una porta, vedesi dipinta l’Annunciazione e la
Madonna col Bambino fra Santo Stefano e San Mi-
chele (prima metà xiv secolo).1
Nel campestre cimitero di Campochiese, fra le erbe
altissime, abbracciata dall’edera, è la diruta chiesa di
San Giorgio. Originariamente l’edificio era formato
di tre navate divise da pilastri quadrati sorreggenti
archi di mattoni a tutto sesto (xn secolo) : il presbi-
terio, di forma quadrata, e le campate estreme delle
navatelle, coperti di volte a costoloni, indicano rima-
neggiamenti avvenuti nel xiv secolo. Le pareti ter-
minali della navatella di destra recano avanzi di affre-
schi su due strati sovrapposti d’intonaco: lo strato
più antico è forse del secolo xil ; sullo strato più re-
cente scorgonsi storie assai evanide della vita di un
santo vescovo, dipinte nello stile bizantineggiante
proprio, come notammo, anche degli affreschi geno-
vesi del xiii secolo.
Più importante è quanto avanza nel presbiterio. Ivi
tutte le pareti erano affrescate, ma ora non rimane
— e danneggiata — che la decorazione dell’ampio
muro di fondo.2 3 *
Nel basso, la parete è adorna di un velimi dipinto,
al di sopra del quale, entro una fascia, si legge:
« mccccxxxxvi die xiii d[ecem]bris ego fr antonius
caresia prior sancti georgi feci fieri hoc opus.»; nell’alto
si svolge una grande figurazione del Giudizio Univer-
sale, preziosa veramente per molte peculiarità icono
grafiche.
Al sommo dell’affresco, Cristo appare entro man-
dorla fra due schiere di angioli volanti, fra gli apo
stoli seduti ai lati : più sotto, sta ritto nel mezzo San
Michele, tutto armato, con l’ali aperte, con la spada
e con le bilancie, ed ha ai suoi piedi un altare co-
perto di candida tela sul quale è disteso l’agnello
divino con le zampe sanguinolenti. Di sotto all’altare,,
da una tomba, risorge una figura coronata ; sulla tomba
sta scritto: «Salamon: hodie salvus ero».5 Alla si-
nistra di San Michele è una schiera di beati inginoc-
chiati, e animule ignude sorgono dalle tombe ; a destra,
angioli armati cacciano i dannati — persone d’ogni
condizione verso le fauci spalancate dell’abisso, e
nel basso è figurato l’inferno.
1 Sotto l’affresco è dipinta, con un’epigrafe che non mi riuscì di
decifrare, una data (MCVIII, sic) da riferirsi, credo, alla prima
metà del xiv secolo. Nell’Elenco degli Edifizi monumentali in Italia
(Roma, Ministero della pnbblica istruzione, 1902, pag. 30) i descritti
affreschi sono assegnati al 1308. Il medesimo Elenco, compilato per
cura degli Uffici Regionali per la conservazione dei monumenti,
non fa cenno degli altri importanti dipinti dei quali diamo notizia !
2 Ove l’intonaco è scrostato scorgonsi tracce di altre più an-
tiche pitture.
3 È da ricercare in quali altre rappresentazioni del Giudizio
questa figura sia introdotta in tal forma,
461
La rappresentazione dell’inferno deriva in parte di-
rettamente dalla Divina Commedia', nel terreno, di
livido macigno scheggiato, vedonsi i diversi vizi varia-
mente tormentati ; 1 da un lato un vecchio vestito di
lunga veste, con cappello, barbato, « Vergilius», posa
la mano sulla spalla di « Da[n]t[e] » il quale si ritrae
in atto di spavento al vedere Ugolino (« co[n]te Agu-
linu ») che, nella fossa, maciulla il capo di Ruggiero
(« eps. Rogerius»), Giù nel fondo, dalle ghiaccia,
sporgono il capo tre «falsi testes».
L’importanza artistica dell’affresco non è minore
di quella iconografica. Di un’esecuzione rapida e pa-
stosa, con grossi contorni neri che accentuano le forme,
il dipinto mostra qualche rapporto con l’arte lom-
barda della prima metà del Quattrocento. Si provveda
alfine, da chi ne ha il dovere, a conservare insieme
coti gli altri affreschi dei dintorni d’Albenga questo
raro e grandioso documento d’arte !
Opere di Barnaba da Modena in Liguria. — Già
il Cavalcasene 2 fece menzione di una tavola della
Madonna col Bambino, esistente nella chiesa dei Santi
! Queste rappresentazioni non hanno rapporto col poema. Nella
«gula» un frate, una donna e un laico, ignudi, sono seduti a mensa,
con le mani legate, tormentati da serpi e da demoni ; nell1 « ava-
ricia», un diavolo fa fondere l’oro per versarlo in gola ai dan-
nati: nella «luxuria» una donna giace a terra e un diavolo le
pettina i capelli mentre un altro le presenta una spera; eco.
2 Cavalcaselle, Storia della pittura in Italia, IV, 137.
del coro non si è salvata che una Crocifissione, me-
d'ocre dipinto forse di scuola lombarda (1364). Allo
esterno del fianco destro della chiesa, nell’incornicia-
tura d’una porta, vedesi dipinta l’Annunciazione e la
Madonna col Bambino fra Santo Stefano e San Mi-
chele (prima metà xiv secolo).1
Nel campestre cimitero di Campochiese, fra le erbe
altissime, abbracciata dall’edera, è la diruta chiesa di
San Giorgio. Originariamente l’edificio era formato
di tre navate divise da pilastri quadrati sorreggenti
archi di mattoni a tutto sesto (xn secolo) : il presbi-
terio, di forma quadrata, e le campate estreme delle
navatelle, coperti di volte a costoloni, indicano rima-
neggiamenti avvenuti nel xiv secolo. Le pareti ter-
minali della navatella di destra recano avanzi di affre-
schi su due strati sovrapposti d’intonaco: lo strato
più antico è forse del secolo xil ; sullo strato più re-
cente scorgonsi storie assai evanide della vita di un
santo vescovo, dipinte nello stile bizantineggiante
proprio, come notammo, anche degli affreschi geno-
vesi del xiii secolo.
Più importante è quanto avanza nel presbiterio. Ivi
tutte le pareti erano affrescate, ma ora non rimane
— e danneggiata — che la decorazione dell’ampio
muro di fondo.2 3 *
Nel basso, la parete è adorna di un velimi dipinto,
al di sopra del quale, entro una fascia, si legge:
« mccccxxxxvi die xiii d[ecem]bris ego fr antonius
caresia prior sancti georgi feci fieri hoc opus.»; nell’alto
si svolge una grande figurazione del Giudizio Univer-
sale, preziosa veramente per molte peculiarità icono
grafiche.
Al sommo dell’affresco, Cristo appare entro man-
dorla fra due schiere di angioli volanti, fra gli apo
stoli seduti ai lati : più sotto, sta ritto nel mezzo San
Michele, tutto armato, con l’ali aperte, con la spada
e con le bilancie, ed ha ai suoi piedi un altare co-
perto di candida tela sul quale è disteso l’agnello
divino con le zampe sanguinolenti. Di sotto all’altare,,
da una tomba, risorge una figura coronata ; sulla tomba
sta scritto: «Salamon: hodie salvus ero».5 Alla si-
nistra di San Michele è una schiera di beati inginoc-
chiati, e animule ignude sorgono dalle tombe ; a destra,
angioli armati cacciano i dannati — persone d’ogni
condizione verso le fauci spalancate dell’abisso, e
nel basso è figurato l’inferno.
1 Sotto l’affresco è dipinta, con un’epigrafe che non mi riuscì di
decifrare, una data (MCVIII, sic) da riferirsi, credo, alla prima
metà del xiv secolo. Nell’Elenco degli Edifizi monumentali in Italia
(Roma, Ministero della pnbblica istruzione, 1902, pag. 30) i descritti
affreschi sono assegnati al 1308. Il medesimo Elenco, compilato per
cura degli Uffici Regionali per la conservazione dei monumenti,
non fa cenno degli altri importanti dipinti dei quali diamo notizia !
2 Ove l’intonaco è scrostato scorgonsi tracce di altre più an-
tiche pitture.
3 È da ricercare in quali altre rappresentazioni del Giudizio
questa figura sia introdotta in tal forma,
461
La rappresentazione dell’inferno deriva in parte di-
rettamente dalla Divina Commedia', nel terreno, di
livido macigno scheggiato, vedonsi i diversi vizi varia-
mente tormentati ; 1 da un lato un vecchio vestito di
lunga veste, con cappello, barbato, « Vergilius», posa
la mano sulla spalla di « Da[n]t[e] » il quale si ritrae
in atto di spavento al vedere Ugolino (« co[n]te Agu-
linu ») che, nella fossa, maciulla il capo di Ruggiero
(« eps. Rogerius»), Giù nel fondo, dalle ghiaccia,
sporgono il capo tre «falsi testes».
L’importanza artistica dell’affresco non è minore
di quella iconografica. Di un’esecuzione rapida e pa-
stosa, con grossi contorni neri che accentuano le forme,
il dipinto mostra qualche rapporto con l’arte lom-
barda della prima metà del Quattrocento. Si provveda
alfine, da chi ne ha il dovere, a conservare insieme
coti gli altri affreschi dei dintorni d’Albenga questo
raro e grandioso documento d’arte !
Opere di Barnaba da Modena in Liguria. — Già
il Cavalcasene 2 fece menzione di una tavola della
Madonna col Bambino, esistente nella chiesa dei Santi
! Queste rappresentazioni non hanno rapporto col poema. Nella
«gula» un frate, una donna e un laico, ignudi, sono seduti a mensa,
con le mani legate, tormentati da serpi e da demoni ; nell1 « ava-
ricia», un diavolo fa fondere l’oro per versarlo in gola ai dan-
nati: nella «luxuria» una donna giace a terra e un diavolo le
pettina i capelli mentre un altro le presenta una spera; eco.
2 Cavalcaselle, Storia della pittura in Italia, IV, 137.