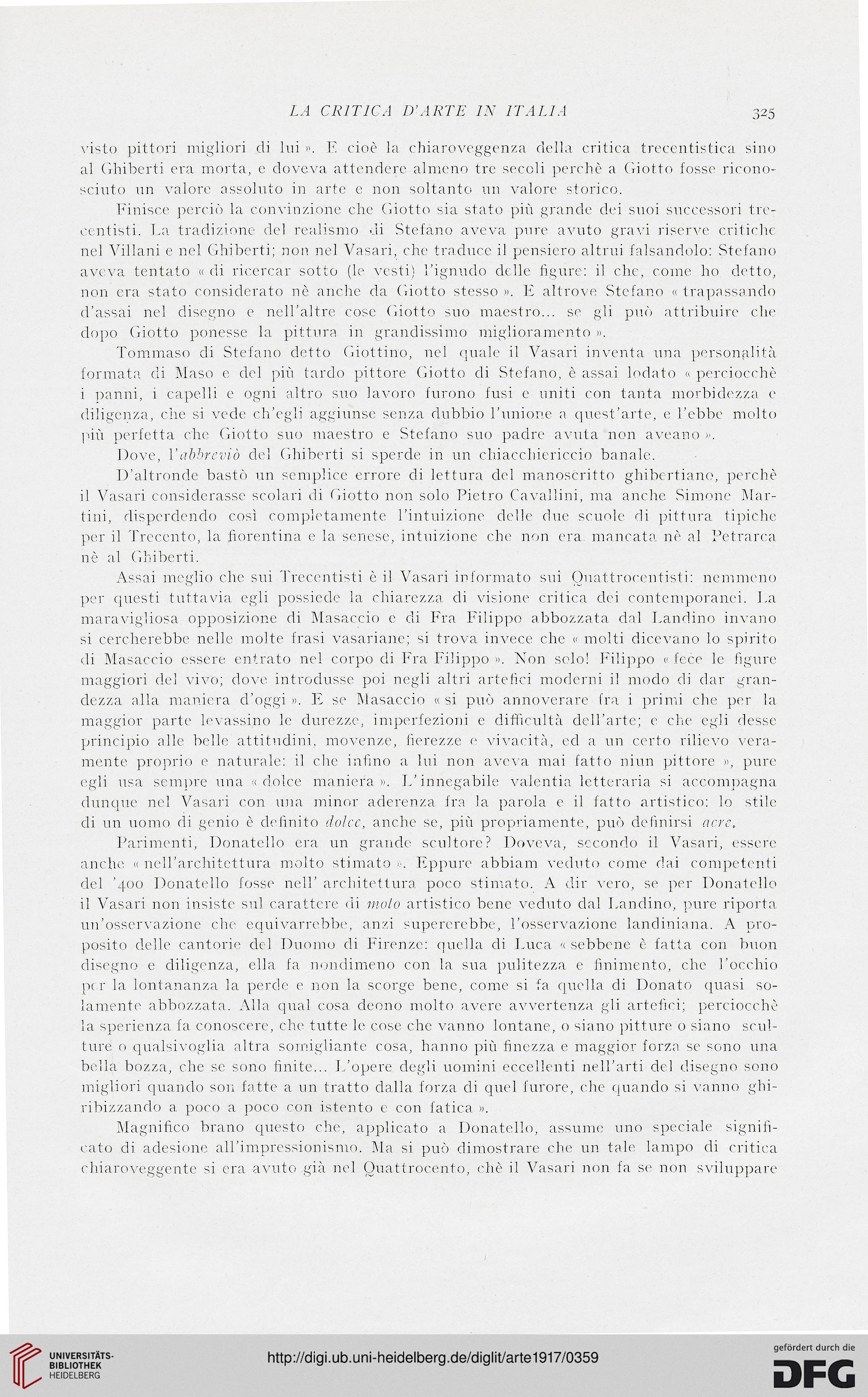LA CRITICA D'ARTE IN ITALIA
325
visto pittori migliori di lui ». E cioè la chiaroveggenza della critica trecentistica sino
al Ghiberti era morta, e doveva attendere almeno tre secoli perchè a (dotto fosse ricono-
sciuto un valore assoluto in arte e non soltanto un valore storico.
Finisce perciò la convinzione che (dotto sia stato più grande dei suoi successori tre-
centisti. La. tradizione del realismo di Stefano aveva pure avuto gravi riserve critiche
nel Villani e nel Ghiberti; non nel Vasari, che traduce il pensiero altrui falsandolo: Stefano
aveva tentato « di ricercar sotto (le vesti) l'ignudo delle figure: il che, come ho detto,
non era stato considerato nè anche da (dotto stesso ». E altrove Stefano « trapassando
d'assai nel disegno e nell'altre cose (dotto suo maestro... se gli può attribuire che
dopo (dotto ponesse la pittura in grandissimo miglioramento »,
Tommaso di Stefano detto (dottino, nel (piale il Vasari inventa una personalità
formata di Maso e del pili tardo pittore Giotto di Stefano, è assai lodato « perciocché
i panni, i capelli e ogni altro suo lavoro furono fusi e uniti con tanta morbidezza e
diligenza, che si vede ch'egli aggiunse senza dubbio l'unione a quest'arte, e l'ebbe molto
più perfetta che Giotto suo maestro e Stefano suo padre avuta non aveano ».
Dove, l'abbreviò del Ghiberti si sperde in un chiacchiericcio banale.
D'altronde bastò un semplice errore eli lettura del manoscritto ghibertiano, perchè
il Vasari considerasse scolari di (dotto non solo Pietro Cavallini, ma anche Simone Mar-
tini, disperdendo così completamente l'intuizione delle due scuole di pittura tipiche
per il Trecento, la fiorentina e la senese, intuizione che non era mancata, nè al Petrarca
nè al Ghiberti.
Assai meglio che sui Trecentisti è il Vasari informato sui Quattrocentisti: nemmeno
per questi tuttavia egli possiede la chiarezza di visione critica elei contemporanei. La
maravigliosa opposizione di Masaccio e di Fra Filippo abbozzata dal Landino invano
si cercherebbe nelle molte frasi vasariane; si trova invece che e molti dicevano lo spirito
di Masaccio essere entrato nel corpo di Fra Filippo ». Non solo! Filippo << fece le figure
maggiori del vivo; dove introdusse poi negli altri artefici moderni il modo di dar gran-
dezza alla maniera d'oggi». E se Masaccio «si può annoverare fra i primi che per la
maggior parte levassino le durezze, imperfezioni e difficultà dell'arte; e che egli desse
principio alle belle attitudini, movenze, fierezze e vivacità, ed a un certo rilievo vera-
mente proprio e naturale: il che infino a lui non aveva mai fatto niun pittore », pure
egli usa sempre una (dolce maniera». L'innegabile valentia letteraria si accompagna
dunque nel Vasari con una minor aderenza fra la parola e il fatto artistico: lo stilo
di un uomo di genio è definito dolce, anche se, più propriamente, può definirsi acre.
Parimenti, Donatello era un grande scultore? Doveva, secondo il Vasari, essere
anche « nell'architettura molto stimato >:•. Eppure abbiam veduto come dai competenti
del '400 Donatello fosse nell' architettura poco stimato. A dir vero, se per Donatello
il Vasari non insiste sul carattere di moto artistico bene veduto dal Landino, pure riporta
un'osservazione che equivarrebbe, anzi supererebbe, l'osservazione landiniana. A pro-
posito delle cantorie del Duomo eli Firenze1: quella di Luca « sebbene è fatta con buon
disegno e diligenza, ella fa nondimeno con la sua pulitezza e finimento, che l'occhio
per la lontananza la perde e non la scorge bene, come si fa quella di Donato (piasi so-
lamente abbozzata. Alla qua] cosa cleono molto avere avvertenza gli artefici; perciocché
la sperionza fa conoscere, che tutte le cose che vanno lontane, o siano pitture o siano scul-
ture o qualsivoglia altra somigliante cosa, hanno più finezza e maggior forza se sono una
bella bozza, che se sono finite... L'opere degli uomini eccellenti nell'arti del disegno sono
migliori quando son fatte a un tratto dalla forza di quel furore, che (piando si vanno ghi-
ribizzando a. poco a poco con istento e con fatica ».
Magnifico brano questo che, applicato a Donatello, assume uno speciale signifi-
cato di adesione all'impressionismo. Ma si può dimostrare che un tale lampo di critica
chiaroveggente si era avuto già nel Quattrocento, chè il Vasari non fa se non sviluppare
325
visto pittori migliori di lui ». E cioè la chiaroveggenza della critica trecentistica sino
al Ghiberti era morta, e doveva attendere almeno tre secoli perchè a (dotto fosse ricono-
sciuto un valore assoluto in arte e non soltanto un valore storico.
Finisce perciò la convinzione che (dotto sia stato più grande dei suoi successori tre-
centisti. La. tradizione del realismo di Stefano aveva pure avuto gravi riserve critiche
nel Villani e nel Ghiberti; non nel Vasari, che traduce il pensiero altrui falsandolo: Stefano
aveva tentato « di ricercar sotto (le vesti) l'ignudo delle figure: il che, come ho detto,
non era stato considerato nè anche da (dotto stesso ». E altrove Stefano « trapassando
d'assai nel disegno e nell'altre cose (dotto suo maestro... se gli può attribuire che
dopo (dotto ponesse la pittura in grandissimo miglioramento »,
Tommaso di Stefano detto (dottino, nel (piale il Vasari inventa una personalità
formata di Maso e del pili tardo pittore Giotto di Stefano, è assai lodato « perciocché
i panni, i capelli e ogni altro suo lavoro furono fusi e uniti con tanta morbidezza e
diligenza, che si vede ch'egli aggiunse senza dubbio l'unione a quest'arte, e l'ebbe molto
più perfetta che Giotto suo maestro e Stefano suo padre avuta non aveano ».
Dove, l'abbreviò del Ghiberti si sperde in un chiacchiericcio banale.
D'altronde bastò un semplice errore eli lettura del manoscritto ghibertiano, perchè
il Vasari considerasse scolari di (dotto non solo Pietro Cavallini, ma anche Simone Mar-
tini, disperdendo così completamente l'intuizione delle due scuole di pittura tipiche
per il Trecento, la fiorentina e la senese, intuizione che non era mancata, nè al Petrarca
nè al Ghiberti.
Assai meglio che sui Trecentisti è il Vasari informato sui Quattrocentisti: nemmeno
per questi tuttavia egli possiede la chiarezza di visione critica elei contemporanei. La
maravigliosa opposizione di Masaccio e di Fra Filippo abbozzata dal Landino invano
si cercherebbe nelle molte frasi vasariane; si trova invece che e molti dicevano lo spirito
di Masaccio essere entrato nel corpo di Fra Filippo ». Non solo! Filippo << fece le figure
maggiori del vivo; dove introdusse poi negli altri artefici moderni il modo di dar gran-
dezza alla maniera d'oggi». E se Masaccio «si può annoverare fra i primi che per la
maggior parte levassino le durezze, imperfezioni e difficultà dell'arte; e che egli desse
principio alle belle attitudini, movenze, fierezze e vivacità, ed a un certo rilievo vera-
mente proprio e naturale: il che infino a lui non aveva mai fatto niun pittore », pure
egli usa sempre una (dolce maniera». L'innegabile valentia letteraria si accompagna
dunque nel Vasari con una minor aderenza fra la parola e il fatto artistico: lo stilo
di un uomo di genio è definito dolce, anche se, più propriamente, può definirsi acre.
Parimenti, Donatello era un grande scultore? Doveva, secondo il Vasari, essere
anche « nell'architettura molto stimato >:•. Eppure abbiam veduto come dai competenti
del '400 Donatello fosse nell' architettura poco stimato. A dir vero, se per Donatello
il Vasari non insiste sul carattere di moto artistico bene veduto dal Landino, pure riporta
un'osservazione che equivarrebbe, anzi supererebbe, l'osservazione landiniana. A pro-
posito delle cantorie del Duomo eli Firenze1: quella di Luca « sebbene è fatta con buon
disegno e diligenza, ella fa nondimeno con la sua pulitezza e finimento, che l'occhio
per la lontananza la perde e non la scorge bene, come si fa quella di Donato (piasi so-
lamente abbozzata. Alla qua] cosa cleono molto avere avvertenza gli artefici; perciocché
la sperionza fa conoscere, che tutte le cose che vanno lontane, o siano pitture o siano scul-
ture o qualsivoglia altra somigliante cosa, hanno più finezza e maggior forza se sono una
bella bozza, che se sono finite... L'opere degli uomini eccellenti nell'arti del disegno sono
migliori quando son fatte a un tratto dalla forza di quel furore, che (piando si vanno ghi-
ribizzando a. poco a poco con istento e con fatica ».
Magnifico brano questo che, applicato a Donatello, assume uno speciale signifi-
cato di adesione all'impressionismo. Ma si può dimostrare che un tale lampo di critica
chiaroveggente si era avuto già nel Quattrocento, chè il Vasari non fa se non sviluppare