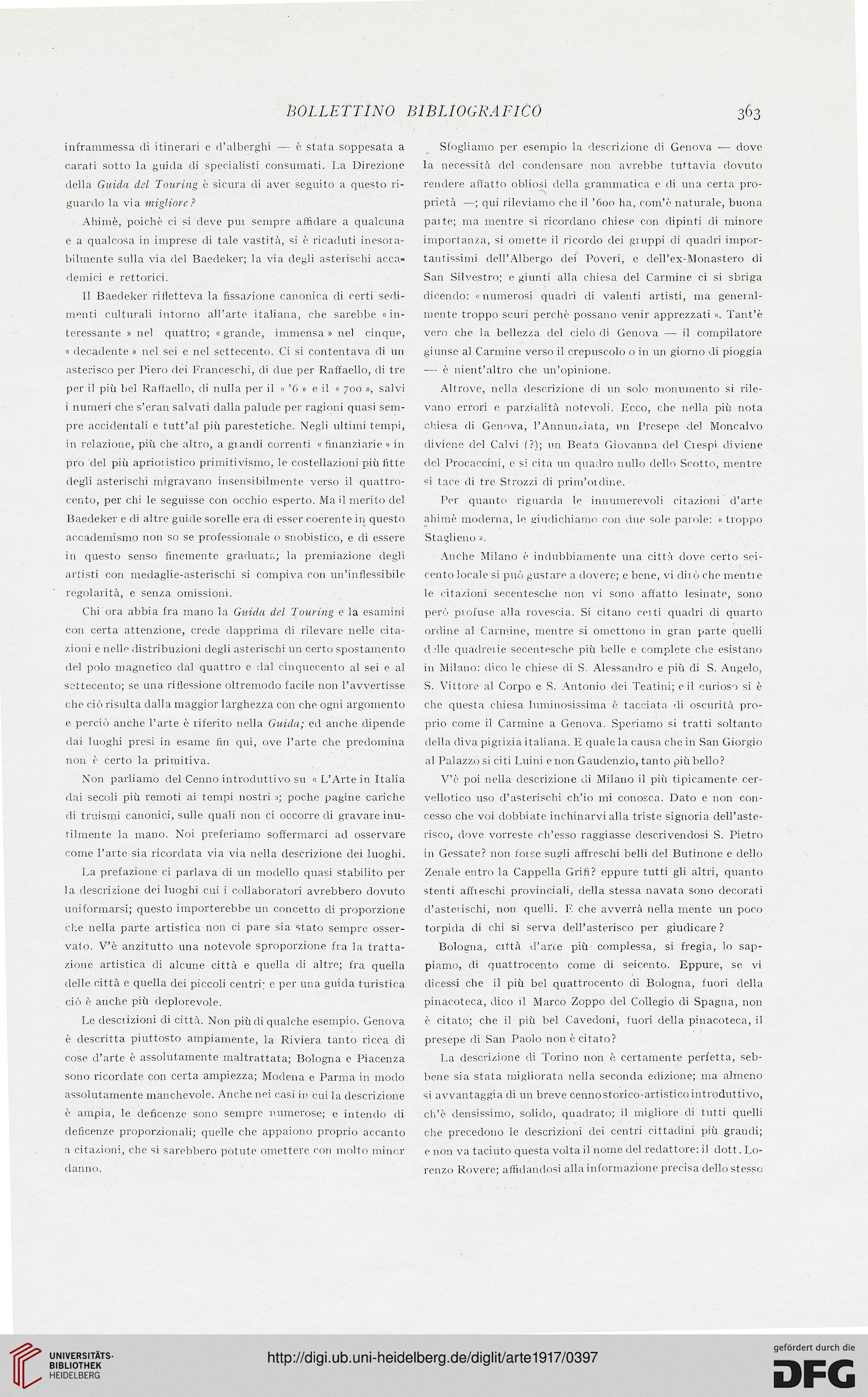BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
363
inframmessa di itinerari e d'alberghi — è stala soppesata a
carati sotto la guida di specialisti consumati. La Direzione
della Guida del Touring è sicura di aver seguito a questo ri-
guardo la via migliore?
Ahimè, poiché ci si deve pui sempre affidare a qualcuna
e a qualcosa in imprese di tale vastità, si è ricaduti inesora-
bilmente sulla via del Baedeker; la via degli asterischi acca-
demici e rettori ci.
Il Baedeker rifletteva la fìssa/ione canonica di certi sedi-
menti culturali intorno all'arte italiana, che sarebbe «in-
teressante » nel quattro; « grande, immensa » nel cinque,
« decadente » nel sei e nel settecento. Ci si contentava di un
asterisco per Piero dei Franceschi, di due per Raffaello, di tre
per il più bel Raffaello, di nulla per il « '6 » e il « 700 », salvi
i numeri che s'eran salvati dalla palude per ragioni quasi sem-
pre accidentali e tutt'al più parestetiche. Negli ultimi tempi,
in relazione, più che altro, a gl andi correnti ti finanziarie » in
prò del più aprioiistieo primitivismo, le costellazioni più fìtte
degli asterischi migravano insensibilmente verso il quattro-
cento, per chi le seguisse con occhio esperto. Ma il merito del
Baedeker e di altre guide sorelle era di esser coerente in questo
accademismo non so se professionale o snobistico, e di essere
in questo senso finemente graduata; la premiazione degli
artisti con medaglie-asterischi si compiva con un'inflessibile
regolarità, e senza omissioni.
Chi ora abbia fra mano la Guida del Touring e la esamini
con certa attenzione, crede dapprima di rilevare nelle cita-
zioni e nelle distribuzioni degli asterischi un certo spostamento
del polo magnetico dal quattro e dal cinquecento al sei e al
settecento; se una riflessione oltremodo facile non l'avvertisse
che ciò risulta dalla maggior larghezza con che ogni argomento
e perciò anche l'arte è riferito nella Guida; ed anche dipende
dai luoghi presi in esame fin qui, ove l'arte che predomina
non è certo la primitiva.
Non parliamo del Cenno introduttivo su « L'Arte in Italia
dai secoli più remoti ai tempi nostri »'; poche pagine cariche
di truismi canonici, sulle quali non ci occorre di gravare inu-
tilmente la mano. Noi preferiamo soffermarci ad osservare
come l'arte sia ricordata via via nella descrizione dei luoghi.
La prefazione ci parlava di un modello quasi stabilito per
la descrizione dei luoghi cui i collaboratori avrebbero dovuto
uniformarsi; questo importerebbe un concetto di proporzione
che nella parte artistica non ci pare sia stato sempre osser-
vato. V'è anzitutto una notevole sproporzione fra la tratta-
zione artistica di alcune città e quella di altre; fra quella
delle città e quella dei piccoli centri; e per una guida turistica
ciò è anche più deplorevole.
Le descrizioni di città. Non più di qualche esempio. Genova
è descritta piuttosto ampiamente, la Riviera tanto ricca di
cose d'arte è assolutamente maltrattata; Bologna e Piacenza
sono ricordate, con certa ampiezza; Modena e Parma in modo
assolutamente manchevole. Anche nei casi ii> cui la descrizione
è ampia, le defìcenze sono sempre numerose; e intendo di
deficenze proporzionali; quelle che appaiono proprio accanto
a citazioni, che si sarebbero potute omettere con molto minor
danno.
Sfogliamo per esempio la descrizione di Genova — dove
la necessità del condensare non avrebbe tuttavia dovuto
rendere affatto obliosi della grammatica e di una certa pro-
prietà —; qui rileviamo che il '600 ha, com'è naturale, buona
pai te; ma mentre si ricordano chiese con dipinti di minore
importanza, si omette il ricordo dei gruppi di quadri impor-
tantissimi dell'Albergo dei Poveri, e dell'ex-Monastero di
San Silvestro; e giunti alla chiesa del Carmine ci si sbriga
dicendo: « numerosi quadri di valenti artisti, ma general-
mente troppo scuri perchè possano venir apprezzati ». Tant'è
vero che la bellezza del cielo di Genova — il compilatore
giunse al Carmine verso il crepuscolo o in un giorno di pioggia
— è nient'altro che un'opinione.
Altrove, nella descrizione di un solo monumento si rile-
vano errori e parzialità notevoli. Ecco, che nella più nota
chiesa di Genova, l'Annunciata, un Presepe del Moncalvo
diviene del Calvi (?}; un Beata Giovanna del Crespi diviene
del Procaccini, e si cita un quadro nullo dello Scotto, mentre
si tace di tre Strozzi di prim'oidine.
Per quanto riguarda le innumerevoli citazioni d'arte
ahimè moderna, le giudichiamo con due sole parole: « troppo
Staglieno »,
Anche Milano è indubbiamente ima città dove certo sei-
cento locale si può gustare a dovere; e bene, vi dirò che mentie
le citazioni secentesche non vi sono affatto lesinate, sono
però profuse alla rovescia. Si citano certi quadri di quarto
ordine al Carmine, mentre si omettono in gran parte quelli
d.ilìe quadrerie secentesche più belle e complete che esistano
in Milano: dico le chiese di S. Alessandro e più di S. Angelo,
S. Vittore al Corpo e S. Antonio dei Teatini; e il curioso si è
che questa chiesa luminosissima è tacciata di oscurità pro-
prio come il Carmine a Genova. Speriamo si tratti soltanto
della diva pigrizia italiana. E quale la causa che in San Giorgio
al Palazzo si citi Luini e non Gaudenzio, tanto più bello?
V'è poi nella descrizione di Milano il più tipicamente cer-
vellotico uso d'asterischi ch'io mi conosca. Dato e non con-
cesso che voi dobbiate inchinarvi alla triste signoria dell'aste-
risco, dove vorreste ch'esso raggiasse descrivendosi S. Pietro
in Gessate? non forse sugli affreschi belli del Bufinone e dello
Zenale entro la Cappella Grifi? eppure tutti gli altri, quanto
stenti affreschi provinciali, della stessa navata sono decorati
d'asterischi, non quelli. F. che avverrà nella mente un poco
torpida di chi si serva dell'asterisco per giudicare?
Bologna, città d'arte più complessa, si fregia, lo sap-
piamo, di quattrocento come di seicento. Eppure, se vi
dicessi che il più bel quattrocento di Bologna, fuori della
pinacoteca, dico il Marco Zoppo del Collegio di Spagna, non
è citato; che il più bel Cavedonr, fuori della pinacoteca, il
presepe di San Paolo non è citato?
La descrizione di Torino non è certamente perfetta, seb-
bene sia stata migliorata nella seconda edizione; ma almeno
si avvantaggia di un breve cennostorico-artistico introduttivo,
ch'è densissimo, solido, quadrato; il migliore di tutti quelli
che precedono le descrizioni dei centri cittadini più grandi;
e non va taciuto questa volta il nome del redattore: il dott. Lo-
renzo Rovere; affidandosi alla informazione precisa dello stesso
363
inframmessa di itinerari e d'alberghi — è stala soppesata a
carati sotto la guida di specialisti consumati. La Direzione
della Guida del Touring è sicura di aver seguito a questo ri-
guardo la via migliore?
Ahimè, poiché ci si deve pui sempre affidare a qualcuna
e a qualcosa in imprese di tale vastità, si è ricaduti inesora-
bilmente sulla via del Baedeker; la via degli asterischi acca-
demici e rettori ci.
Il Baedeker rifletteva la fìssa/ione canonica di certi sedi-
menti culturali intorno all'arte italiana, che sarebbe «in-
teressante » nel quattro; « grande, immensa » nel cinque,
« decadente » nel sei e nel settecento. Ci si contentava di un
asterisco per Piero dei Franceschi, di due per Raffaello, di tre
per il più bel Raffaello, di nulla per il « '6 » e il « 700 », salvi
i numeri che s'eran salvati dalla palude per ragioni quasi sem-
pre accidentali e tutt'al più parestetiche. Negli ultimi tempi,
in relazione, più che altro, a gl andi correnti ti finanziarie » in
prò del più aprioiistieo primitivismo, le costellazioni più fìtte
degli asterischi migravano insensibilmente verso il quattro-
cento, per chi le seguisse con occhio esperto. Ma il merito del
Baedeker e di altre guide sorelle era di esser coerente in questo
accademismo non so se professionale o snobistico, e di essere
in questo senso finemente graduata; la premiazione degli
artisti con medaglie-asterischi si compiva con un'inflessibile
regolarità, e senza omissioni.
Chi ora abbia fra mano la Guida del Touring e la esamini
con certa attenzione, crede dapprima di rilevare nelle cita-
zioni e nelle distribuzioni degli asterischi un certo spostamento
del polo magnetico dal quattro e dal cinquecento al sei e al
settecento; se una riflessione oltremodo facile non l'avvertisse
che ciò risulta dalla maggior larghezza con che ogni argomento
e perciò anche l'arte è riferito nella Guida; ed anche dipende
dai luoghi presi in esame fin qui, ove l'arte che predomina
non è certo la primitiva.
Non parliamo del Cenno introduttivo su « L'Arte in Italia
dai secoli più remoti ai tempi nostri »'; poche pagine cariche
di truismi canonici, sulle quali non ci occorre di gravare inu-
tilmente la mano. Noi preferiamo soffermarci ad osservare
come l'arte sia ricordata via via nella descrizione dei luoghi.
La prefazione ci parlava di un modello quasi stabilito per
la descrizione dei luoghi cui i collaboratori avrebbero dovuto
uniformarsi; questo importerebbe un concetto di proporzione
che nella parte artistica non ci pare sia stato sempre osser-
vato. V'è anzitutto una notevole sproporzione fra la tratta-
zione artistica di alcune città e quella di altre; fra quella
delle città e quella dei piccoli centri; e per una guida turistica
ciò è anche più deplorevole.
Le descrizioni di città. Non più di qualche esempio. Genova
è descritta piuttosto ampiamente, la Riviera tanto ricca di
cose d'arte è assolutamente maltrattata; Bologna e Piacenza
sono ricordate, con certa ampiezza; Modena e Parma in modo
assolutamente manchevole. Anche nei casi ii> cui la descrizione
è ampia, le defìcenze sono sempre numerose; e intendo di
deficenze proporzionali; quelle che appaiono proprio accanto
a citazioni, che si sarebbero potute omettere con molto minor
danno.
Sfogliamo per esempio la descrizione di Genova — dove
la necessità del condensare non avrebbe tuttavia dovuto
rendere affatto obliosi della grammatica e di una certa pro-
prietà —; qui rileviamo che il '600 ha, com'è naturale, buona
pai te; ma mentre si ricordano chiese con dipinti di minore
importanza, si omette il ricordo dei gruppi di quadri impor-
tantissimi dell'Albergo dei Poveri, e dell'ex-Monastero di
San Silvestro; e giunti alla chiesa del Carmine ci si sbriga
dicendo: « numerosi quadri di valenti artisti, ma general-
mente troppo scuri perchè possano venir apprezzati ». Tant'è
vero che la bellezza del cielo di Genova — il compilatore
giunse al Carmine verso il crepuscolo o in un giorno di pioggia
— è nient'altro che un'opinione.
Altrove, nella descrizione di un solo monumento si rile-
vano errori e parzialità notevoli. Ecco, che nella più nota
chiesa di Genova, l'Annunciata, un Presepe del Moncalvo
diviene del Calvi (?}; un Beata Giovanna del Crespi diviene
del Procaccini, e si cita un quadro nullo dello Scotto, mentre
si tace di tre Strozzi di prim'oidine.
Per quanto riguarda le innumerevoli citazioni d'arte
ahimè moderna, le giudichiamo con due sole parole: « troppo
Staglieno »,
Anche Milano è indubbiamente ima città dove certo sei-
cento locale si può gustare a dovere; e bene, vi dirò che mentie
le citazioni secentesche non vi sono affatto lesinate, sono
però profuse alla rovescia. Si citano certi quadri di quarto
ordine al Carmine, mentre si omettono in gran parte quelli
d.ilìe quadrerie secentesche più belle e complete che esistano
in Milano: dico le chiese di S. Alessandro e più di S. Angelo,
S. Vittore al Corpo e S. Antonio dei Teatini; e il curioso si è
che questa chiesa luminosissima è tacciata di oscurità pro-
prio come il Carmine a Genova. Speriamo si tratti soltanto
della diva pigrizia italiana. E quale la causa che in San Giorgio
al Palazzo si citi Luini e non Gaudenzio, tanto più bello?
V'è poi nella descrizione di Milano il più tipicamente cer-
vellotico uso d'asterischi ch'io mi conosca. Dato e non con-
cesso che voi dobbiate inchinarvi alla triste signoria dell'aste-
risco, dove vorreste ch'esso raggiasse descrivendosi S. Pietro
in Gessate? non forse sugli affreschi belli del Bufinone e dello
Zenale entro la Cappella Grifi? eppure tutti gli altri, quanto
stenti affreschi provinciali, della stessa navata sono decorati
d'asterischi, non quelli. F. che avverrà nella mente un poco
torpida di chi si serva dell'asterisco per giudicare?
Bologna, città d'arte più complessa, si fregia, lo sap-
piamo, di quattrocento come di seicento. Eppure, se vi
dicessi che il più bel quattrocento di Bologna, fuori della
pinacoteca, dico il Marco Zoppo del Collegio di Spagna, non
è citato; che il più bel Cavedonr, fuori della pinacoteca, il
presepe di San Paolo non è citato?
La descrizione di Torino non è certamente perfetta, seb-
bene sia stata migliorata nella seconda edizione; ma almeno
si avvantaggia di un breve cennostorico-artistico introduttivo,
ch'è densissimo, solido, quadrato; il migliore di tutti quelli
che precedono le descrizioni dei centri cittadini più grandi;
e non va taciuto questa volta il nome del redattore: il dott. Lo-
renzo Rovere; affidandosi alla informazione precisa dello stesso