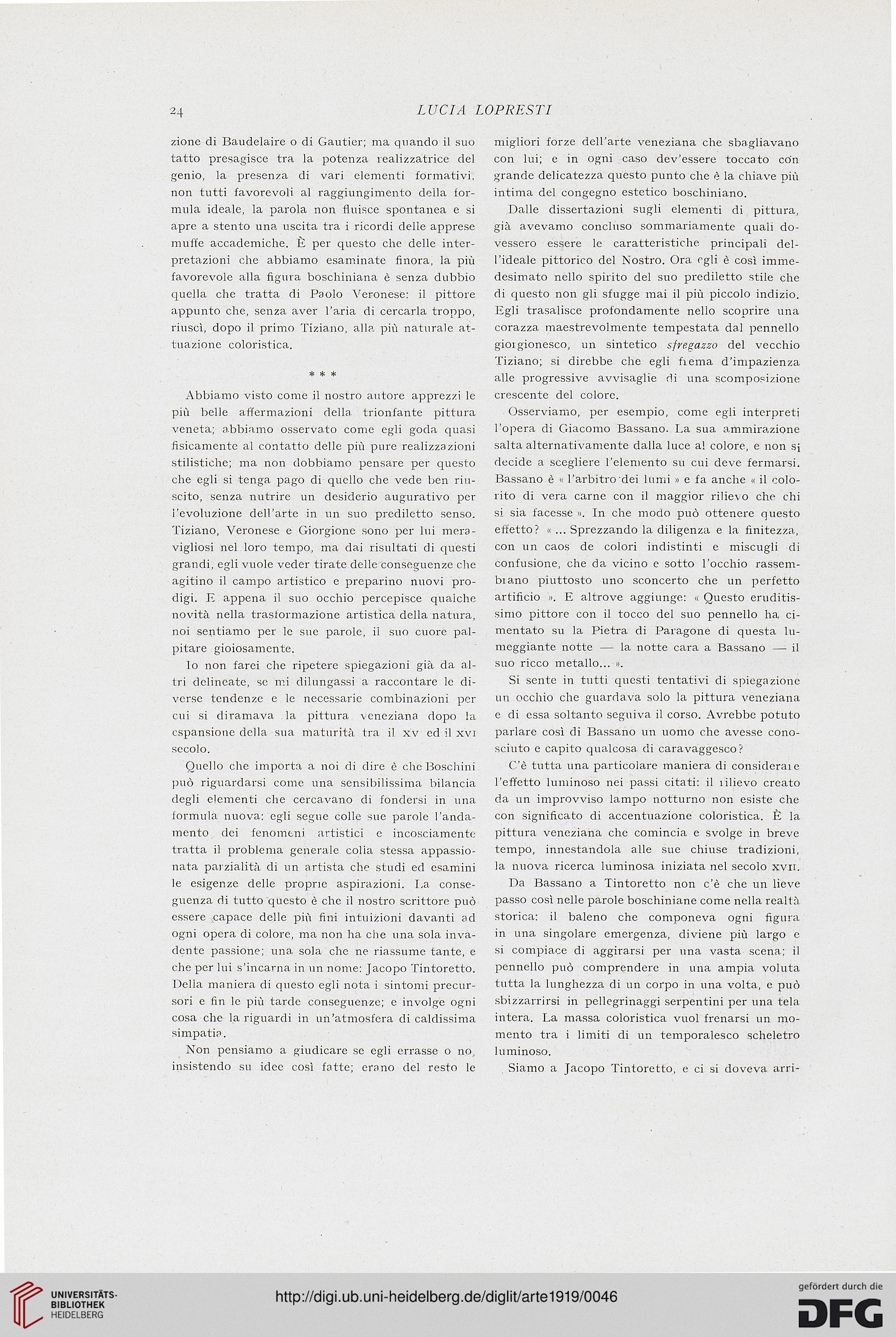24
LUCIA LOPRKSTI
zionc di Baudelaire o di Gautier; ma quando il suo
latto presagisce tra la potenza realizzatrice del
genio, la presenza di vari elementi formativi,
non tutti favorevoli al raggiungimento della for-
mula ideale, la parola non fluisce spontanea e si
apre a stento una uscita tra i ricordi delle apprese
muffe accademiche. È per questo che delle inter-
pretazioni che abbiamo esaminate finora, la più
favorevole alla figura boschiniana è senza dubbio
quella che tratta di Paolo Veronese: il pittore
appunto che, senza aver l'aria di cercarla troppo,
riuscì, dopo il primo Tiziano, alla più naturale at-
tuazione coloristica.
* * *
Abbiamo visto come il nostro autore apprezzi le
più belle affermazioni della trionfante pittura
veneta; abbiamo osservato come egli goda quasi
fisicamente al contatto delle più pure realizzazioni
stilistiche; ma non dobbiamo pensare per questo
che egli si tenga pago di quello che vede ben riu-
scito, senza nutrire un desiderio augurativo per
l'evoluzione dell'arte in un suo prediletto senso.
Tiziano, Veronese e Giorgionc sono per lui mera-
vigliosi nel loro tempo, ma dai risultati di questi
grandi, egli vuole veder tirate delle conseguenze che
agitino il campo artistico e preparino nuovi pro-
digi, lì appena il suo occhio percepisce qualche
novità nella trasformazione artistica della natura,
noi sentiamo per le sue parole, il suo cuore pal-
pitare gioiosamente.
Io non farci che ripetere spiegazioni già da al-
iti delincate, se mi dilungassi a raccontare le di-
verse tendenze e le necessarie combinazioni per
cui si diramava la pittura \ cneziana dopo la
espansione della sua maturità tra il xv ed il xvi
secolo.
Quello che importa a noi di dire è che Boschini
può riguardarsi come una sensibilissima bilancia
degli clementi che cercavano di fondersi in una
lormula nuova: egli segue colle sue parole l'anda-
mento dei fenomeni artistici e incosciamente
tratta il problema generale colia stessa appassio-
nata parzialità di un artista che studi ed esamini
le esigenze delle proprie aspirazioni. I.a conse-
guenza di tutto questo è che il nostro scrittore può
essere capace delle più fini intuizioni davanti ad
ogni opera di colore, ma non ha che una sola inva-
dente passione; una sola che ne riassume tante, e
che per lui s'incarna in un nome: Jacopo Tintoretto.
Delia maniera di questo egli nota i sintomi precur-
sori e fin le più tarde conseguenze; e involge ogni
cosa che la riguardi in un'atmosfera di caldissima
simpatia.
Non pensiamo a giudicare se egli errasse o no,
insistendo su idee così fatte; erano del resto le
migliori forze dell'arte veneziana che sbagliavano
con lui; e in ogni caso dev'essere toccato con
grande delicatezza questo punto che è la chiave più
intima del congegno estetico boschiniano.
Dalle dissertazioni sugli elementi di pittura,
già avevamo concluso sommariamente quali do-
vessero essere le caratteristiche principali del-
l'ideale pittorico del Nostro. Ora egli è così imme-
desimato nello spirito del suo prediletto stile che
di questo non gli sfugge mai il più piccolo indizio.
Egli trasalisce profondamente nello scoprire una
corazza maestrevolmente tempestata dal pennello
gioì gionesco, un sintetico sfregazzo del vecchio
Tiziano; si direbbe che egli fiema d'impazienza
alle progressive avvisaglie di una scomposizione
crescente del colore.
Osserviamo, per esempio, come egli interpreti
l'opera di Giacomo Bassano. Da sua ammirazione
salta alternativamente dalla luce a! colore, e non si
decide a scegliere l'elemento su cui deve fermarsi.
Bassano è « l'arbitro dei lumi » e fa anche « il colo-
rito di vera carne con il maggior rilie\o che chi
si sia facesse ». In che modo può ottenere questo
effetto? « ... Sprezzando la diligenza e la finitezza,
con un caos de colori indistinti e miscugli di
confusione, che da vicino e sotto l'occhio rassem-
biano piuttosto uno sconcerto che un perfetto
artifìcio ». E altrove aggiunge: « Questo eruditis-
simo pittore con il tocco del suo pennello ha ci-
mentato su la Pietra di Paragone di questa lu-
meggiante notte — la notte cara a Bassano — il
suo ricco metallo... ».
Si sente in tutti questi tentativi di spiegazione
un occhio che guardava solo la pittura veneziana
e di essa soltanto seguiva il corso. Avrebbe potuto
parlare così di Bassano un uomo che avesse cono-
sciuto e capito qualcosa di caravaggesco?
C'è tutta una particolare maniera di considerale
l'effetto luminoso nei passi citati: il ìilievo creato
da un improvviso lampo notturno non esiste che
con significato di accentuazione coloristica. È la
pittura veneziana che comincia e svolge in breve
tempo, innestandola alle sue chiuse tradizioni,
la nuova ricerca luminosa iniziata nel secolo xvn.
Da Bassano a Tintoretto non c'è che un liève
passo così nelle parole boschiniane come nella realtà
storica: il baleno che componeva ogni figura
in una singolare emergenza, diviene più largo e
si compiace di aggirarsi per una vasta scena; il
pennello può comprendere in una ampia voluta
tutta la lunghezza di un corpo in una volta, e può
sbizzarrirsi in pellegrinaggi serpentini per una tela
intera. La massa coloristica vuol frenarsi un mo-
mento tra i limiti di un temporalesco scheletro
luminoso.
Siamo a Jacopo Tintoretto, e ci si doveva arri-
LUCIA LOPRKSTI
zionc di Baudelaire o di Gautier; ma quando il suo
latto presagisce tra la potenza realizzatrice del
genio, la presenza di vari elementi formativi,
non tutti favorevoli al raggiungimento della for-
mula ideale, la parola non fluisce spontanea e si
apre a stento una uscita tra i ricordi delle apprese
muffe accademiche. È per questo che delle inter-
pretazioni che abbiamo esaminate finora, la più
favorevole alla figura boschiniana è senza dubbio
quella che tratta di Paolo Veronese: il pittore
appunto che, senza aver l'aria di cercarla troppo,
riuscì, dopo il primo Tiziano, alla più naturale at-
tuazione coloristica.
* * *
Abbiamo visto come il nostro autore apprezzi le
più belle affermazioni della trionfante pittura
veneta; abbiamo osservato come egli goda quasi
fisicamente al contatto delle più pure realizzazioni
stilistiche; ma non dobbiamo pensare per questo
che egli si tenga pago di quello che vede ben riu-
scito, senza nutrire un desiderio augurativo per
l'evoluzione dell'arte in un suo prediletto senso.
Tiziano, Veronese e Giorgionc sono per lui mera-
vigliosi nel loro tempo, ma dai risultati di questi
grandi, egli vuole veder tirate delle conseguenze che
agitino il campo artistico e preparino nuovi pro-
digi, lì appena il suo occhio percepisce qualche
novità nella trasformazione artistica della natura,
noi sentiamo per le sue parole, il suo cuore pal-
pitare gioiosamente.
Io non farci che ripetere spiegazioni già da al-
iti delincate, se mi dilungassi a raccontare le di-
verse tendenze e le necessarie combinazioni per
cui si diramava la pittura \ cneziana dopo la
espansione della sua maturità tra il xv ed il xvi
secolo.
Quello che importa a noi di dire è che Boschini
può riguardarsi come una sensibilissima bilancia
degli clementi che cercavano di fondersi in una
lormula nuova: egli segue colle sue parole l'anda-
mento dei fenomeni artistici e incosciamente
tratta il problema generale colia stessa appassio-
nata parzialità di un artista che studi ed esamini
le esigenze delle proprie aspirazioni. I.a conse-
guenza di tutto questo è che il nostro scrittore può
essere capace delle più fini intuizioni davanti ad
ogni opera di colore, ma non ha che una sola inva-
dente passione; una sola che ne riassume tante, e
che per lui s'incarna in un nome: Jacopo Tintoretto.
Delia maniera di questo egli nota i sintomi precur-
sori e fin le più tarde conseguenze; e involge ogni
cosa che la riguardi in un'atmosfera di caldissima
simpatia.
Non pensiamo a giudicare se egli errasse o no,
insistendo su idee così fatte; erano del resto le
migliori forze dell'arte veneziana che sbagliavano
con lui; e in ogni caso dev'essere toccato con
grande delicatezza questo punto che è la chiave più
intima del congegno estetico boschiniano.
Dalle dissertazioni sugli elementi di pittura,
già avevamo concluso sommariamente quali do-
vessero essere le caratteristiche principali del-
l'ideale pittorico del Nostro. Ora egli è così imme-
desimato nello spirito del suo prediletto stile che
di questo non gli sfugge mai il più piccolo indizio.
Egli trasalisce profondamente nello scoprire una
corazza maestrevolmente tempestata dal pennello
gioì gionesco, un sintetico sfregazzo del vecchio
Tiziano; si direbbe che egli fiema d'impazienza
alle progressive avvisaglie di una scomposizione
crescente del colore.
Osserviamo, per esempio, come egli interpreti
l'opera di Giacomo Bassano. Da sua ammirazione
salta alternativamente dalla luce a! colore, e non si
decide a scegliere l'elemento su cui deve fermarsi.
Bassano è « l'arbitro dei lumi » e fa anche « il colo-
rito di vera carne con il maggior rilie\o che chi
si sia facesse ». In che modo può ottenere questo
effetto? « ... Sprezzando la diligenza e la finitezza,
con un caos de colori indistinti e miscugli di
confusione, che da vicino e sotto l'occhio rassem-
biano piuttosto uno sconcerto che un perfetto
artifìcio ». E altrove aggiunge: « Questo eruditis-
simo pittore con il tocco del suo pennello ha ci-
mentato su la Pietra di Paragone di questa lu-
meggiante notte — la notte cara a Bassano — il
suo ricco metallo... ».
Si sente in tutti questi tentativi di spiegazione
un occhio che guardava solo la pittura veneziana
e di essa soltanto seguiva il corso. Avrebbe potuto
parlare così di Bassano un uomo che avesse cono-
sciuto e capito qualcosa di caravaggesco?
C'è tutta una particolare maniera di considerale
l'effetto luminoso nei passi citati: il ìilievo creato
da un improvviso lampo notturno non esiste che
con significato di accentuazione coloristica. È la
pittura veneziana che comincia e svolge in breve
tempo, innestandola alle sue chiuse tradizioni,
la nuova ricerca luminosa iniziata nel secolo xvn.
Da Bassano a Tintoretto non c'è che un liève
passo così nelle parole boschiniane come nella realtà
storica: il baleno che componeva ogni figura
in una singolare emergenza, diviene più largo e
si compiace di aggirarsi per una vasta scena; il
pennello può comprendere in una ampia voluta
tutta la lunghezza di un corpo in una volta, e può
sbizzarrirsi in pellegrinaggi serpentini per una tela
intera. La massa coloristica vuol frenarsi un mo-
mento tra i limiti di un temporalesco scheletro
luminoso.
Siamo a Jacopo Tintoretto, e ci si doveva arri-