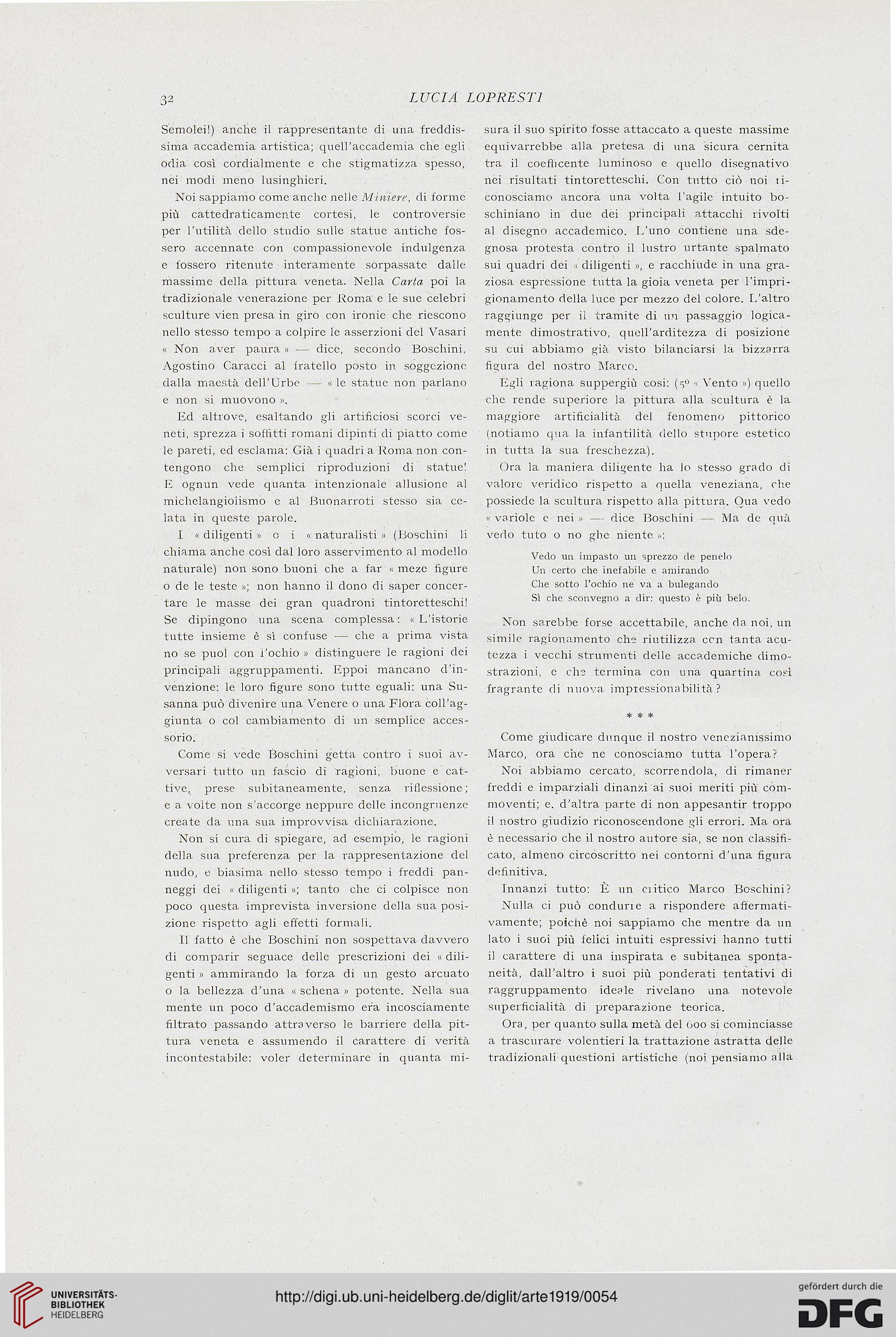32
LUCIA LO PRESTI
Semolei!) anche il rappresentante di una freddis-
sima accademia artistica; quell'accademia che egli
odia così cordialmente e che stigmatizza spesso,
nei modi meno lusinghieri.
Noi sappiamo come anche nelle Miniere, di forme
più cattedraticamente cortesi, le controversie
per l'utilità dello studio sulle statue antiche fos-
sero accennate con compassionevole indulgenza
e fossero ritenute interamente sorpassate dalle
massime della pittura veneta. Nella Carta poi la
tradizionale venerazione per Roma e le sue celebri
sculture vien presa in giro con ironie che riescono
nello stesso tempo a colpire le asserzioni del Vasari
« Non aver paura » — dice, secondo Boschini,
Agostino Caracci al fratello posto in soggezione
dalla maestà dell'Urbe — «le statue non parlano
e non si muovono ».
Ed altrove, esaltando gli artificiosi scorci ve-
neti, sprezza i soffitti romani dipinti di piatto come
le pareti, ed esclama: Già i quadri a Roma non con-
tengono che semplici riproduzioni di statue!
E ognun vede quanta intenzionale allusione al
michelangioiismo e al Buonarroti stesso sia ce-
lata in queste parole.
[ « diligenti » o i « naturalisti » (Boschini li
chiama anche così dal loro asservimento al modello
naturale) non sono buoni che a far « meze figure
o de le teste »; non hanno il dono di saper concer-
tare le masse dei gran quadroni tintoretteschi!
Se dipingono una scena complessa : « L'istorie
tutte insieme è sì confuse ■— che a prima vista
no se puoi con i'ochio » distinguere le ragioni dei
principali aggruppamenti. Eppoi mancano d'in-
venzione: le loro figure sono tutte eguali: una Su-
sanna può divenire una Venere o una Flora coll'ag-
giunta o col cambiamento di uri semplice acces-
sorio.
Come si vede Boschini getta contro i suoi av-
versari tutto un fascio di ragioni, linone e cat-
tive, prese subitaneamente, senza riflessione;
e a volte non s'accorge neppure delle incongruenze
create da una sua improvvisa dichiarazione.
Non si cura di spiegare, ad esempio, le ragioni
della sua preferenza per la rappresentazione del
nudo, e biasima nello stesso tempo i freddi pan-
neggi dei « diligenti »; tanto che ci colpisce non
poco questa imprevista inversione della sua posi-
zione rispetto agli effetti formali.
ti fatto è che Boschini non sospettava davvero
di comparir seguace delle prescrizioni dei « dili-
genti » ammirando la forza di un gesto arcuato
o la bellezza d'una « schena » potente. Nella sua
mente un poco d'accademismo era incosciamente
filtrato passando attraverso le barriere della pit-
tura veneta e assumendo il carattere di verità
incontestabile: voler determinare in quanta mi-
sura il suo spirito fosse attaccato a queste massime
equivarrebbe alla pretesa di una sicura cernita
tra il coeflicente luminoso e quello disegnativo
nei risultati tintoretteschi. Con tutto ciò noi i i-
conosciamo ancora una volta l'agile intuito bo-
schiniano in due dei principali attacchi rivolti
al disegno accademico. L'uno contiene una sde-
gnosa protesta contro il lustro urtante spalmato
sui quadri dei « diligenti », e racchiude in una gra-
ziosa espressione tutta la gioia veneta per l'impri-
gionamento della luce per mezzo del colore, [.'altro
raggiunge per iì tramite di un passaggio logica-
mente dimostrativo, quell'arditezza di posizione
su cui abbiamo già visto bilanciarsi la bizzarra
figura del nostro Marco.
Egli ragiona suppergiù cosi: (50 < Vento ») quello
che rende superiore la pittura alla scultura è la
maggiore artificialità del fenomeno pittorico
(notiamo qua la infantilità dello stupore estetico
in tutta la sua freschezza).
Ora la maniera diligente ha lo stesso grado di
valore veridico rispetto a quella veneziana, che
possiede la scultura rispetto alla pittura. Qua vedo
« variole e nei» — dice Boschini — Ma de quà
vedo tufo o no ghe niente »:
Vedo un impasto un sprezzo eie pendo
Un certo che inefabìle e amirando
Che sotto I'ochio ne va a bulegando
Sì che sconvegno a dir: questo è più belo.
Non sarebbe forse accettabile, anche da noi, un
simile ragionamento che riutilizza, ccn tanta acu-
tezza i vecchi strumenti delle accademiche dimo-
strazioni, e che termina con una quartina così
fragrante di nuova impressionabilità ?
* * *
Come giudicare dunque il nostro venezianissimo
Marco, ora che ne conosciamo tutta l'opera?
Noi abbiamo cercato, scorrendola, di rimaner
freddi e imparziali dinanzi ai suoi meriti più com-
moventi; e. d'altra parte di non appesantir troppo
il nostro giudizio riconoscendone gli errori. Ma ora
è necessario che il nostro autore sia, se non classifi-
cato, almeno circoscritto nei contorni d'una figura
definitiva.
innanzi tutto: È un ciitico Marco Boschini?
Nulla, ci può condurle a rispondere affermati-
vamente; poiché noi sappiamo che mentre da un
lato i suoi più felici intuiti espressivi hanno tutti
il carattere di una inspirata e subitanea sponta-
neità, dall'altro i suoi più ponderati tentativi di
raggruppamento ideale rivelano una notevole
superficialità di preparazione teorica.
Ora, per quanto sulla metà del 000 si cominciasse
a trascurare volentieri la trattazione astratta delle
tradizionali questioni artistiche (noi pensiamo alla
LUCIA LO PRESTI
Semolei!) anche il rappresentante di una freddis-
sima accademia artistica; quell'accademia che egli
odia così cordialmente e che stigmatizza spesso,
nei modi meno lusinghieri.
Noi sappiamo come anche nelle Miniere, di forme
più cattedraticamente cortesi, le controversie
per l'utilità dello studio sulle statue antiche fos-
sero accennate con compassionevole indulgenza
e fossero ritenute interamente sorpassate dalle
massime della pittura veneta. Nella Carta poi la
tradizionale venerazione per Roma e le sue celebri
sculture vien presa in giro con ironie che riescono
nello stesso tempo a colpire le asserzioni del Vasari
« Non aver paura » — dice, secondo Boschini,
Agostino Caracci al fratello posto in soggezione
dalla maestà dell'Urbe — «le statue non parlano
e non si muovono ».
Ed altrove, esaltando gli artificiosi scorci ve-
neti, sprezza i soffitti romani dipinti di piatto come
le pareti, ed esclama: Già i quadri a Roma non con-
tengono che semplici riproduzioni di statue!
E ognun vede quanta intenzionale allusione al
michelangioiismo e al Buonarroti stesso sia ce-
lata in queste parole.
[ « diligenti » o i « naturalisti » (Boschini li
chiama anche così dal loro asservimento al modello
naturale) non sono buoni che a far « meze figure
o de le teste »; non hanno il dono di saper concer-
tare le masse dei gran quadroni tintoretteschi!
Se dipingono una scena complessa : « L'istorie
tutte insieme è sì confuse ■— che a prima vista
no se puoi con i'ochio » distinguere le ragioni dei
principali aggruppamenti. Eppoi mancano d'in-
venzione: le loro figure sono tutte eguali: una Su-
sanna può divenire una Venere o una Flora coll'ag-
giunta o col cambiamento di uri semplice acces-
sorio.
Come si vede Boschini getta contro i suoi av-
versari tutto un fascio di ragioni, linone e cat-
tive, prese subitaneamente, senza riflessione;
e a volte non s'accorge neppure delle incongruenze
create da una sua improvvisa dichiarazione.
Non si cura di spiegare, ad esempio, le ragioni
della sua preferenza per la rappresentazione del
nudo, e biasima nello stesso tempo i freddi pan-
neggi dei « diligenti »; tanto che ci colpisce non
poco questa imprevista inversione della sua posi-
zione rispetto agli effetti formali.
ti fatto è che Boschini non sospettava davvero
di comparir seguace delle prescrizioni dei « dili-
genti » ammirando la forza di un gesto arcuato
o la bellezza d'una « schena » potente. Nella sua
mente un poco d'accademismo era incosciamente
filtrato passando attraverso le barriere della pit-
tura veneta e assumendo il carattere di verità
incontestabile: voler determinare in quanta mi-
sura il suo spirito fosse attaccato a queste massime
equivarrebbe alla pretesa di una sicura cernita
tra il coeflicente luminoso e quello disegnativo
nei risultati tintoretteschi. Con tutto ciò noi i i-
conosciamo ancora una volta l'agile intuito bo-
schiniano in due dei principali attacchi rivolti
al disegno accademico. L'uno contiene una sde-
gnosa protesta contro il lustro urtante spalmato
sui quadri dei « diligenti », e racchiude in una gra-
ziosa espressione tutta la gioia veneta per l'impri-
gionamento della luce per mezzo del colore, [.'altro
raggiunge per iì tramite di un passaggio logica-
mente dimostrativo, quell'arditezza di posizione
su cui abbiamo già visto bilanciarsi la bizzarra
figura del nostro Marco.
Egli ragiona suppergiù cosi: (50 < Vento ») quello
che rende superiore la pittura alla scultura è la
maggiore artificialità del fenomeno pittorico
(notiamo qua la infantilità dello stupore estetico
in tutta la sua freschezza).
Ora la maniera diligente ha lo stesso grado di
valore veridico rispetto a quella veneziana, che
possiede la scultura rispetto alla pittura. Qua vedo
« variole e nei» — dice Boschini — Ma de quà
vedo tufo o no ghe niente »:
Vedo un impasto un sprezzo eie pendo
Un certo che inefabìle e amirando
Che sotto I'ochio ne va a bulegando
Sì che sconvegno a dir: questo è più belo.
Non sarebbe forse accettabile, anche da noi, un
simile ragionamento che riutilizza, ccn tanta acu-
tezza i vecchi strumenti delle accademiche dimo-
strazioni, e che termina con una quartina così
fragrante di nuova impressionabilità ?
* * *
Come giudicare dunque il nostro venezianissimo
Marco, ora che ne conosciamo tutta l'opera?
Noi abbiamo cercato, scorrendola, di rimaner
freddi e imparziali dinanzi ai suoi meriti più com-
moventi; e. d'altra parte di non appesantir troppo
il nostro giudizio riconoscendone gli errori. Ma ora
è necessario che il nostro autore sia, se non classifi-
cato, almeno circoscritto nei contorni d'una figura
definitiva.
innanzi tutto: È un ciitico Marco Boschini?
Nulla, ci può condurle a rispondere affermati-
vamente; poiché noi sappiamo che mentre da un
lato i suoi più felici intuiti espressivi hanno tutti
il carattere di una inspirata e subitanea sponta-
neità, dall'altro i suoi più ponderati tentativi di
raggruppamento ideale rivelano una notevole
superficialità di preparazione teorica.
Ora, per quanto sulla metà del 000 si cominciasse
a trascurare volentieri la trattazione astratta delle
tradizionali questioni artistiche (noi pensiamo alla