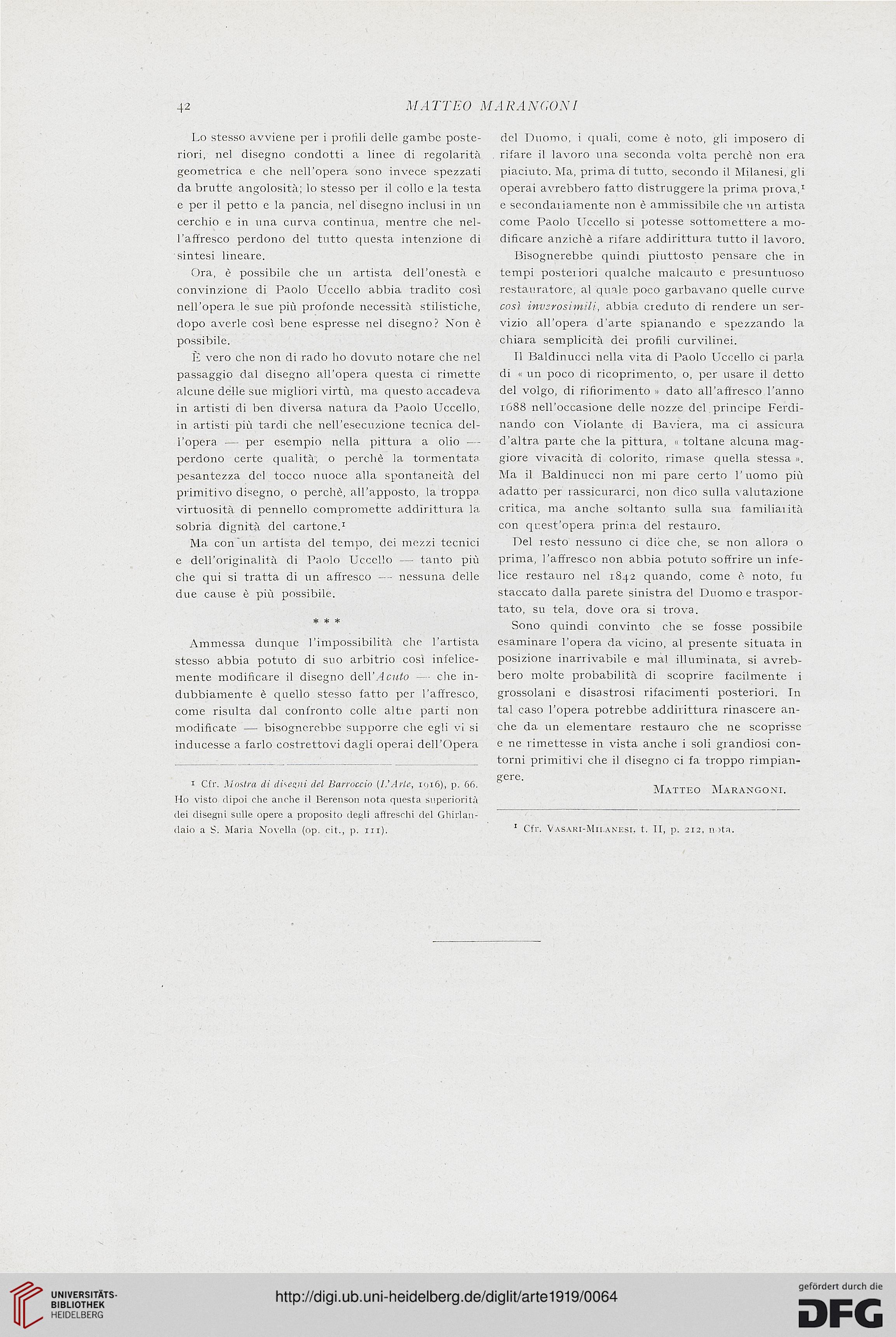42
MATTEO MARANGONI
Lo stesso avviene per i profili delle gambe poste-
riori, nel disegno eondotti a linee di regolarità
geometrica e che nell'opera sono invece spezzati
da brutte angolosità; lo stesso per il collo e la testa
e per il petto e la pancia, nel'disegno inclusi in un
cerchio e in una curva continua, mentre che nel-
l'affresco perdono del tutto questa intenzione di
sintesi lineare.
Ora, è possibile che un artista dell'onestà e
convinzione di Paolo Uccello abbia tradito così
nell'opera.le sue più profonde necessità stilistiche,
dopo averle così bene espresse nel disegno? Non è
possibile.
È vero che non di rado ho dovuto notare che nel
passaggio dal disegno all'opera questa ci rimette
alcune delle sue migliori virtù, ma questo accadeva
in artisti di ben diversa natura da Paolo Uccello,
in artisti più tardi che nell'esecuzione tecnica del-
l'opera — per esempio nella pittura a olio -
perdono certe qualità'; o perchè la tormentata
pesantezza del tocco nuoce alla spontaneità del
primitivo disegno, o perchè, all'apposto, la troppa
virtuosità di pennello compromette addirittura la
sobria dignità del cartone.1
Ma con un artista del tempo, dei mezzi tecnici
e dell'originalità di Paolo Uccello — tanto più
che qui si tratta di un affresco —- nessuna delle
due cause è più possibile.
# * *
Ammessa dunque l'impossibilità che l'artista
stesso abbia potuto di suo arbitrio così infelice-
mente modificare il disegno dell'Acuto — che in-
dubbiamente è quello stesso fatto per l'affresco,
come risulta dal confronto colle altie parti non
modificate — bisognerebbe supporre che egli vi si
inducesse a farlo costrettovi dagli operai dell'Opera
1 Cfr. Mostra di diselli del Barroccio (L'Arie, 1916), p. 66.
Ho visto dipoi che anche il Berenson nota questa superiorità
dei disegni sulle opere a proposito degli affreschi del Ghirlan-
daio a S. Maria Novella (op. cit., p. in).
del Duomo, i quali, come è noto, gli imposero di
rifare il lavoro una seconda volta perchè non era
piaciuto. Ma, prima di tutto, secondo il Milanesi, gli
operai avrebbero fatto distruggere la prima prova,1
e secondaiiamente non è ammissibile che un artista
come Paolo Uccello si potesse sottomettere a mo-
dificare anziché a rifare addirittura tutto il lavoro.
Bisognerebbe quindi piuttosto pensare che in
tempi posteriori qualche malcauto e presuntuoso
restauratore, al quale poco garbavano quelle curve
così inv2r0sim.il7, abbia cteduto di rendere un ser-
vizio all'opera d'arte spianando e spezzando la
chiara semplicità dei profili curvilinei.
11 Baldinucci nella vita di Paolo Uccello ci parla
di « un poco di ricoprimento, o, per usare il detto
del volgo, di rifiorimento « dato all'affresco l'anno
1688 nell'occasione delle nozze del. principe Ferdi-
nando con Violante di Baviera, ma ci assicura
d'altra parte che la pittura, .1 toltane alcuna mag-
giore vivacità di colorito, rimase quella stessa ».
Ma il Baldinucci non mi pare certo l'uomo più
adatto per rassicurarci, non dico sulla valutazione
critica, ma anche soltanto sulla sua familiaiità
con quest'opera prima del restauro.
Del resto nessuno ci dice che, se non allora o
prima, l'affresco non abbia potuto soffrire un infe-
lice restauro nel 1842 quando, come è noto, fu
staccato dalla parete sinistra del Duomo e traspor-
tato, su tela, dove ora si trova.
Sono quindi convinto che se fosse possibile
esaminare l'opera da vicino, al presente situata, in
posizione inarrivabile e mal illuminata, si avreb-
bero molte probabilità di scoprire facilmente i
grossolani e disastrosi rifacimenti posteriori. In
tal caso l'opera potrebbe addirittura rinascere an-
che da un elementare restauro che ne scoprisse
e ne rimettesse in vista anche i soli grandiosi con-
torni primitivi che il disegno ci fa troppo rimpian-
gere.
Matteo Marangoni.
1 Cfr. Vasari-Milanesi, t. II, p. 212, nota.
MATTEO MARANGONI
Lo stesso avviene per i profili delle gambe poste-
riori, nel disegno eondotti a linee di regolarità
geometrica e che nell'opera sono invece spezzati
da brutte angolosità; lo stesso per il collo e la testa
e per il petto e la pancia, nel'disegno inclusi in un
cerchio e in una curva continua, mentre che nel-
l'affresco perdono del tutto questa intenzione di
sintesi lineare.
Ora, è possibile che un artista dell'onestà e
convinzione di Paolo Uccello abbia tradito così
nell'opera.le sue più profonde necessità stilistiche,
dopo averle così bene espresse nel disegno? Non è
possibile.
È vero che non di rado ho dovuto notare che nel
passaggio dal disegno all'opera questa ci rimette
alcune delle sue migliori virtù, ma questo accadeva
in artisti di ben diversa natura da Paolo Uccello,
in artisti più tardi che nell'esecuzione tecnica del-
l'opera — per esempio nella pittura a olio -
perdono certe qualità'; o perchè la tormentata
pesantezza del tocco nuoce alla spontaneità del
primitivo disegno, o perchè, all'apposto, la troppa
virtuosità di pennello compromette addirittura la
sobria dignità del cartone.1
Ma con un artista del tempo, dei mezzi tecnici
e dell'originalità di Paolo Uccello — tanto più
che qui si tratta di un affresco —- nessuna delle
due cause è più possibile.
# * *
Ammessa dunque l'impossibilità che l'artista
stesso abbia potuto di suo arbitrio così infelice-
mente modificare il disegno dell'Acuto — che in-
dubbiamente è quello stesso fatto per l'affresco,
come risulta dal confronto colle altie parti non
modificate — bisognerebbe supporre che egli vi si
inducesse a farlo costrettovi dagli operai dell'Opera
1 Cfr. Mostra di diselli del Barroccio (L'Arie, 1916), p. 66.
Ho visto dipoi che anche il Berenson nota questa superiorità
dei disegni sulle opere a proposito degli affreschi del Ghirlan-
daio a S. Maria Novella (op. cit., p. in).
del Duomo, i quali, come è noto, gli imposero di
rifare il lavoro una seconda volta perchè non era
piaciuto. Ma, prima di tutto, secondo il Milanesi, gli
operai avrebbero fatto distruggere la prima prova,1
e secondaiiamente non è ammissibile che un artista
come Paolo Uccello si potesse sottomettere a mo-
dificare anziché a rifare addirittura tutto il lavoro.
Bisognerebbe quindi piuttosto pensare che in
tempi posteriori qualche malcauto e presuntuoso
restauratore, al quale poco garbavano quelle curve
così inv2r0sim.il7, abbia cteduto di rendere un ser-
vizio all'opera d'arte spianando e spezzando la
chiara semplicità dei profili curvilinei.
11 Baldinucci nella vita di Paolo Uccello ci parla
di « un poco di ricoprimento, o, per usare il detto
del volgo, di rifiorimento « dato all'affresco l'anno
1688 nell'occasione delle nozze del. principe Ferdi-
nando con Violante di Baviera, ma ci assicura
d'altra parte che la pittura, .1 toltane alcuna mag-
giore vivacità di colorito, rimase quella stessa ».
Ma il Baldinucci non mi pare certo l'uomo più
adatto per rassicurarci, non dico sulla valutazione
critica, ma anche soltanto sulla sua familiaiità
con quest'opera prima del restauro.
Del resto nessuno ci dice che, se non allora o
prima, l'affresco non abbia potuto soffrire un infe-
lice restauro nel 1842 quando, come è noto, fu
staccato dalla parete sinistra del Duomo e traspor-
tato, su tela, dove ora si trova.
Sono quindi convinto che se fosse possibile
esaminare l'opera da vicino, al presente situata, in
posizione inarrivabile e mal illuminata, si avreb-
bero molte probabilità di scoprire facilmente i
grossolani e disastrosi rifacimenti posteriori. In
tal caso l'opera potrebbe addirittura rinascere an-
che da un elementare restauro che ne scoprisse
e ne rimettesse in vista anche i soli grandiosi con-
torni primitivi che il disegno ci fa troppo rimpian-
gere.
Matteo Marangoni.
1 Cfr. Vasari-Milanesi, t. II, p. 212, nota.