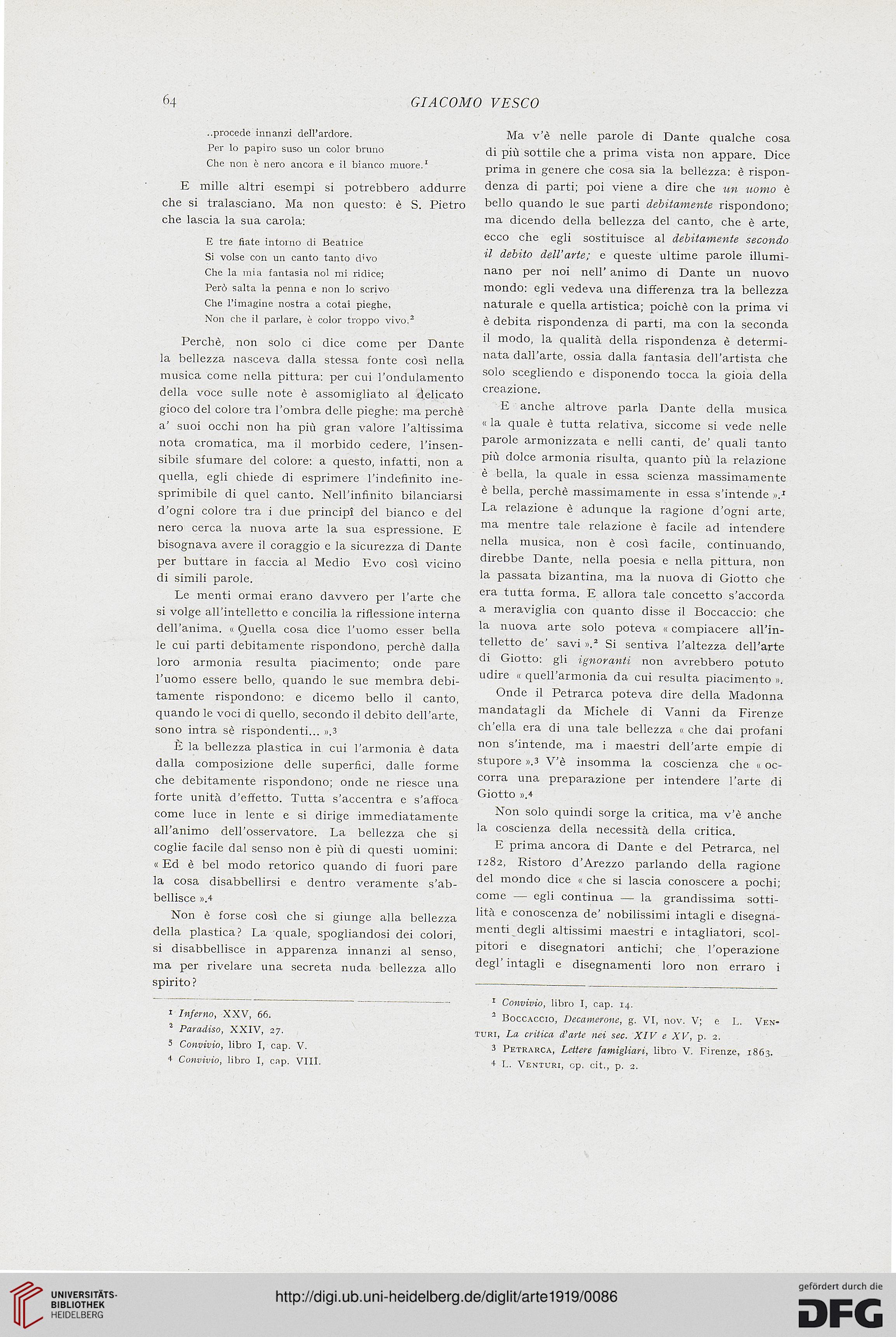64
GIACOMO VESCO
..procede innanzi dell'ardore.
Per lo papiro suso un color bruno
Che non è nero ancora e il bianco muore.'
E mille altri esempi si potrebbero addurre
che si tralasciano. Ma non questo: è S. Pietro
che lascia la sua carola:
E tre fiate intorno di Beatiice
Si volse con un canto tanto d'vo
Che la mia fantasia noi mi ridice;
Perù salta la penna e non lo scrivo
Che l'imagine nostra a cotai pieghe.
Non che il parlare, è color troppo vivo.2
Perchè, non solo ci dice come per Dante
la bellezza nasceva dalla stessa fonte così nella
musica come nella pittura: per cui l'ondulamento
della voce sulle note è assomigliato al delicato
gioco del colore tra l'ombra delle pieghe: ma perchè
a' suoi occhi non ha più gran valore l'altissima
nota cromatica, ma il morbido cedere, l'insen-
sibile sfumare del colore: a questo, infatti, non a
quella, egli chiede di esprimere l'indefinito ine-
sprimibile di quel canto. Nell'infinito bilanciarsi
d'ogni colore tra i due principi del bianco e del
nero cerca la nuova arte la sua espressione. E
bisognava avere il coraggio e la sicurezza di Dante
per buttare in faccia al Medio Evo così vicino
di simili parole.
Le menti ormai erano davvero per l'arte che
si volge all'intelletto e concilia la riflessione interna
dell'anima. « Quella cosa dice l'uomo esser bella
le cui parti debitamente rispondono, perchè dalla
loro armonia resulta piacimento; onde pare
l'uomo essere bello, quando le sue membra debi-
tamente rispondono: e diccmo bello il canto,
quando le voci di quello, secondo il debito dell'arte,
sono intra sè rispondenti... ».S
È la bellezza plastica in cui l'armonia è data
dalla composizione delle superfici, dalle forme
che debitamente rispondono; onde ne riesce una
forte unità d'effetto. Tutta s'accentra e s'affoca
come luce in lente e si dirige immediatamente
all'animo dell'osservatore. La bellezza che si
coglie facile dal senso non è più di questi uomini:
« Ed è bel modo retorico quando di fuori pare
la cosa disabbellirsi e dentro veramente s'ab-
bellisce )l.4
Non è forse così che si giunge alla bellezza
della plastica? La quale, spogliandosi dei colori,
si disabbellisce in apparenza innanzi al senso,
ma per rivelare una secreta nuda bellezza allo
spirito?
i Inferno, XXV, 66.
1 Paradiso, XXIV, 27.
5 Convivio, libro I, cap. V.
■t Convivio, libro I, cap. Vili.
Ma v'è nelle parole di Dante qualche cosa
di più sottile che a prima vista non appare. Dice
prima in genere che cosa sia la bellezza: è rispon-
denza di parti; poi viene a dire che un uomo è
bello quando le sue parti debitamente rispondono;
ma dicendo della bellezza del canto, che è arte,
ecco che egli sostituisce al debitamente secondo
il debito dell'arte; e queste ultime parole illumi-
nano per noi neh' animo di Dante un nuovo
mondo: egli vedeva una differenza tra la bellezza
naturale e quella artistica; poiché con la prima vi
è debita rispondenza di parti, ma con la seconda
il modo, la qualità della rispondenza è determi-
nata dall'arte, ossia dalla fantasia dell'artista che
solo scegliendo e disponendo tocca la gioia della
creazione.
E anche altrove parla Dante della musica
« la quale è tutta relativa, siccome si vede nelle
parole armonizzata e nelli canti, de' quali tanto
più dolce armonia risulta, quanto più la relazione
è bella, la quale in essa scienza massimamente
è bella, perchè massimamente in essa s'intende ».J
La relazione è adunque la ragione d'ogni arte,
ma mentre tale relazione è facile ad intendere
nella musica, non è così facile, continuando,
direbbe Dante, nella poesia e nella pittura, non
la passata bizantina, ma la nuova di Giotto che
era tutta forma. E allora tale concetto s'accorda
a meraviglia con quanto disse il Boccaccio: che
la nuova arte solo poteva « compiacere all'in-
telletto de' savi ».2 Si sentiva l'altezza dell'arte
di Giotto: gli ignoranti non avrebbero potuto
udire « quell'armonia da cui resulta piacimento ».
Onde il Petrarca poteva dire della Madonna
mandatagli da Michele di Vanni da Firenze
ch'ella era di una tale bellezza « che dai profani
non s'intende, ma i maestri dell'arte empie di
stupore ».3 V'è insomma la coscienza che « oc-
corra una preparazione per intendere l'arte di
Giotto ».4
Non solo quindi sorge la critica, ma v'è anche
la coscienza della necessità della critica.
E prima ancora di Dante e del Petrarca, nel
1282, Ristoro d'Arezzo parlando della ragione
del mondo dice « che si lascia conoscere a pochi;
come — egli continua — la grandissima sotti-
lità e conoscenza de' nobilissimi intagli e disegna-
mene degli altissimi maestri e intagliatori, scol-
pitori e disegnatori antichi; che l'operazione
dogi' intagli e disegnamenti loro non erraro i
1 Convivio, libro I, cap. 14.
1 Boccaccio, Decamcrone, g. VI, nov. V; e L. Ven-
turi, La critica d'arte nei sec. XIV e XV, p. 2.
3 Petrarca, Lettere famigliari, libro V. Firenze, 1863.
4 L. Venturi, cp. cit., p. 2.
GIACOMO VESCO
..procede innanzi dell'ardore.
Per lo papiro suso un color bruno
Che non è nero ancora e il bianco muore.'
E mille altri esempi si potrebbero addurre
che si tralasciano. Ma non questo: è S. Pietro
che lascia la sua carola:
E tre fiate intorno di Beatiice
Si volse con un canto tanto d'vo
Che la mia fantasia noi mi ridice;
Perù salta la penna e non lo scrivo
Che l'imagine nostra a cotai pieghe.
Non che il parlare, è color troppo vivo.2
Perchè, non solo ci dice come per Dante
la bellezza nasceva dalla stessa fonte così nella
musica come nella pittura: per cui l'ondulamento
della voce sulle note è assomigliato al delicato
gioco del colore tra l'ombra delle pieghe: ma perchè
a' suoi occhi non ha più gran valore l'altissima
nota cromatica, ma il morbido cedere, l'insen-
sibile sfumare del colore: a questo, infatti, non a
quella, egli chiede di esprimere l'indefinito ine-
sprimibile di quel canto. Nell'infinito bilanciarsi
d'ogni colore tra i due principi del bianco e del
nero cerca la nuova arte la sua espressione. E
bisognava avere il coraggio e la sicurezza di Dante
per buttare in faccia al Medio Evo così vicino
di simili parole.
Le menti ormai erano davvero per l'arte che
si volge all'intelletto e concilia la riflessione interna
dell'anima. « Quella cosa dice l'uomo esser bella
le cui parti debitamente rispondono, perchè dalla
loro armonia resulta piacimento; onde pare
l'uomo essere bello, quando le sue membra debi-
tamente rispondono: e diccmo bello il canto,
quando le voci di quello, secondo il debito dell'arte,
sono intra sè rispondenti... ».S
È la bellezza plastica in cui l'armonia è data
dalla composizione delle superfici, dalle forme
che debitamente rispondono; onde ne riesce una
forte unità d'effetto. Tutta s'accentra e s'affoca
come luce in lente e si dirige immediatamente
all'animo dell'osservatore. La bellezza che si
coglie facile dal senso non è più di questi uomini:
« Ed è bel modo retorico quando di fuori pare
la cosa disabbellirsi e dentro veramente s'ab-
bellisce )l.4
Non è forse così che si giunge alla bellezza
della plastica? La quale, spogliandosi dei colori,
si disabbellisce in apparenza innanzi al senso,
ma per rivelare una secreta nuda bellezza allo
spirito?
i Inferno, XXV, 66.
1 Paradiso, XXIV, 27.
5 Convivio, libro I, cap. V.
■t Convivio, libro I, cap. Vili.
Ma v'è nelle parole di Dante qualche cosa
di più sottile che a prima vista non appare. Dice
prima in genere che cosa sia la bellezza: è rispon-
denza di parti; poi viene a dire che un uomo è
bello quando le sue parti debitamente rispondono;
ma dicendo della bellezza del canto, che è arte,
ecco che egli sostituisce al debitamente secondo
il debito dell'arte; e queste ultime parole illumi-
nano per noi neh' animo di Dante un nuovo
mondo: egli vedeva una differenza tra la bellezza
naturale e quella artistica; poiché con la prima vi
è debita rispondenza di parti, ma con la seconda
il modo, la qualità della rispondenza è determi-
nata dall'arte, ossia dalla fantasia dell'artista che
solo scegliendo e disponendo tocca la gioia della
creazione.
E anche altrove parla Dante della musica
« la quale è tutta relativa, siccome si vede nelle
parole armonizzata e nelli canti, de' quali tanto
più dolce armonia risulta, quanto più la relazione
è bella, la quale in essa scienza massimamente
è bella, perchè massimamente in essa s'intende ».J
La relazione è adunque la ragione d'ogni arte,
ma mentre tale relazione è facile ad intendere
nella musica, non è così facile, continuando,
direbbe Dante, nella poesia e nella pittura, non
la passata bizantina, ma la nuova di Giotto che
era tutta forma. E allora tale concetto s'accorda
a meraviglia con quanto disse il Boccaccio: che
la nuova arte solo poteva « compiacere all'in-
telletto de' savi ».2 Si sentiva l'altezza dell'arte
di Giotto: gli ignoranti non avrebbero potuto
udire « quell'armonia da cui resulta piacimento ».
Onde il Petrarca poteva dire della Madonna
mandatagli da Michele di Vanni da Firenze
ch'ella era di una tale bellezza « che dai profani
non s'intende, ma i maestri dell'arte empie di
stupore ».3 V'è insomma la coscienza che « oc-
corra una preparazione per intendere l'arte di
Giotto ».4
Non solo quindi sorge la critica, ma v'è anche
la coscienza della necessità della critica.
E prima ancora di Dante e del Petrarca, nel
1282, Ristoro d'Arezzo parlando della ragione
del mondo dice « che si lascia conoscere a pochi;
come — egli continua — la grandissima sotti-
lità e conoscenza de' nobilissimi intagli e disegna-
mene degli altissimi maestri e intagliatori, scol-
pitori e disegnatori antichi; che l'operazione
dogi' intagli e disegnamenti loro non erraro i
1 Convivio, libro I, cap. 14.
1 Boccaccio, Decamcrone, g. VI, nov. V; e L. Ven-
turi, La critica d'arte nei sec. XIV e XV, p. 2.
3 Petrarca, Lettere famigliari, libro V. Firenze, 1863.
4 L. Venturi, cp. cit., p. 2.