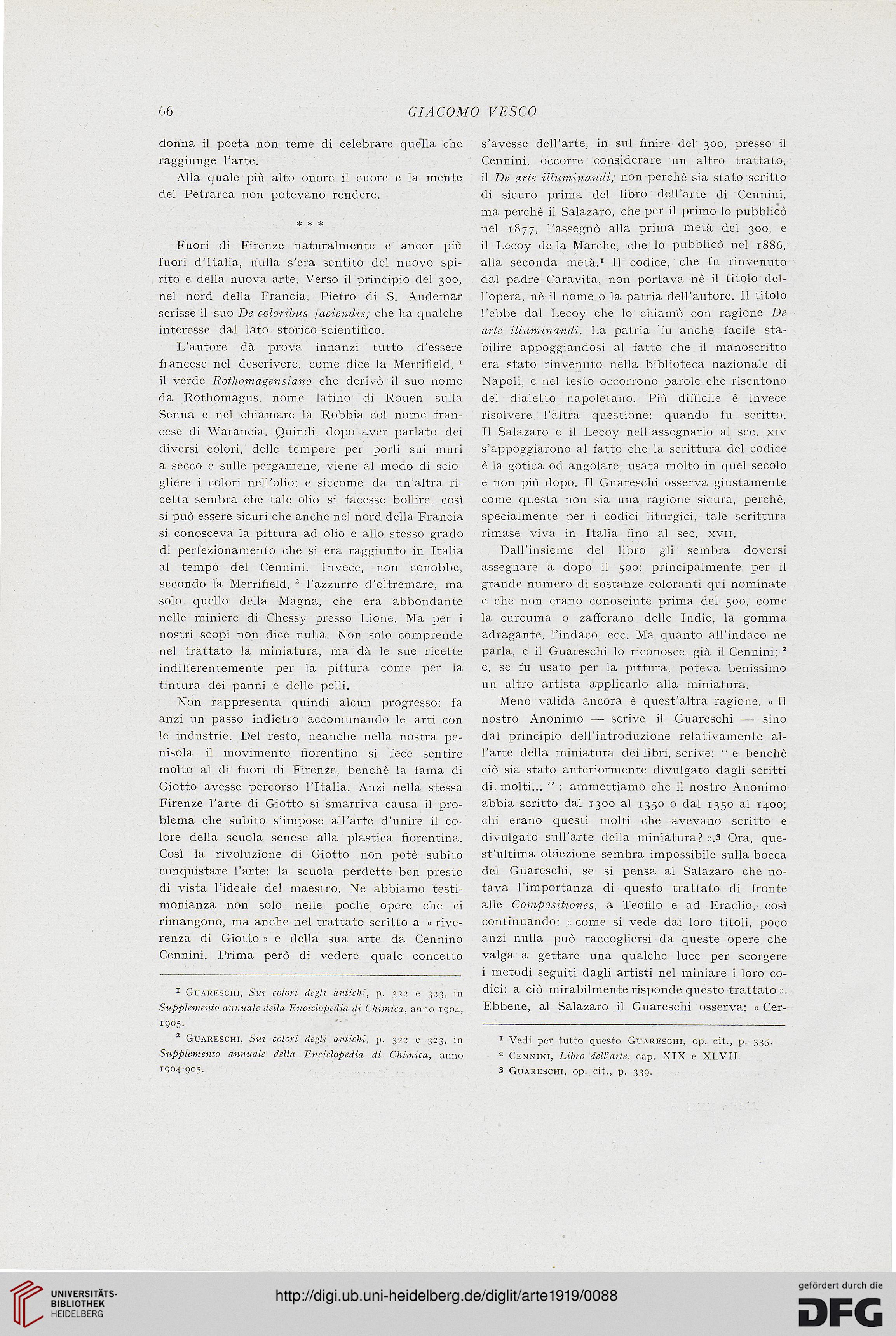66
GIACOMO VESCO
donna il poeta non teme di celebrare quella che
raggiunge l'arte.
Alla quale più alto onore il cuore c la mente
del Petrarca non potevano rendere.
* * *
Fuori di Firenze naturalmente e ancor più
fuori d'Italia, nulla s'era sentito del nuovo spi-
rito e della nuova arte. Verso il principio del 300,
nel nord della Francia, Pietro, di S. Audemar
scrisse il suo De coloribus faciendis; che ha qualche
interesse dal lato storico-scientifico.
L'autore dà prova innanzi tutto d'essere
fi ancese nel descrivere, come dice la Merrifield, 1
il verde Rothomagensia.no che derivò il suo nome
da Rothomagus, nome latino di koucn sulla
Senna e nel chiamare la Robbia col nome fran-
cese di Warancia. Quindi, dopo aver parlato elei
diversi colori, delle tempere pei porli sui muri
a secco e sulle pergamene, viene al modo di scio-
gliere i colori nell'olio; e siccome da un'altra ri-
cetta sembra che tale olio si facesse bollire, così
si può essere sicuri che anche nel nord della Francia
si conosceva la pittura ad olio e allo stesso grado
di perfezionamento che si era raggiunto in Italia
al tempo del Cennini. Invece, non conobbe,
secondo la Merrifield, 2 l'azzurro d'oltremare, ma
solo quello della Magna, che era abbondante
nelle miniere di Chessy presso Lione. Ma per i
nostri scopi non dice nulla. Non solo comprende
nel trattato la miniatura, ma dà le sue ricette
indifferentemente per la pittura come per la
tintura dei panni e delle pelli.
Non rappresenta quindi alcun progresso: fa
anzi un passo indietro accomunando le arti con
le industrie. Del resto, neanche nella nostra pe-
nisola il movimento fiorentino si fece sentire
molto al di fuori di Firenze, benché la fama di
Giotto avesse percorso l'Italia. Anzi nella stessa
Firenze l'arte di Giotto si smarriva causa il pro-
blema che subito s'impose all'arte d'unire il co-
lore della scuola senese alla plastica fiorentina.
Così la rivoluzione di Giotto non potè subito
conquistare l'arte: la scuola perdette ben presto
di vista l'ideale del maestro. Ne abbiamo testi-
monianza non solo nelle poche opere che ci
rimangono, ma anche nel trattato scritto a « rive-
renza di Giotto » e della sua arte da Cennino
Cennini. Prima però di vedere quale concetto
1 GuARKSCHi, Siti colori degli antichi, p. 32: 0 323, in
Supplemento annuale della Enciclopedia di Chimica, anno 1904,
1905.
2 Guareschi, Sui colori degli antichi, p. 322 e 323, in
Supplemento animale della Enciclopedia di Chimica, anno
1904-905.
s'avesse dell'arte, in sul finire del 300, presso il
Cennini, occorre considerare un altro trattato,
il De arte illuminandi; non perchè sia stato scritto
di sicuro prima del libro dell'arte di Cennini,
ma perchè il Salazaro, che per il primo lo pubblicò
nel 1877, l'assegnò alla prima metà del 300, e
il Lecoy de la Marche, che lo pubblicò nel 1886,
alla seconda metà.1 Il codice, che fu rinvenuto
dal padre Caravita, non portava nè il titolo del-
l'opera, nè il nome o la patria dell'autore. 11 titolo
l'ebbe dal Lecoy che lo chiamò con ragione De
arte illuminandi. La patria fu anche facile sta-
bilire appoggiandosi al fatto che il manoscritto
era stato rinvenuto nella biblioteca nazionale di
Napoli, e nel testo occorrono parole che risentono
del dialetto napoletano. Più difficile è invece
risolvere l'altra questione: quando fu scritto.
TI Salazaro e il Lecoy nell'assegnarlo al sec. xiv
s'appoggiarono al fatto che la scrittura del codice
è la gotica od angolare, usata molto in quel secolo
e non più dopo. 11 Guareschi osserva giustamente
come questa non sia una ragione sicura, perchè,
specialmente per i codici liturgici, tale scrittura
rimase viva in Italia fino al sec. XVH.
Dall'insieme del libro gli sembra doversi
assegnare a dopo il 500: principalmente per il
grande numero di sostanze coloranti qui nominate
e che non erano conosciute prima del 500, come
la curcuma o zafferano delle Tndie, la gomma
adragante, l'indaco, ecc. Ma quanto all'indaco ne
parla, e il Guareschi lo riconosce, già il Cennini; 2
e, se fu usato per la pittura, poteva benissimo
un altro artista applicarlo alla miniatura.
Meno valida ancora è quest'altra ragione. « Il
nostro Anonimo — scrive il Guareschi — sino
dal principio dell'introduzione relativamente al-
l'arte della miniatura dei libri, scrive: " e benché
ciò sia stato anteriormente divulgato dagli scritti
di. molti... " : ammettiamo che il nostro Anonimo
abbia scritto dal 1300 al 1350 o dal 1350 al 1400;
chi erano questi molti che avevano scritto e
divulgato sull'arte della miniatura? ».3 Ora, que-
st'ultima obiezione sembra impossibile sulla bocca
del Guareschi, se si pensa al Salazaro che no-
tava l'importanza di questo trattato di fronte
alle Compositiones, a Teofilo e ad Eraclio, così
continuando: « come si vede dai loro titoli, poco
anzi nulla può raccogliersi da queste opere che
valga a gettare una qualche luce per scorgere
i metodi seguiti dagli artisti nel miniare i loro co-
dici: a ciò mirabilmente risponde questo trattato».
Ebbene, al Salazaro il Guareschi osserva: « Cer-
1 Vedi per tutto questo Guareschi, op. olt., p. 335.
2 Cennini, Libro dell'arte, cap. XIX e XLVII.
3 Guareschi, op. rit., p. 339.
GIACOMO VESCO
donna il poeta non teme di celebrare quella che
raggiunge l'arte.
Alla quale più alto onore il cuore c la mente
del Petrarca non potevano rendere.
* * *
Fuori di Firenze naturalmente e ancor più
fuori d'Italia, nulla s'era sentito del nuovo spi-
rito e della nuova arte. Verso il principio del 300,
nel nord della Francia, Pietro, di S. Audemar
scrisse il suo De coloribus faciendis; che ha qualche
interesse dal lato storico-scientifico.
L'autore dà prova innanzi tutto d'essere
fi ancese nel descrivere, come dice la Merrifield, 1
il verde Rothomagensia.no che derivò il suo nome
da Rothomagus, nome latino di koucn sulla
Senna e nel chiamare la Robbia col nome fran-
cese di Warancia. Quindi, dopo aver parlato elei
diversi colori, delle tempere pei porli sui muri
a secco e sulle pergamene, viene al modo di scio-
gliere i colori nell'olio; e siccome da un'altra ri-
cetta sembra che tale olio si facesse bollire, così
si può essere sicuri che anche nel nord della Francia
si conosceva la pittura ad olio e allo stesso grado
di perfezionamento che si era raggiunto in Italia
al tempo del Cennini. Invece, non conobbe,
secondo la Merrifield, 2 l'azzurro d'oltremare, ma
solo quello della Magna, che era abbondante
nelle miniere di Chessy presso Lione. Ma per i
nostri scopi non dice nulla. Non solo comprende
nel trattato la miniatura, ma dà le sue ricette
indifferentemente per la pittura come per la
tintura dei panni e delle pelli.
Non rappresenta quindi alcun progresso: fa
anzi un passo indietro accomunando le arti con
le industrie. Del resto, neanche nella nostra pe-
nisola il movimento fiorentino si fece sentire
molto al di fuori di Firenze, benché la fama di
Giotto avesse percorso l'Italia. Anzi nella stessa
Firenze l'arte di Giotto si smarriva causa il pro-
blema che subito s'impose all'arte d'unire il co-
lore della scuola senese alla plastica fiorentina.
Così la rivoluzione di Giotto non potè subito
conquistare l'arte: la scuola perdette ben presto
di vista l'ideale del maestro. Ne abbiamo testi-
monianza non solo nelle poche opere che ci
rimangono, ma anche nel trattato scritto a « rive-
renza di Giotto » e della sua arte da Cennino
Cennini. Prima però di vedere quale concetto
1 GuARKSCHi, Siti colori degli antichi, p. 32: 0 323, in
Supplemento annuale della Enciclopedia di Chimica, anno 1904,
1905.
2 Guareschi, Sui colori degli antichi, p. 322 e 323, in
Supplemento animale della Enciclopedia di Chimica, anno
1904-905.
s'avesse dell'arte, in sul finire del 300, presso il
Cennini, occorre considerare un altro trattato,
il De arte illuminandi; non perchè sia stato scritto
di sicuro prima del libro dell'arte di Cennini,
ma perchè il Salazaro, che per il primo lo pubblicò
nel 1877, l'assegnò alla prima metà del 300, e
il Lecoy de la Marche, che lo pubblicò nel 1886,
alla seconda metà.1 Il codice, che fu rinvenuto
dal padre Caravita, non portava nè il titolo del-
l'opera, nè il nome o la patria dell'autore. 11 titolo
l'ebbe dal Lecoy che lo chiamò con ragione De
arte illuminandi. La patria fu anche facile sta-
bilire appoggiandosi al fatto che il manoscritto
era stato rinvenuto nella biblioteca nazionale di
Napoli, e nel testo occorrono parole che risentono
del dialetto napoletano. Più difficile è invece
risolvere l'altra questione: quando fu scritto.
TI Salazaro e il Lecoy nell'assegnarlo al sec. xiv
s'appoggiarono al fatto che la scrittura del codice
è la gotica od angolare, usata molto in quel secolo
e non più dopo. 11 Guareschi osserva giustamente
come questa non sia una ragione sicura, perchè,
specialmente per i codici liturgici, tale scrittura
rimase viva in Italia fino al sec. XVH.
Dall'insieme del libro gli sembra doversi
assegnare a dopo il 500: principalmente per il
grande numero di sostanze coloranti qui nominate
e che non erano conosciute prima del 500, come
la curcuma o zafferano delle Tndie, la gomma
adragante, l'indaco, ecc. Ma quanto all'indaco ne
parla, e il Guareschi lo riconosce, già il Cennini; 2
e, se fu usato per la pittura, poteva benissimo
un altro artista applicarlo alla miniatura.
Meno valida ancora è quest'altra ragione. « Il
nostro Anonimo — scrive il Guareschi — sino
dal principio dell'introduzione relativamente al-
l'arte della miniatura dei libri, scrive: " e benché
ciò sia stato anteriormente divulgato dagli scritti
di. molti... " : ammettiamo che il nostro Anonimo
abbia scritto dal 1300 al 1350 o dal 1350 al 1400;
chi erano questi molti che avevano scritto e
divulgato sull'arte della miniatura? ».3 Ora, que-
st'ultima obiezione sembra impossibile sulla bocca
del Guareschi, se si pensa al Salazaro che no-
tava l'importanza di questo trattato di fronte
alle Compositiones, a Teofilo e ad Eraclio, così
continuando: « come si vede dai loro titoli, poco
anzi nulla può raccogliersi da queste opere che
valga a gettare una qualche luce per scorgere
i metodi seguiti dagli artisti nel miniare i loro co-
dici: a ciò mirabilmente risponde questo trattato».
Ebbene, al Salazaro il Guareschi osserva: « Cer-
1 Vedi per tutto questo Guareschi, op. olt., p. 335.
2 Cennini, Libro dell'arte, cap. XIX e XLVII.
3 Guareschi, op. rit., p. 339.