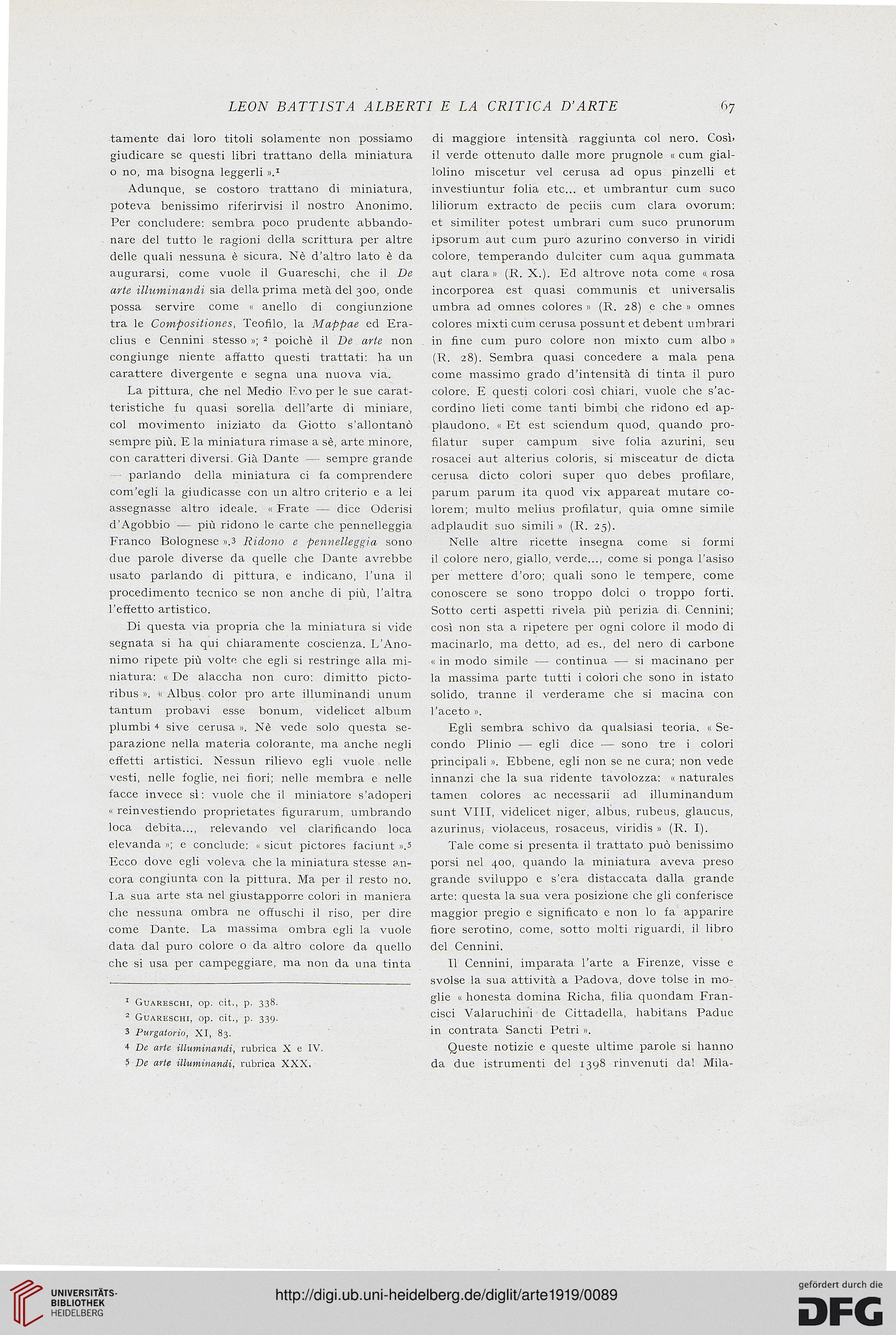LEON BATTISTA ALBERTI E LA CRITICA D'ARTE
67
tamentc dai loro titoli solamente non possiamo
giudicare se questi libri trattano della miniatura
o no, ma bisogna leggerli ».r
Adunque, se costoro trattano di miniatura,
poteva benissimo riferirvisi il nostro Anonimo.
Per concludere: sembra poco prudente abbando-
nare del tutto le ragioni della scrittura per altre
delle quali nessuna è sicura. Nè d'altro lato è da
augurarsi, come vuole il Guareschi, che il De
arte illuntinandi sia della prima metà del 300, onde
possa servire come « anello di congiunzione
tra le Compositiones, Teofilo, la Mappae ed Era-
clius e Cennini stesso »; 2 poiché il De arte non
congiunge niente affatto questi trattati: ha un
carattere divergente e segna una nuova via.
La pittura, che nel Medio Evo per le sue carat-
teristiche fu quasi sorella dell'arte di miniare,
col movimento iniziato da Giotto s'allontanò
sempre più. E la miniatura rimase a sè, arte minore,
con caratteri diversi. Già Dante — sempre grande
parlando della miniatura ci {a comprendere
com'egli la giudicasse con un altro criterio e a lei
assegnasse altro ideale. « Frate — dice Oderisi
d'Agobbio — più ridono le carte che pennelleggia.
Franco Bolognese ».3 Rìdono e pennelleggia sono
due parole diverse da quelle che Dante avrebbe
usato parlando di pittura, e indicano, l'una il
procedimento tecnico se non anche di più, l'altra
l'effetto artistico.
Di questa via propria che la miniatura si vide
segnata si ha qui chiaramente coscienza. L'Ano-
nimo ripete più volte che egli si restringe alla mi-
niatura: « De alaccha non curo: dimitto picto-
ribus ». « Albus. color prò arte illuminandi unum
tantum probavi esse bonum, videlicet album
piumbi + sive cerusa ». Nè vede solo questa se-
parazione nella materia colorante, ma anche negli
effetti artistici. Nessun rilievo egli vuole nelle
vesti, nelle foglie, nei fiori; nelle membra e nelle
facce invece si: vuole che il miniatore s'adoperi
« reinvestiendo proprietates fìgurarum, timbrando
loca debita..., relevando vel clarificando loca
elevanda »; e conclude: « sicut pictores faciunt O
Ecco dove egli voleva che la miniatura stesse an-
cora congiunta con la pittura. Ma per il resto no.
La sua arte sta nel giustapporre colori in maniera
che nessuna ombra ne offuschi il riso, per dire
come Dante. La massima ombra egli la vuole
data dal puro colore o da altro colore da quello
che si usa per campeggiare, ma non da una tinta
1 Guareschi, op. cit., p. 338.
2 Guareschi, op. cit., p. 339.
3 Purgatorio, XI, 83.
4 De arte illuminandi, rubrica X e IV.
5 De arte illuminandi, rubrica XXX.
di maggiore intensità raggiunta col nero. Così,
il verde ottenuto dalle more prugnole « cum gial-
lolino miscetur vel cerusa ad opus pinzelli et
investiuntur folia etc... et umbrantur cum suco
liliorum extracto de peciis cum clara ovorum:
et similiter potest umbrari cum suco prunorum
ipsorum aut cum puro azurino converso in viridi
colore, temperando dulciter cum aqua gummata
aut clara» (R. X.). Ed altrove nota come «rosa
incorporea est quasi communis et universalis
umbra ad omnes colores » (R. 28) e che » omnes
colores mixti cum cerusa possunt et debent umbrari
in fine cum puro colore non mixto cum albo »
(R. 28). Sembra quasi concedere a mala pena
come massimo grado d'intensità di tinta il puro
colore. E questi colori così chiari, vuole che s'ac-
cordino lieti come tanti bimbi che ridono ed ap-
plaudono. « Et est sciendum quod, quando pro-
filatili' super campum sive folia azurini, seu
rosacei aut alterius coloris, si misceatur de dieta
cerusa dicto colori super quo debes profilare,
parum parum ita quod vix appareat mutare co-
lorem; multo melius profilatur, quia orline simile
adplaudit suo simili » (R. 25).
Nelle altre ricette insegna come si formi
il colore nero, giallo, verde..., come si ponga l'asiso
per mettere d'oro; quali sono le tempere, come
conoscere se sono troppo dolci o troppo forti.
Sotto certi aspetti rivela più perizia di Cennini;
così non sta a ripetere per ogni colore il modo di
macinarlo, ma detto, ad es., del nero di carbone
« in modo simile — continua — si macinano per
la massima parte tutti i colori che sono in istato
solido, tranne il verderame che si macina con
l'aceto ».
Egli sembra schivo da qualsiasi teoria. « Se-
condo Plinio — egli dice — sono tre i colori
principali ». Ebbene, egli non se ne cura; non vede
innanzi che la sua ridente tavolozza: « naturales
tamen colores ac necessarii ad illuminandum
sunt Vili, videlicet niger, albus, rubeus, glaucus,
azurinus, violaceus, rosaceus, viridis » (R. I).
Tale come si presenta il trattato può benissimo
porsi nel 400, quando la miniatura aveva preso
grande sviluppo c s'era distaccata dalla grande
arte: questa la sua vera posizione che gli conferisce
maggior pregio e significato e non lo fa apparire
fiore serotino, come, sotto molti riguardi, il libro
del Cennini.
Il Cennini, imparata l'arte a Firenze, visse e
svolse la sua attività a Padova, dove tolse in mo-
glie 0 honcsta domina Richa, lilia quondam Fran-
cisci Valaruchini de Cittadella, habitans Paduc
in contrata Sancti Petri ».
Queste notìzie e queste ultime parole si hanno
da due istrumenti del 1398 rinvenuti dal Mila-
67
tamentc dai loro titoli solamente non possiamo
giudicare se questi libri trattano della miniatura
o no, ma bisogna leggerli ».r
Adunque, se costoro trattano di miniatura,
poteva benissimo riferirvisi il nostro Anonimo.
Per concludere: sembra poco prudente abbando-
nare del tutto le ragioni della scrittura per altre
delle quali nessuna è sicura. Nè d'altro lato è da
augurarsi, come vuole il Guareschi, che il De
arte illuntinandi sia della prima metà del 300, onde
possa servire come « anello di congiunzione
tra le Compositiones, Teofilo, la Mappae ed Era-
clius e Cennini stesso »; 2 poiché il De arte non
congiunge niente affatto questi trattati: ha un
carattere divergente e segna una nuova via.
La pittura, che nel Medio Evo per le sue carat-
teristiche fu quasi sorella dell'arte di miniare,
col movimento iniziato da Giotto s'allontanò
sempre più. E la miniatura rimase a sè, arte minore,
con caratteri diversi. Già Dante — sempre grande
parlando della miniatura ci {a comprendere
com'egli la giudicasse con un altro criterio e a lei
assegnasse altro ideale. « Frate — dice Oderisi
d'Agobbio — più ridono le carte che pennelleggia.
Franco Bolognese ».3 Rìdono e pennelleggia sono
due parole diverse da quelle che Dante avrebbe
usato parlando di pittura, e indicano, l'una il
procedimento tecnico se non anche di più, l'altra
l'effetto artistico.
Di questa via propria che la miniatura si vide
segnata si ha qui chiaramente coscienza. L'Ano-
nimo ripete più volte che egli si restringe alla mi-
niatura: « De alaccha non curo: dimitto picto-
ribus ». « Albus. color prò arte illuminandi unum
tantum probavi esse bonum, videlicet album
piumbi + sive cerusa ». Nè vede solo questa se-
parazione nella materia colorante, ma anche negli
effetti artistici. Nessun rilievo egli vuole nelle
vesti, nelle foglie, nei fiori; nelle membra e nelle
facce invece si: vuole che il miniatore s'adoperi
« reinvestiendo proprietates fìgurarum, timbrando
loca debita..., relevando vel clarificando loca
elevanda »; e conclude: « sicut pictores faciunt O
Ecco dove egli voleva che la miniatura stesse an-
cora congiunta con la pittura. Ma per il resto no.
La sua arte sta nel giustapporre colori in maniera
che nessuna ombra ne offuschi il riso, per dire
come Dante. La massima ombra egli la vuole
data dal puro colore o da altro colore da quello
che si usa per campeggiare, ma non da una tinta
1 Guareschi, op. cit., p. 338.
2 Guareschi, op. cit., p. 339.
3 Purgatorio, XI, 83.
4 De arte illuminandi, rubrica X e IV.
5 De arte illuminandi, rubrica XXX.
di maggiore intensità raggiunta col nero. Così,
il verde ottenuto dalle more prugnole « cum gial-
lolino miscetur vel cerusa ad opus pinzelli et
investiuntur folia etc... et umbrantur cum suco
liliorum extracto de peciis cum clara ovorum:
et similiter potest umbrari cum suco prunorum
ipsorum aut cum puro azurino converso in viridi
colore, temperando dulciter cum aqua gummata
aut clara» (R. X.). Ed altrove nota come «rosa
incorporea est quasi communis et universalis
umbra ad omnes colores » (R. 28) e che » omnes
colores mixti cum cerusa possunt et debent umbrari
in fine cum puro colore non mixto cum albo »
(R. 28). Sembra quasi concedere a mala pena
come massimo grado d'intensità di tinta il puro
colore. E questi colori così chiari, vuole che s'ac-
cordino lieti come tanti bimbi che ridono ed ap-
plaudono. « Et est sciendum quod, quando pro-
filatili' super campum sive folia azurini, seu
rosacei aut alterius coloris, si misceatur de dieta
cerusa dicto colori super quo debes profilare,
parum parum ita quod vix appareat mutare co-
lorem; multo melius profilatur, quia orline simile
adplaudit suo simili » (R. 25).
Nelle altre ricette insegna come si formi
il colore nero, giallo, verde..., come si ponga l'asiso
per mettere d'oro; quali sono le tempere, come
conoscere se sono troppo dolci o troppo forti.
Sotto certi aspetti rivela più perizia di Cennini;
così non sta a ripetere per ogni colore il modo di
macinarlo, ma detto, ad es., del nero di carbone
« in modo simile — continua — si macinano per
la massima parte tutti i colori che sono in istato
solido, tranne il verderame che si macina con
l'aceto ».
Egli sembra schivo da qualsiasi teoria. « Se-
condo Plinio — egli dice — sono tre i colori
principali ». Ebbene, egli non se ne cura; non vede
innanzi che la sua ridente tavolozza: « naturales
tamen colores ac necessarii ad illuminandum
sunt Vili, videlicet niger, albus, rubeus, glaucus,
azurinus, violaceus, rosaceus, viridis » (R. I).
Tale come si presenta il trattato può benissimo
porsi nel 400, quando la miniatura aveva preso
grande sviluppo c s'era distaccata dalla grande
arte: questa la sua vera posizione che gli conferisce
maggior pregio e significato e non lo fa apparire
fiore serotino, come, sotto molti riguardi, il libro
del Cennini.
Il Cennini, imparata l'arte a Firenze, visse e
svolse la sua attività a Padova, dove tolse in mo-
glie 0 honcsta domina Richa, lilia quondam Fran-
cisci Valaruchini de Cittadella, habitans Paduc
in contrata Sancti Petri ».
Queste notìzie e queste ultime parole si hanno
da due istrumenti del 1398 rinvenuti dal Mila-