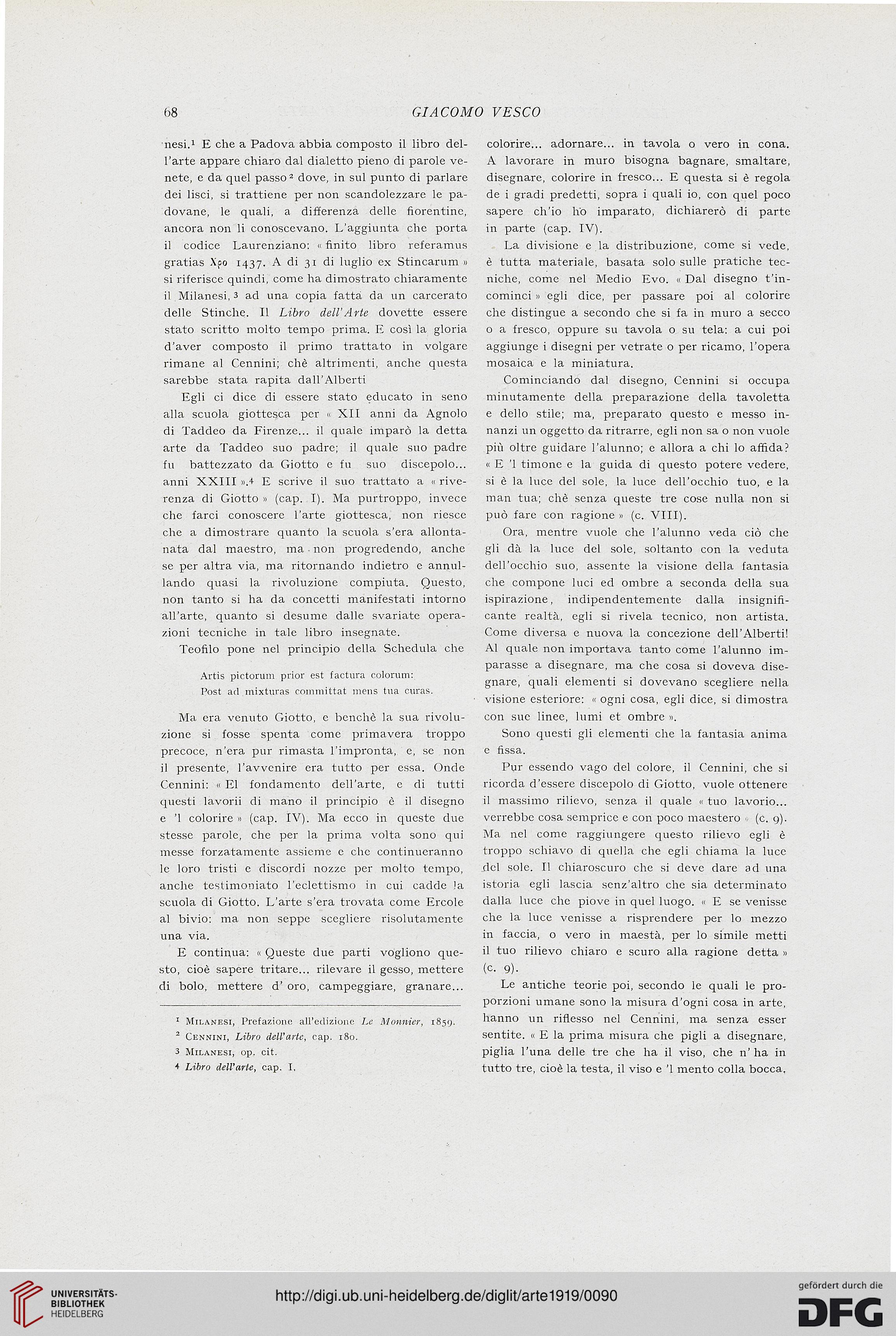68
GIACOMO VE SCO
nesi.1 E che a Padova abbia composto il libro del-
l'arte appare chiaro dal dialetto pieno di parole ve-
nete, e da quel passo2 dove, in sul punto di parlare
dei lisci, si trattiene per non scandolezzare le pa-
dovane, le quali, a differenza delle fiorentine,
ancora non li conoscevano. L'aggiunta che porta
il codice Laurcnziano: « finito libro referamus
gratias Xpo 1437. A di 31 di luglio ex Stincarum »
si riferisce quindi, come ha dimostrato chiaramente
il. Milanesi, 3 ad una copia fatta da un carcerato
delle Stinche. Il Libro dell'Arte dovette essere
stato scritto molto tempo prima. E così la gloria
d'aver composto il primo trattato in volgare
rimane al Cennini; chè altrimenti, anche questa
sarebbe stata rapita dall'Alberti
Egli ci dice di essere stato educato in seno
alla scuola giottesca per « XII anni da Agnolo
di Taddeo da Firenze... il quale imparò la detta
arte da Taddeo suo padre; il quale suo padre
fu battezzato da Giotto e fu suo discepolo...
anni XXIII ».♦ E scrive il suo trattato a « rive-
renza di Giotto » (cap. I). Ma purtroppo, invece
che farci conoscere l'arte giottesca, non riesce
che a dimostrare quanto la scuola s'era allonta-
nata da] maestro, ma non progredendo, anche
se per altra via, ma ritornando indietro e annul-
lando quasi la rivoluzione compiuta. Questo,
non tanto si ha da concetti manifestati intorno
all'arte, quanto si desume dalle svariate opera-
zioni tecniche in tale libro insegnate.
Teofìlo pone nel principio della Schedula che
Artis pictorum prior est factura colorum:.
Post art mixturas committat mens tua curas.
Ma era venuto Giotto, e benché la sua rivolu-
zione si fosse spenta come primavera troppo
precoce, n'era pur rimasta l'impronta, e, se non
il presente, l'avvenire era tutto per essa. Onde
Cennini: « El fondamento dell'arte, e di tutti
questi lavorìi di mano il principio è il disegno
e '1 colorire » (cap. IV). Ma ecco in queste due
stesse parole, che per la prima volta sono qui
messe forzatamente assieme e che continueranno
le loro tristi e discordi nozze per molto tempo,
anche testimoniato l'eclettismo in cui cadde la
scuola di Giotto. L'arte s'era trovata come Ercole
al bivio: ma non seppe scegliere risolutamente
una via.
E continua: « Queste due parti vogliono que-
sto, cioè sapere tritare... rilevare il gesso, mettere
di bolo, mettere d' oro, campeggiare, granare...
1 Milanesi, Prefazione all'edizione Le Mounier, 1859.
2 Cennini, Libro dell'arte, cap. 180.
3 Milanesi, op. cit.
4 Libro dell'arte, cap. T.
colorire... adornare... in tavola o vero in cona.
A lavorare in muro bisogna bagnare, smaltare,
disegnare, colorire in fresco... E questa si è regola
de i gradi predetti, sopra i quali io, con quel poco
sapere ch'io ho imparato, dichiarerò di parte
in parte (cap. IV).
La divisione e la distribuzione, come si vede,
è tutta materiale, basata solo sulle pratiche tec-
niche, come nel Medio Evo. « Dal disegno t'in-
cominci » egli dice, per passare poi al colorire
che distingue a secondo che si fa in muro a secco
o a fresco, oppure su tavola o su tela: a cui poi
aggiunge i disegni per vetrate o per ricamo, l'opera
mosaica e la miniatura.
Cominciando dal disegno, Cennini si occupa
minutamente della preparazione della tavoletta
e dello stile; ma, preparato questo e messo in-
nanzi un oggetto da ritrarre, egli non sa o non vuole
più oltre guidare l'alunno; e allora a chi lo affida?
« E '1 timone e la guida di questo potere vedere,
si è la luce del sole, la luce dell'occhio tuo, e la
man tua; chè senza queste tre cose nulla non si
può fare con ragione » (e. Vili).
Ora, mentre vuole che l'alunno veda ciò che
gli dà la luce del sole, soltanto con la veduta
dell'occhio suo, assente la visione della fantasia
che compone luci ed ombre a seconda della sua
ispirazione, indipendentemente dalla insignifi-
cante realtà, egli si rivela tecnico, non artista.
Come diversa e nuova la concezione dell'Alberti!
Al quale non importava tanto come l'alunno im-
parasse a disegnare, ma che cosa si doveva dise-
gnare, quali elementi si dovevano scegliere nella
visione esteriore: « ogni cosa, egli dice, si dimostra
con sue linee, lumi et ombre ».
Sono questi gli elementi che la fantasia anima
e fìssa.
Pur essendo vago del colore, il Cennini, che si
ricorda d'essere discepolo di Giotto, vuole ottenere
il massimo rilievo, senza il quale « tuo lavorio...
verrebbe cosa semprice e con poco maestero (c. g).
Ma nel come raggiungere questo rilievo egli è
troppo schiavo di quella che egli chiama la luce
del sole. Il chiaroscuro che si deve dare ad una
istoria egli lascia senz'altro che sia determinato
dalla luce che piove in quel luogo. « E se venisse
che la luce venisse a risprendere per lo mezzo
in faccia, o vero in maestà, per lo simile metti
il tuo rilievo chiaro e scuro alla ragione detta »
(c. 9).
Le antiche teorie poi, secondo le quali le pro-
porzioni umane sono la misura d'ogni cosa in arte,
hanno un riflesso nel Cennini, ma senza esser
sentite. « E la prima misura che pigli a disegnare,
piglia l'una delle tre che ha il viso, che n' ha in
tutto tre, cioè la testa, il viso e '1 mento colla bocca,
GIACOMO VE SCO
nesi.1 E che a Padova abbia composto il libro del-
l'arte appare chiaro dal dialetto pieno di parole ve-
nete, e da quel passo2 dove, in sul punto di parlare
dei lisci, si trattiene per non scandolezzare le pa-
dovane, le quali, a differenza delle fiorentine,
ancora non li conoscevano. L'aggiunta che porta
il codice Laurcnziano: « finito libro referamus
gratias Xpo 1437. A di 31 di luglio ex Stincarum »
si riferisce quindi, come ha dimostrato chiaramente
il. Milanesi, 3 ad una copia fatta da un carcerato
delle Stinche. Il Libro dell'Arte dovette essere
stato scritto molto tempo prima. E così la gloria
d'aver composto il primo trattato in volgare
rimane al Cennini; chè altrimenti, anche questa
sarebbe stata rapita dall'Alberti
Egli ci dice di essere stato educato in seno
alla scuola giottesca per « XII anni da Agnolo
di Taddeo da Firenze... il quale imparò la detta
arte da Taddeo suo padre; il quale suo padre
fu battezzato da Giotto e fu suo discepolo...
anni XXIII ».♦ E scrive il suo trattato a « rive-
renza di Giotto » (cap. I). Ma purtroppo, invece
che farci conoscere l'arte giottesca, non riesce
che a dimostrare quanto la scuola s'era allonta-
nata da] maestro, ma non progredendo, anche
se per altra via, ma ritornando indietro e annul-
lando quasi la rivoluzione compiuta. Questo,
non tanto si ha da concetti manifestati intorno
all'arte, quanto si desume dalle svariate opera-
zioni tecniche in tale libro insegnate.
Teofìlo pone nel principio della Schedula che
Artis pictorum prior est factura colorum:.
Post art mixturas committat mens tua curas.
Ma era venuto Giotto, e benché la sua rivolu-
zione si fosse spenta come primavera troppo
precoce, n'era pur rimasta l'impronta, e, se non
il presente, l'avvenire era tutto per essa. Onde
Cennini: « El fondamento dell'arte, e di tutti
questi lavorìi di mano il principio è il disegno
e '1 colorire » (cap. IV). Ma ecco in queste due
stesse parole, che per la prima volta sono qui
messe forzatamente assieme e che continueranno
le loro tristi e discordi nozze per molto tempo,
anche testimoniato l'eclettismo in cui cadde la
scuola di Giotto. L'arte s'era trovata come Ercole
al bivio: ma non seppe scegliere risolutamente
una via.
E continua: « Queste due parti vogliono que-
sto, cioè sapere tritare... rilevare il gesso, mettere
di bolo, mettere d' oro, campeggiare, granare...
1 Milanesi, Prefazione all'edizione Le Mounier, 1859.
2 Cennini, Libro dell'arte, cap. 180.
3 Milanesi, op. cit.
4 Libro dell'arte, cap. T.
colorire... adornare... in tavola o vero in cona.
A lavorare in muro bisogna bagnare, smaltare,
disegnare, colorire in fresco... E questa si è regola
de i gradi predetti, sopra i quali io, con quel poco
sapere ch'io ho imparato, dichiarerò di parte
in parte (cap. IV).
La divisione e la distribuzione, come si vede,
è tutta materiale, basata solo sulle pratiche tec-
niche, come nel Medio Evo. « Dal disegno t'in-
cominci » egli dice, per passare poi al colorire
che distingue a secondo che si fa in muro a secco
o a fresco, oppure su tavola o su tela: a cui poi
aggiunge i disegni per vetrate o per ricamo, l'opera
mosaica e la miniatura.
Cominciando dal disegno, Cennini si occupa
minutamente della preparazione della tavoletta
e dello stile; ma, preparato questo e messo in-
nanzi un oggetto da ritrarre, egli non sa o non vuole
più oltre guidare l'alunno; e allora a chi lo affida?
« E '1 timone e la guida di questo potere vedere,
si è la luce del sole, la luce dell'occhio tuo, e la
man tua; chè senza queste tre cose nulla non si
può fare con ragione » (e. Vili).
Ora, mentre vuole che l'alunno veda ciò che
gli dà la luce del sole, soltanto con la veduta
dell'occhio suo, assente la visione della fantasia
che compone luci ed ombre a seconda della sua
ispirazione, indipendentemente dalla insignifi-
cante realtà, egli si rivela tecnico, non artista.
Come diversa e nuova la concezione dell'Alberti!
Al quale non importava tanto come l'alunno im-
parasse a disegnare, ma che cosa si doveva dise-
gnare, quali elementi si dovevano scegliere nella
visione esteriore: « ogni cosa, egli dice, si dimostra
con sue linee, lumi et ombre ».
Sono questi gli elementi che la fantasia anima
e fìssa.
Pur essendo vago del colore, il Cennini, che si
ricorda d'essere discepolo di Giotto, vuole ottenere
il massimo rilievo, senza il quale « tuo lavorio...
verrebbe cosa semprice e con poco maestero (c. g).
Ma nel come raggiungere questo rilievo egli è
troppo schiavo di quella che egli chiama la luce
del sole. Il chiaroscuro che si deve dare ad una
istoria egli lascia senz'altro che sia determinato
dalla luce che piove in quel luogo. « E se venisse
che la luce venisse a risprendere per lo mezzo
in faccia, o vero in maestà, per lo simile metti
il tuo rilievo chiaro e scuro alla ragione detta »
(c. 9).
Le antiche teorie poi, secondo le quali le pro-
porzioni umane sono la misura d'ogni cosa in arte,
hanno un riflesso nel Cennini, ma senza esser
sentite. « E la prima misura che pigli a disegnare,
piglia l'una delle tre che ha il viso, che n' ha in
tutto tre, cioè la testa, il viso e '1 mento colla bocca,