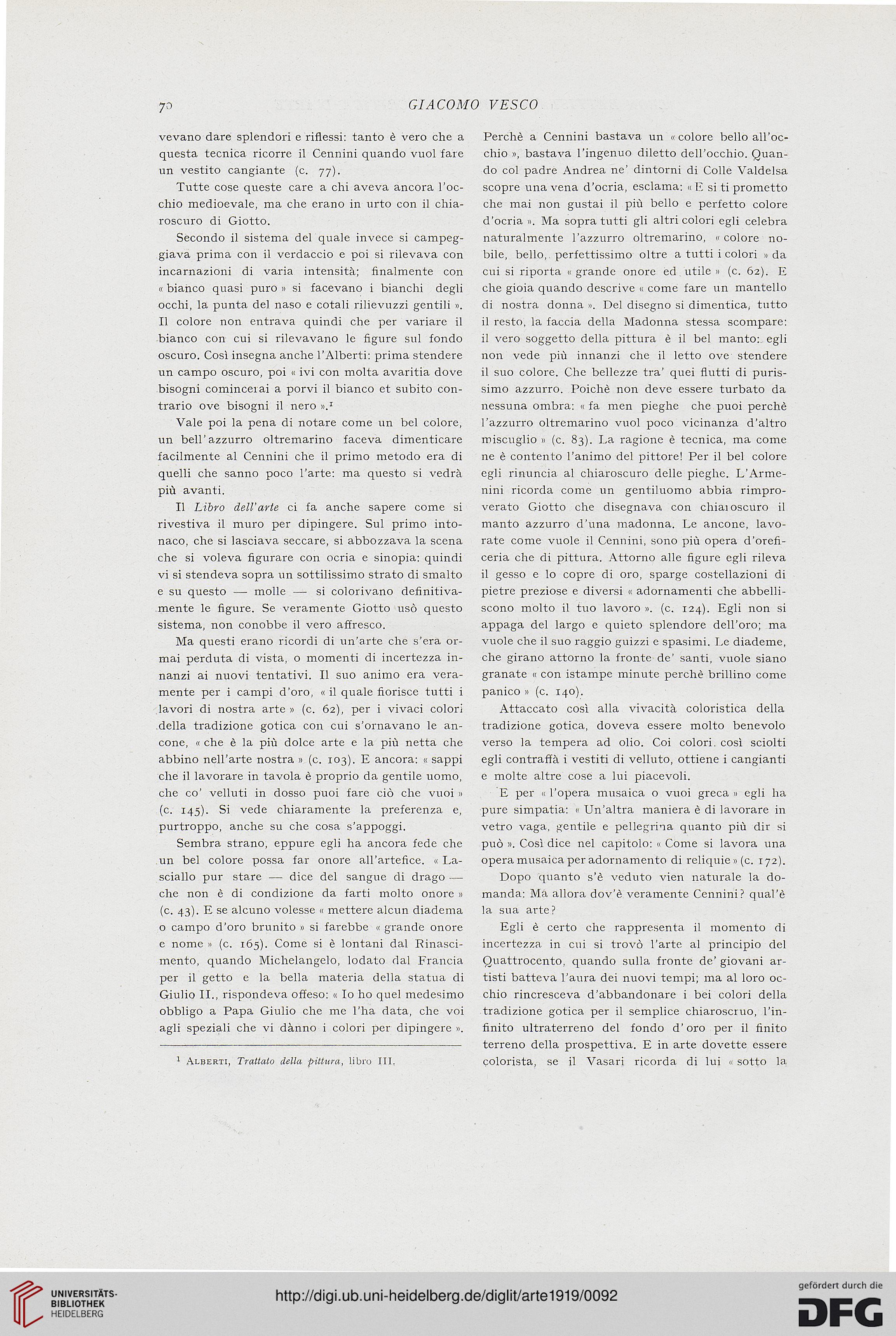GIACOMO VESCO
7*
vevano dare splendori e riflessi: tanto è vero che a
questa tecnica ricorre il Cennini quando vuol fare
un vestito cangiante (c. 77).
Tutte cose queste care a chi aveva ancora l'oc-
chio medioevale, ma che erano in urto con il chia-
roscuro di Giotto.
Secondo il sistema del quale invece si campeg-
giava prima con il verdaccio e poi si rilevava con
incarnazioni di varia intensità; finalmente con
« bianco quasi puro » si facevano i bianchi degli
occhi, la punta del naso c cotali rilievuzzi gentili ».
Il colore non entrava quindi che per variare il
bianco con cui si rilevavano le figure sul fondo
oscuro. Così insegna anche l'Alberti: prima stendere
un campo oscuro, poi « ivi con molta avaritia dove
bisogni comincerai a porvi il bianco et subito con-
trario ove bisogni il nero ».*
Vale poi la pena di notare come un bel colore,
un bell'azzurro oltremarino faceva dimenticare
facilmente al Cennini che il primo metodo era di
quelli che sanno poco l'arte: ma questo si vedrà
più avanti.
Il Libro dell'arte ci fa anche sapere come si
rivestiva il muro per dipingere. Sul primo into-
naco, che si lasciava seccare, si abbozzava la scena
che si voleva figurare con ocria e sinopia: quindi
vi si stendeva sopra un sottilissimo strato di smalto
e su questo — molle — si colorivano definitiva-
mente le figure. Se veramente Giotto usò questo
sistema, non conobbe il vero affresco.
Ma questi erano ricordi di un'arte che s'era or-
mai perduta di vista, o momenti di incertezza in-
nanzi ai nuovi tentativi. Il suo animo era vera-
mente per i campi d'oro, « il quale fiorisce tutti i
lavori di nostra arte » (c. 62), per i vivaci colori
della tradizione gotica con cui s'ornavano le an-
cone, « che è la più dolce arte e la più netta che
abbino nell'arte nostra » (c. 103). E ancora: « sappi
che il lavorare in tavola è proprio da gentile uomo,
che co' velluti in dosso puoi fare ciò che vuoi »
(c. 145). Si vede chiaramente la preferenza e,
purtroppo, anche su che cosa s'appoggi.
Sembra strano, eppure egli ha ancora fede che
un bel colore possa far onore all'artefice. « La-
sciano pur stare — dice del sangue di drago —
che non è di condizione da farti molto onore »
(c. 43). E se alcuno volesse « mettere alcun diadema
o campo d'oro brunito » si farebbe « grande onore
e nome » (c. 165). Come si è lontani dal Rinasci-
mento, quando Michelangelo, lodato dal Francia
per il getto e la bella materia della statua di
Giulio II., rispondeva offeso: « Io ho quel medesimo
obbligo a Papa Giulio che me l'ha data, che voi
agli speziali che vi danno i colori per dipingere ».
1 Alberti, Trattato della pittura, libro III,
Perchè a Cennini bastava un « colore bello all'oc-
chio », bastava l'ingenuo diletto dell'occhio. Quan-
do col padre Andrea ne' dintorni di Colle Valdelsa
scopre una vena d'ocria, esclama: « E si ti prometto
che mai non gustai il più bello e perfetto colore
d'ocria ». Ma sopra tutti gli altri colori egli celebra
naturalmente l'azzurro oltremarino, « colore no-
bile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori » da
cui si riporta « grande onore ed utile » (c. 62). E
che gioia quando descrive « come fare un mantello
di nostra donna ». Del disegno si dimentica, tutto
il resto, la faccia della Madonna stessa scompare:
il vero soggetto della pittura è il bel manto: egli
non vede più innanzi che il letto ove stendere
il suo colore. Che bellezze tra' quei flutti di puris-
simo azzurro. Poiché non deve essere turbato da
nessuna ombra: « fa men pieghe che puoi perchè
l'azzurro oltremarino vuol poco vicinanza d'altro
miscuglio » (c. 83). La ragione è tecnica, ma come
ne è contento l'animo del pittore! Per il bel colore
egli rinuncia al chiaroscuro delle pieghe. L'Arme-
nini ricorda come un gentiluomo abbia rimpro-
verato Giotto che disegnava con chiai oscuro il
manto azzurro d'una madonna. Le ancone, lavo-
rate come vuole il Cennini, sono più opera d'orefi-
ceria che di pittura. Attorno alle figure egli rileva
il gesso e lo copre di oro, sparge costellazioni di
pietre preziose e diversi « adornamenti che abbelli-
scono molto il tuo lavoro ». (c. 124). Egli non si
appaga del largo e quieto splendore dell'oro; ma
vuole che il suo raggio guizzi e spasimi. Ce diademe,
che girano attorno la fronte de' santi, vuole siano
granate « con istampe minute perchè brillino come
panico » (c. 140).
Attaccato così alla vivacità coloristica della
tradizione gotica, doveva essere molto benevolo
verso la tempera ad olio. Coi colori, così sciolti
egli contraffà i vestiti di velluto, ottiene i cangianti
e molte altre cose a lui piacevoli.
E per « l'opera musaica o vuoi greca » egli ha
pure simpatia: « Un'altra maniera è di lavorare in
vetro vaga, gentile e pellegrina quanto più dir si
può ». Così dice nel capitolo: « Come si lavora una
opera musaica per adornamento di reliquie» (c. 172).
Dopo quanto s'è veduto vien naturale la do-
manda: Mà allora dov'è veramente Cennini? qual'è
la sua arte?
Egli è certo che rappresenta il momento di
incertezza in cui si trovò l'arte al principio del
Quattrocento, quando sulla fronte de' giovani ar-
tisti batteva l'aura dei nuovi tempi; ma al loro oc-
chio rincresceva d'abbandonare i bei colori della
tradizione gotica per il semplice chiaroscruo, l'in-
finito ultraterreno del fondo d'oro per il finito
terreno della prospettiva. E in arte dovette essere
colorista, se il Vasari ricorda di lui « sotto la
7*
vevano dare splendori e riflessi: tanto è vero che a
questa tecnica ricorre il Cennini quando vuol fare
un vestito cangiante (c. 77).
Tutte cose queste care a chi aveva ancora l'oc-
chio medioevale, ma che erano in urto con il chia-
roscuro di Giotto.
Secondo il sistema del quale invece si campeg-
giava prima con il verdaccio e poi si rilevava con
incarnazioni di varia intensità; finalmente con
« bianco quasi puro » si facevano i bianchi degli
occhi, la punta del naso c cotali rilievuzzi gentili ».
Il colore non entrava quindi che per variare il
bianco con cui si rilevavano le figure sul fondo
oscuro. Così insegna anche l'Alberti: prima stendere
un campo oscuro, poi « ivi con molta avaritia dove
bisogni comincerai a porvi il bianco et subito con-
trario ove bisogni il nero ».*
Vale poi la pena di notare come un bel colore,
un bell'azzurro oltremarino faceva dimenticare
facilmente al Cennini che il primo metodo era di
quelli che sanno poco l'arte: ma questo si vedrà
più avanti.
Il Libro dell'arte ci fa anche sapere come si
rivestiva il muro per dipingere. Sul primo into-
naco, che si lasciava seccare, si abbozzava la scena
che si voleva figurare con ocria e sinopia: quindi
vi si stendeva sopra un sottilissimo strato di smalto
e su questo — molle — si colorivano definitiva-
mente le figure. Se veramente Giotto usò questo
sistema, non conobbe il vero affresco.
Ma questi erano ricordi di un'arte che s'era or-
mai perduta di vista, o momenti di incertezza in-
nanzi ai nuovi tentativi. Il suo animo era vera-
mente per i campi d'oro, « il quale fiorisce tutti i
lavori di nostra arte » (c. 62), per i vivaci colori
della tradizione gotica con cui s'ornavano le an-
cone, « che è la più dolce arte e la più netta che
abbino nell'arte nostra » (c. 103). E ancora: « sappi
che il lavorare in tavola è proprio da gentile uomo,
che co' velluti in dosso puoi fare ciò che vuoi »
(c. 145). Si vede chiaramente la preferenza e,
purtroppo, anche su che cosa s'appoggi.
Sembra strano, eppure egli ha ancora fede che
un bel colore possa far onore all'artefice. « La-
sciano pur stare — dice del sangue di drago —
che non è di condizione da farti molto onore »
(c. 43). E se alcuno volesse « mettere alcun diadema
o campo d'oro brunito » si farebbe « grande onore
e nome » (c. 165). Come si è lontani dal Rinasci-
mento, quando Michelangelo, lodato dal Francia
per il getto e la bella materia della statua di
Giulio II., rispondeva offeso: « Io ho quel medesimo
obbligo a Papa Giulio che me l'ha data, che voi
agli speziali che vi danno i colori per dipingere ».
1 Alberti, Trattato della pittura, libro III,
Perchè a Cennini bastava un « colore bello all'oc-
chio », bastava l'ingenuo diletto dell'occhio. Quan-
do col padre Andrea ne' dintorni di Colle Valdelsa
scopre una vena d'ocria, esclama: « E si ti prometto
che mai non gustai il più bello e perfetto colore
d'ocria ». Ma sopra tutti gli altri colori egli celebra
naturalmente l'azzurro oltremarino, « colore no-
bile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori » da
cui si riporta « grande onore ed utile » (c. 62). E
che gioia quando descrive « come fare un mantello
di nostra donna ». Del disegno si dimentica, tutto
il resto, la faccia della Madonna stessa scompare:
il vero soggetto della pittura è il bel manto: egli
non vede più innanzi che il letto ove stendere
il suo colore. Che bellezze tra' quei flutti di puris-
simo azzurro. Poiché non deve essere turbato da
nessuna ombra: « fa men pieghe che puoi perchè
l'azzurro oltremarino vuol poco vicinanza d'altro
miscuglio » (c. 83). La ragione è tecnica, ma come
ne è contento l'animo del pittore! Per il bel colore
egli rinuncia al chiaroscuro delle pieghe. L'Arme-
nini ricorda come un gentiluomo abbia rimpro-
verato Giotto che disegnava con chiai oscuro il
manto azzurro d'una madonna. Le ancone, lavo-
rate come vuole il Cennini, sono più opera d'orefi-
ceria che di pittura. Attorno alle figure egli rileva
il gesso e lo copre di oro, sparge costellazioni di
pietre preziose e diversi « adornamenti che abbelli-
scono molto il tuo lavoro ». (c. 124). Egli non si
appaga del largo e quieto splendore dell'oro; ma
vuole che il suo raggio guizzi e spasimi. Ce diademe,
che girano attorno la fronte de' santi, vuole siano
granate « con istampe minute perchè brillino come
panico » (c. 140).
Attaccato così alla vivacità coloristica della
tradizione gotica, doveva essere molto benevolo
verso la tempera ad olio. Coi colori, così sciolti
egli contraffà i vestiti di velluto, ottiene i cangianti
e molte altre cose a lui piacevoli.
E per « l'opera musaica o vuoi greca » egli ha
pure simpatia: « Un'altra maniera è di lavorare in
vetro vaga, gentile e pellegrina quanto più dir si
può ». Così dice nel capitolo: « Come si lavora una
opera musaica per adornamento di reliquie» (c. 172).
Dopo quanto s'è veduto vien naturale la do-
manda: Mà allora dov'è veramente Cennini? qual'è
la sua arte?
Egli è certo che rappresenta il momento di
incertezza in cui si trovò l'arte al principio del
Quattrocento, quando sulla fronte de' giovani ar-
tisti batteva l'aura dei nuovi tempi; ma al loro oc-
chio rincresceva d'abbandonare i bei colori della
tradizione gotica per il semplice chiaroscruo, l'in-
finito ultraterreno del fondo d'oro per il finito
terreno della prospettiva. E in arte dovette essere
colorista, se il Vasari ricorda di lui « sotto la