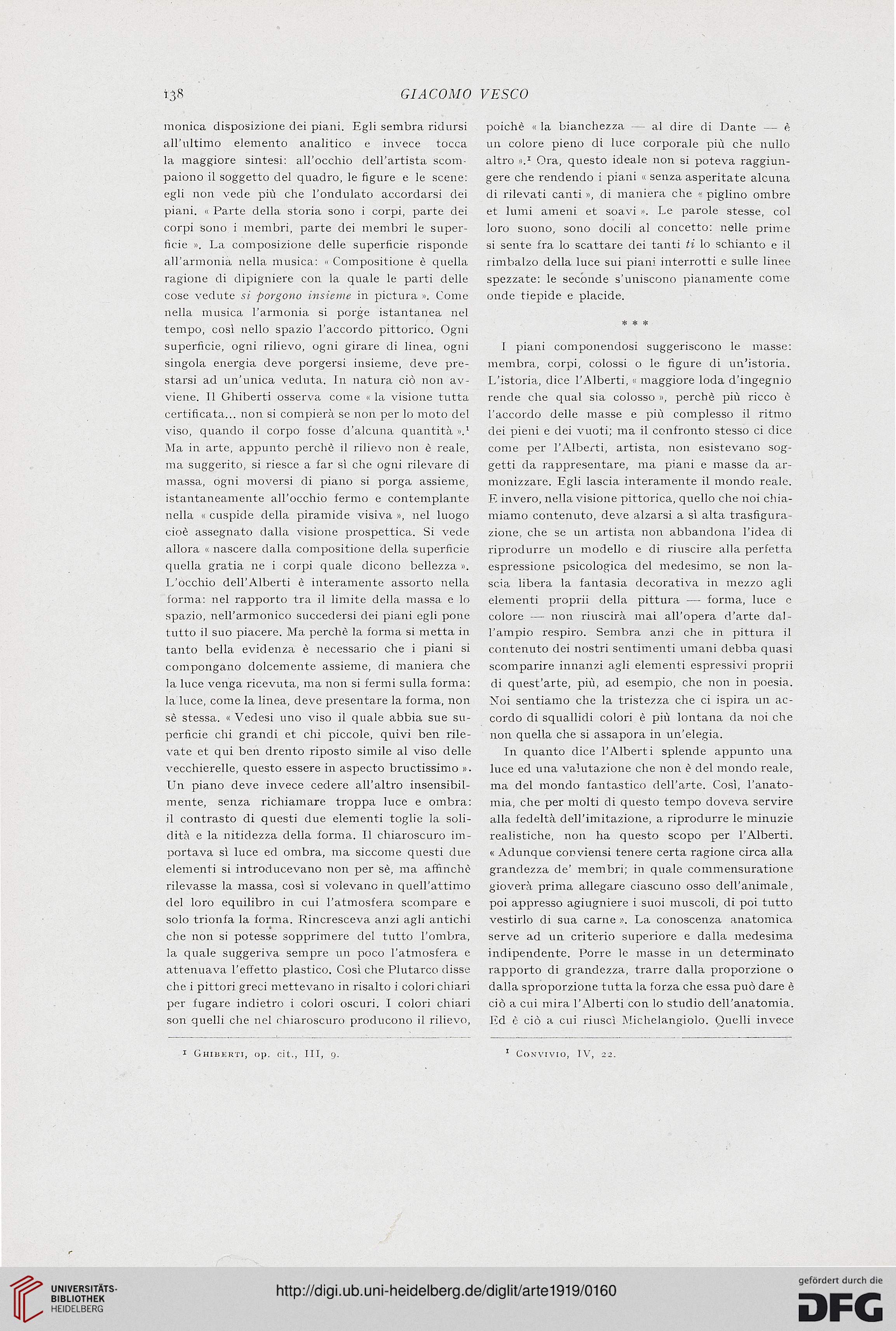GIACOMO VE SCO
monìca disposizione dei piani. Kgli sembra ridursi
all'ultimo elemento analitico e invece tocca
la maggiore sintesi: all'occhio dell'artista scom-
paiono il soggetto del quadro, le figure e le scene:
egli non vede più che l'ondulato accordarsi dei
piani. « Parte della storia sono i corpi, parte dei
corpi sono i membri, parte dei membri le super-
ficie ». La composizione delle superficie risponde
all'armonia nella musica: •< Compositione è quella,
ragione di dipigniere con la quale le parti delle
cose vedute si porgono insieme in pictura ». Come
nella musica l'armonia si porge istantanea nel
tempo, così nello spazio l'accordo pittorico. Ogni
superficie, ogni rilievo, ogni girare di linea, ogni
singola energia deve porgersi insieme, deve pre-
starsi ad un'unica veduta. In natura ciò non av-
viene. Il Ghiberti osserva come « la visione tutta
certificata... non si compierà se non per lo moto del
viso, quando il corpo fosse d'alcuna quantità ».'
Ma in arte, appunto perchè il rilievo non è reale,
ma suggerito, si riesce a far si che ogni rilevare di
massa, ogni moversi di piano si porga assieme,
istantaneamente all'occhio fermo e contemplante
nella « cuspide della piramide visiva », nel luogo
cioè assegnato dalla visione prospettica. Si vede
allora «nascere dalla compositione della superficie
quella gratia ne i corpi quale dicono bellezza ».
L'occhio dell'Alberti è interamente assorto nella
forma: nel rapporto tra il limite della massa e lo
spazio, nell'armonico succedersi dei piani egli pone
tutto il suo piacere. Ma perchè la forma si metta in
tanto bella evidenza è necessario che i piani si
compongano dolcemente assieme, di maniera che
la luce venga ricevuta, ma non si fermi sulla forma:
la luce, come la linea, deve presentare la forma, non
sè stessa. « Vedesi uno viso il quale abbia sue su-
perficie chi grandi et chi piccole, quivi ben rile-
vate et qui ben drento riposto simile al viso delle
vecchierelle, questo essere in aspecto bructissimo ».
Un piano deve invece cedere all'altro insensibil-
mente, senza richiamare troppa luce e ombra:
il contrasto di questi due elementi toglie la soli-
dità e la nitidezza della forma. 11 chiaroscuro im-
portava si luce ed ombra, ma siccome questi due
elementi si introducevano non per sè, ma affinchè
rilevasse la massa, così si volevano in quell'attimo
del loro equilibro in cui l'atmosfera scompare e
solo trionfa la forma. Rincresceva anzi agli antichi
che non si potesse sopprimere del tutto l'ombra,
la quale suggeriva sempre un poco l'atmosfera e
attenuava l'effetto plastico, (.'osi che Plutarco disse
che i pittori greci mettevano in risalto i colori chiari
per fugare indietro i colori oscuri. I colori chiari
son quelli che nel chiaroscuro producono il rilievo,
1 Ghiberti, op. cit., III, 9.
poiché « la bianchezza — al dire di Dante — è
un colore pieno di luce corporale più che nullo
altro i.1 Ora, questo ideale non si poteva raggiun-
gere che rendendo i piani « senza asperitate alcuna
di rilevati canti », di maniera che « piglino ombre
et lumi ameni et soavi ». Le parole stesse, col
loro suono, sono docili al concetto: nelle prime
si sente fra lo scattare dei tanti ti lo schianto e il
rimbalzo della luce sui piani interrotti e sulle linee
spezzate: le seconde s'uniscono pianamente come
onde tiepide e placide.
* * *
1 piani componendosi suggeriscono le masse:
membra, corpi, colossi o le figure di un'istoria.
L'istoria, dice l'Alberti, « maggiore loda d'ingegnio
rende che qual sia colosso », perchè più ricco è
l'accordo delle masse e più complesso il ritmo
dei pieni e dei vuoti; ma il confronto stesso ci dice
come per l'Alberti, artista, non esistevano sog-
getti da rappresentare, ma piani e masse da ar-
monizzare. Egli lascia interamente il mondo reale.
E invero, nella visione pittorica, quello che noi chia-
miamo contenuto, deve alzarsi a sì alta trasfigura-
zione, che se un artista non abbandona l'idea di
riprodurre un modello e di riuscire alla perfetta
espressione psicologica del medesimo, se non la-
scia libera la fantasia decorativa in mezzo agli
elementi proprii della pittura — forma, luce e
colore — non riuscirà mai all'opera d'arte dal-
l'ampio respiro. Sembra anzi che in pittura il
contenuto dei nostri sentimenti umani debba quasi
scomparire innanzi agli elementi espressivi proprii
di quest'arte, più, ad esempio, che non in poesia.
Noi sentiamo che la tristezza che ci ispira un ac-
cordo di squallidi colori è più lontana da noi che
non quella che si assapora in un'elegia.
In quanto dice l'Alberti splende appunto una
luce ed una valutazione che non è del mondo reale,
ma del mondo fantastico dell'arte. Cosi, l'anato-
mia, che per molti di questo tempo doveva servire
alla fedeltà dell'imitazione, a riprodurre le minuzie
realistiche, non ha questo scopo per l'Alberti.
« Adunque conviensi tenere certa ragione circa alla
grandezza de' membri; in quale commensuratione
gioverà prima allegare ciascuno osso dell'animale,
poi appresso agiugniere i suoi muscoli, di poi tutto
vestirlo di sua carne ». La conoscenza anatomica
serve ad un criterio superiore e dalla medesima
indipendente. Porre le masse in un detcrminato
rapporto di grandezza, trarre dalla proporzione o
dalla sproporzione tutta la forza che essa può dare è
ciò a cui mira l'Alberti con lo studio dell'anatomia.
Ed è ciò a cui riuscì Michelangiolo. Quelli invece
1 Convivio, IV, 22.
monìca disposizione dei piani. Kgli sembra ridursi
all'ultimo elemento analitico e invece tocca
la maggiore sintesi: all'occhio dell'artista scom-
paiono il soggetto del quadro, le figure e le scene:
egli non vede più che l'ondulato accordarsi dei
piani. « Parte della storia sono i corpi, parte dei
corpi sono i membri, parte dei membri le super-
ficie ». La composizione delle superficie risponde
all'armonia nella musica: •< Compositione è quella,
ragione di dipigniere con la quale le parti delle
cose vedute si porgono insieme in pictura ». Come
nella musica l'armonia si porge istantanea nel
tempo, così nello spazio l'accordo pittorico. Ogni
superficie, ogni rilievo, ogni girare di linea, ogni
singola energia deve porgersi insieme, deve pre-
starsi ad un'unica veduta. In natura ciò non av-
viene. Il Ghiberti osserva come « la visione tutta
certificata... non si compierà se non per lo moto del
viso, quando il corpo fosse d'alcuna quantità ».'
Ma in arte, appunto perchè il rilievo non è reale,
ma suggerito, si riesce a far si che ogni rilevare di
massa, ogni moversi di piano si porga assieme,
istantaneamente all'occhio fermo e contemplante
nella « cuspide della piramide visiva », nel luogo
cioè assegnato dalla visione prospettica. Si vede
allora «nascere dalla compositione della superficie
quella gratia ne i corpi quale dicono bellezza ».
L'occhio dell'Alberti è interamente assorto nella
forma: nel rapporto tra il limite della massa e lo
spazio, nell'armonico succedersi dei piani egli pone
tutto il suo piacere. Ma perchè la forma si metta in
tanto bella evidenza è necessario che i piani si
compongano dolcemente assieme, di maniera che
la luce venga ricevuta, ma non si fermi sulla forma:
la luce, come la linea, deve presentare la forma, non
sè stessa. « Vedesi uno viso il quale abbia sue su-
perficie chi grandi et chi piccole, quivi ben rile-
vate et qui ben drento riposto simile al viso delle
vecchierelle, questo essere in aspecto bructissimo ».
Un piano deve invece cedere all'altro insensibil-
mente, senza richiamare troppa luce e ombra:
il contrasto di questi due elementi toglie la soli-
dità e la nitidezza della forma. 11 chiaroscuro im-
portava si luce ed ombra, ma siccome questi due
elementi si introducevano non per sè, ma affinchè
rilevasse la massa, così si volevano in quell'attimo
del loro equilibro in cui l'atmosfera scompare e
solo trionfa la forma. Rincresceva anzi agli antichi
che non si potesse sopprimere del tutto l'ombra,
la quale suggeriva sempre un poco l'atmosfera e
attenuava l'effetto plastico, (.'osi che Plutarco disse
che i pittori greci mettevano in risalto i colori chiari
per fugare indietro i colori oscuri. I colori chiari
son quelli che nel chiaroscuro producono il rilievo,
1 Ghiberti, op. cit., III, 9.
poiché « la bianchezza — al dire di Dante — è
un colore pieno di luce corporale più che nullo
altro i.1 Ora, questo ideale non si poteva raggiun-
gere che rendendo i piani « senza asperitate alcuna
di rilevati canti », di maniera che « piglino ombre
et lumi ameni et soavi ». Le parole stesse, col
loro suono, sono docili al concetto: nelle prime
si sente fra lo scattare dei tanti ti lo schianto e il
rimbalzo della luce sui piani interrotti e sulle linee
spezzate: le seconde s'uniscono pianamente come
onde tiepide e placide.
* * *
1 piani componendosi suggeriscono le masse:
membra, corpi, colossi o le figure di un'istoria.
L'istoria, dice l'Alberti, « maggiore loda d'ingegnio
rende che qual sia colosso », perchè più ricco è
l'accordo delle masse e più complesso il ritmo
dei pieni e dei vuoti; ma il confronto stesso ci dice
come per l'Alberti, artista, non esistevano sog-
getti da rappresentare, ma piani e masse da ar-
monizzare. Egli lascia interamente il mondo reale.
E invero, nella visione pittorica, quello che noi chia-
miamo contenuto, deve alzarsi a sì alta trasfigura-
zione, che se un artista non abbandona l'idea di
riprodurre un modello e di riuscire alla perfetta
espressione psicologica del medesimo, se non la-
scia libera la fantasia decorativa in mezzo agli
elementi proprii della pittura — forma, luce e
colore — non riuscirà mai all'opera d'arte dal-
l'ampio respiro. Sembra anzi che in pittura il
contenuto dei nostri sentimenti umani debba quasi
scomparire innanzi agli elementi espressivi proprii
di quest'arte, più, ad esempio, che non in poesia.
Noi sentiamo che la tristezza che ci ispira un ac-
cordo di squallidi colori è più lontana da noi che
non quella che si assapora in un'elegia.
In quanto dice l'Alberti splende appunto una
luce ed una valutazione che non è del mondo reale,
ma del mondo fantastico dell'arte. Cosi, l'anato-
mia, che per molti di questo tempo doveva servire
alla fedeltà dell'imitazione, a riprodurre le minuzie
realistiche, non ha questo scopo per l'Alberti.
« Adunque conviensi tenere certa ragione circa alla
grandezza de' membri; in quale commensuratione
gioverà prima allegare ciascuno osso dell'animale,
poi appresso agiugniere i suoi muscoli, di poi tutto
vestirlo di sua carne ». La conoscenza anatomica
serve ad un criterio superiore e dalla medesima
indipendente. Porre le masse in un detcrminato
rapporto di grandezza, trarre dalla proporzione o
dalla sproporzione tutta la forza che essa può dare è
ciò a cui mira l'Alberti con lo studio dell'anatomia.
Ed è ciò a cui riuscì Michelangiolo. Quelli invece
1 Convivio, IV, 22.