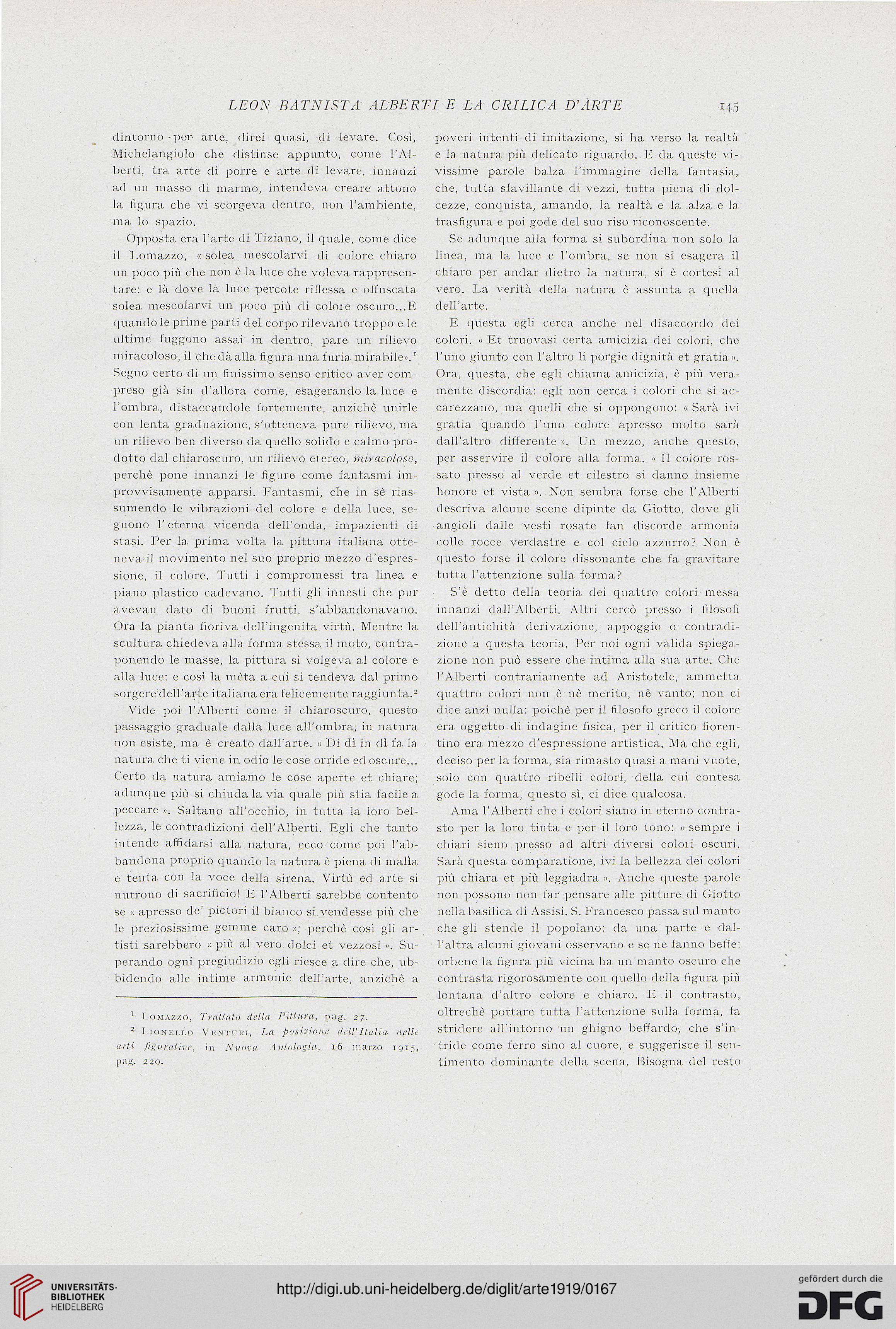LEON BATNISTA ALBERTI E LA CRILICA D'ARTE
1.45
dintorno - per arte, direi quasi, di levare. Cosi,
Michelangiolo che distinse appunto, come l'Al-
berti, tra arte di porre e arte di levare, innanzi
ad un masso di marmo, intendeva creare attono
la figura clic vi scorgeva dentro, non l'ambiente,
■ma lo spazio.
Opposta era l'arte di Tiziano, il quale, come dice
il Eomazzo, « solea mescolarvi di colore chiaro
un poco più che non è la luce che voleva rappresen-
tare: e là dove la luce percote riflessa e offuscata
solea mescolarvi un poco più di coloie oscuro...E
quando le prime parti del corpo rilevano troppo e le
ultime fuggono assai in dentro, pare un rilievo
miracoloso, il che dà alla figura una furia mirabile».1
Segno certo di un finissimo senso critico aver com-
preso già sin d'allora come, esagerando la luce e
l'ombra, distaccandole fortemente, anziché unirle
con lenta graduazione, s'otteneva pure rilievo, ma
un rilievo ben diverso da quello solido e calmo pro-
dotto dal chiaroscuro, un rilievo etereo, miracoloso,
perchè pone innanzi le figure come fantasmi im-
provvisamente apparsi. Fantasmi, che in sè rias-
sumendo le vibrazioni del colore e della luce, se-
guono l'eterna vicenda dell'onda, impazienti di
stasi. Per la prima volta la pittura italiana otte-
neva il movimento nel suo proprio mezzo d'espres-
sione, il colore. Tutti i compromessi tra linea e
piano plastico cadevano. Tutti gli innesti che pur
avevan dato di buoni frutti, s'abbandonavano.
Ora la pianta fioriva dell'ingenita virtù. Mentre la
scultura chiedeva alla forma stessa il moto, contra-
poncndo le masse, la pittura si volgeva al colore e
alla luce: e così la mèta a cui si tendeva dal primo
sorgere 'dell'arte italiana era felicemente raggiunta.2
Vide poi l'Alberti come il chiaroscuro, questo
passaggio graduale dalla luce all'ombra, in natura
non esiste, ma è creato dall'arte. « Di dì in di fa la
natura che ti viene in odio le cose orride ed oscure...
Certo da natura amiamo le cose aperte et chiare;
adunque più si chiuda la via quale più stia facile a
peccare ». Saltano all'occhio, in tutta la loro bel-
lezza, le contradizioni dell'Alberti. Egli che tanto
intende affidarsi alla natura, ecco come poi l'ab-
bandona proprio quando la natura è piena di malìa
e tenta con la voce della sirena. Virtù ed arte si
nutrono di sacrificio! E l'Alberti sarebbe contento
se « apresso de' pictori il bianco si vendesse più che
le preziosissime gemme caro »; perchè così gli ar-
tisti sarebbero « più al vero, dolci et vezzosi ». Su-
perando ogni pregiudizio egli riesce a dire che, ub-
bidendo alle intime armonie dell'arte, anziché a
1 Lomazzo, Trattato della Pittura, pag. 27.
2 Lionello Venturi, La posizione dell'Italia nelle
arti figurative, in Nuova Antologia, 16 marzo 1915,
pag. 220.
poveri intenti di imitazione, si ha verso la realtà
e la natura più delicato riguardo. E da queste vi-
vissime parole balza l'immagine della fantasia,
che, tutta sfavillante di vezzi, tutta piena di dol-
cezze, conquista, amando, la realtà e la alza e la
trasfigura e poi gode del suo riso riconoscente.
Se adunque alla forma si subordina non solo la.
linea, ma la luce e l'ombra, se non si esagera il
chiaro per andar dietro la natura, si è cortesi al
vero. La verità della natura è assunta a quella
dell'arte.
E questa egli cerca anche nel disaccordo dei
colori. « Et truovasi certa amicizia dei colori, che
l'uno giunto con l'altro li porgie dignità et grafia».
Ora, questa, che egli chiama amicizia, è più vera-
mente discordia: egli non cerca i colori che si ac-
carezzano, ma quelli che si oppongono: « Sarà ivi
grafia quando l'uno colore apresso molto sarà
dall'altro differente ». Un mezzo, anche questo,
per asservire il colore alla forma. « Il colore ros-
sato presso' al verde et cilestro si danno insieme
honore et vista ». Non sembra forse che l'Alberti
descriva alcune scene dipinte da Giotto, dove gli
angioli dalle 'vesti rosate fan discorde armonia
colle rocce verdastre e col cielo azzurro? Non è
questo forse il colore dissonante che fa gravitare
tutta l'attenzione sulla forma ?
S'è detto della teoria dei quattro colori messa
innanzi dall'Alberti. Altri cercò presso i filosofi
dell'antichità derivazione, appoggio o contradi-
zione a questa teoria. Per noi ogni valida spiega-
zione non può essere che intima alla sua arte. Che
l'Alberti contrariamente ad Aristotele, ammetta
quattro colori non è nè merito, nè vanto; non ci
dice anzi nulla: poiché per il filosofo greco il colore
era oggetto di indagine fisica, per il critico fioren-
tino era mezzo d'espressione artistica. Ma che egli,
deciso per la forma, sia rimasto quasi a mani vuote,
solo con quattro ribelli colori, della cui contesa
gode la forma, questo sì, ci dice qualcosa.
Ama l'Alberti che i colori siano in eterno contra-
sto per la loro tinta e per il loro tono: « sempre i
chiari sieno presso ad altri diversi coloii oscuri.
Sarà questa comparatione, ivi la bellezza dei colori
più chiara et più leggiadra ». Anche queste parole
non possono non far pensare alle pitture di Giotto
nella basilica di Assisi. S. Francesco passa sul manto
che gli stende il popolano: da, una parte e dal-
l'altra alcuni giovani osservano e se ne fanno beffe:
orbene la figura più vicina ha un manto oscuro che
contrasta rigorosamente con quello della figura più
lontana d'altro colore e chiaro. E il contrasto,
oltreché portare tutta l'attenzione sulla forma, fa
stridere all'intorno 'un ghigno beffardo, che s'in-
tride come ferro sino al cuore, e suggerisce il sen-
timento dominante della scena, Bisogna del resto
1.45
dintorno - per arte, direi quasi, di levare. Cosi,
Michelangiolo che distinse appunto, come l'Al-
berti, tra arte di porre e arte di levare, innanzi
ad un masso di marmo, intendeva creare attono
la figura clic vi scorgeva dentro, non l'ambiente,
■ma lo spazio.
Opposta era l'arte di Tiziano, il quale, come dice
il Eomazzo, « solea mescolarvi di colore chiaro
un poco più che non è la luce che voleva rappresen-
tare: e là dove la luce percote riflessa e offuscata
solea mescolarvi un poco più di coloie oscuro...E
quando le prime parti del corpo rilevano troppo e le
ultime fuggono assai in dentro, pare un rilievo
miracoloso, il che dà alla figura una furia mirabile».1
Segno certo di un finissimo senso critico aver com-
preso già sin d'allora come, esagerando la luce e
l'ombra, distaccandole fortemente, anziché unirle
con lenta graduazione, s'otteneva pure rilievo, ma
un rilievo ben diverso da quello solido e calmo pro-
dotto dal chiaroscuro, un rilievo etereo, miracoloso,
perchè pone innanzi le figure come fantasmi im-
provvisamente apparsi. Fantasmi, che in sè rias-
sumendo le vibrazioni del colore e della luce, se-
guono l'eterna vicenda dell'onda, impazienti di
stasi. Per la prima volta la pittura italiana otte-
neva il movimento nel suo proprio mezzo d'espres-
sione, il colore. Tutti i compromessi tra linea e
piano plastico cadevano. Tutti gli innesti che pur
avevan dato di buoni frutti, s'abbandonavano.
Ora la pianta fioriva dell'ingenita virtù. Mentre la
scultura chiedeva alla forma stessa il moto, contra-
poncndo le masse, la pittura si volgeva al colore e
alla luce: e così la mèta a cui si tendeva dal primo
sorgere 'dell'arte italiana era felicemente raggiunta.2
Vide poi l'Alberti come il chiaroscuro, questo
passaggio graduale dalla luce all'ombra, in natura
non esiste, ma è creato dall'arte. « Di dì in di fa la
natura che ti viene in odio le cose orride ed oscure...
Certo da natura amiamo le cose aperte et chiare;
adunque più si chiuda la via quale più stia facile a
peccare ». Saltano all'occhio, in tutta la loro bel-
lezza, le contradizioni dell'Alberti. Egli che tanto
intende affidarsi alla natura, ecco come poi l'ab-
bandona proprio quando la natura è piena di malìa
e tenta con la voce della sirena. Virtù ed arte si
nutrono di sacrificio! E l'Alberti sarebbe contento
se « apresso de' pictori il bianco si vendesse più che
le preziosissime gemme caro »; perchè così gli ar-
tisti sarebbero « più al vero, dolci et vezzosi ». Su-
perando ogni pregiudizio egli riesce a dire che, ub-
bidendo alle intime armonie dell'arte, anziché a
1 Lomazzo, Trattato della Pittura, pag. 27.
2 Lionello Venturi, La posizione dell'Italia nelle
arti figurative, in Nuova Antologia, 16 marzo 1915,
pag. 220.
poveri intenti di imitazione, si ha verso la realtà
e la natura più delicato riguardo. E da queste vi-
vissime parole balza l'immagine della fantasia,
che, tutta sfavillante di vezzi, tutta piena di dol-
cezze, conquista, amando, la realtà e la alza e la
trasfigura e poi gode del suo riso riconoscente.
Se adunque alla forma si subordina non solo la.
linea, ma la luce e l'ombra, se non si esagera il
chiaro per andar dietro la natura, si è cortesi al
vero. La verità della natura è assunta a quella
dell'arte.
E questa egli cerca anche nel disaccordo dei
colori. « Et truovasi certa amicizia dei colori, che
l'uno giunto con l'altro li porgie dignità et grafia».
Ora, questa, che egli chiama amicizia, è più vera-
mente discordia: egli non cerca i colori che si ac-
carezzano, ma quelli che si oppongono: « Sarà ivi
grafia quando l'uno colore apresso molto sarà
dall'altro differente ». Un mezzo, anche questo,
per asservire il colore alla forma. « Il colore ros-
sato presso' al verde et cilestro si danno insieme
honore et vista ». Non sembra forse che l'Alberti
descriva alcune scene dipinte da Giotto, dove gli
angioli dalle 'vesti rosate fan discorde armonia
colle rocce verdastre e col cielo azzurro? Non è
questo forse il colore dissonante che fa gravitare
tutta l'attenzione sulla forma ?
S'è detto della teoria dei quattro colori messa
innanzi dall'Alberti. Altri cercò presso i filosofi
dell'antichità derivazione, appoggio o contradi-
zione a questa teoria. Per noi ogni valida spiega-
zione non può essere che intima alla sua arte. Che
l'Alberti contrariamente ad Aristotele, ammetta
quattro colori non è nè merito, nè vanto; non ci
dice anzi nulla: poiché per il filosofo greco il colore
era oggetto di indagine fisica, per il critico fioren-
tino era mezzo d'espressione artistica. Ma che egli,
deciso per la forma, sia rimasto quasi a mani vuote,
solo con quattro ribelli colori, della cui contesa
gode la forma, questo sì, ci dice qualcosa.
Ama l'Alberti che i colori siano in eterno contra-
sto per la loro tinta e per il loro tono: « sempre i
chiari sieno presso ad altri diversi coloii oscuri.
Sarà questa comparatione, ivi la bellezza dei colori
più chiara et più leggiadra ». Anche queste parole
non possono non far pensare alle pitture di Giotto
nella basilica di Assisi. S. Francesco passa sul manto
che gli stende il popolano: da, una parte e dal-
l'altra alcuni giovani osservano e se ne fanno beffe:
orbene la figura più vicina ha un manto oscuro che
contrasta rigorosamente con quello della figura più
lontana d'altro colore e chiaro. E il contrasto,
oltreché portare tutta l'attenzione sulla forma, fa
stridere all'intorno 'un ghigno beffardo, che s'in-
tride come ferro sino al cuore, e suggerisce il sen-
timento dominante della scena, Bisogna del resto