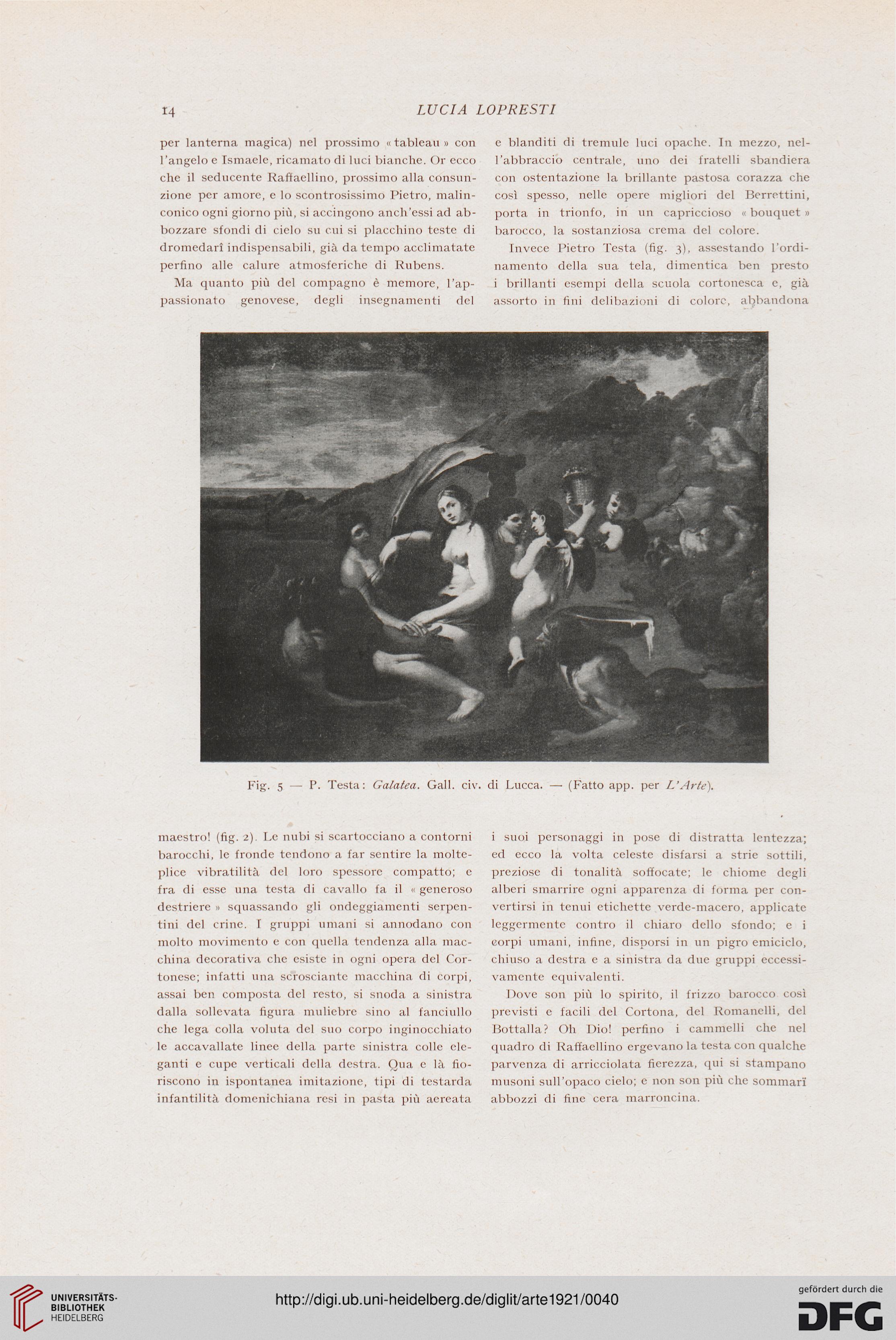LUCIA LOPRESTI
14
per lanterna magica) nel prossimo « tableau » con
l'angelo e Ismaele, ricamato di luci bianche. ( )r ecco
che il seducente Randellino, prossimo alla consun-
zione per amore, e lo scontrosissimo Pietro, malin-
conico ogni giorno più, si accingono anch'essi ad ab-
bozzare sfondi di ciclo su cui si placchino teste di
dromedari indispensabili, già da tempo acclimatate
perfino alle calure atmosferiche di Rubens.
Ma quanto più del compagno è memore, l'ap-
passionato genovese, degli insegnamenti del
e blanditi di tremule luci opache. In mezzo, nel-
l'abbraccio centrale, uno dei fratelli sbandiera
con ostentazione la brillante pastosa corazza che
così spesso, nelle opere migliori del Berrettini,
porta in trionfo, in un capriccioso «bouquet»
barocco, la sostanziosa crema del colore.
Invece Pietro Testa (fig. 3), assestando l'ordi-
namento della sua tela, dimentica ben presto
i brillanti esempi della scuola cortonesca e, già
assorto in fini delibazioni di colore, abbandona
Fig. 5 — P. Testa: Galatea. Gali. civ. di Lucca. — (Fatto app. per L'Arte).
maestro! (fig. 2). Le nubi si scartocciano a contorni
barocchi, le fronde tendono a far sentire la molte-
plice vibratilità del loro spessore compatto; e
fra di esse una testa di cavallo fa il « generoso
destriere » squassando gli ondeggiamenti serpen-
tini del crine. I gruppi umani si annodano con
molto movimento e con quella tendenza alla mac-
china decorativa che esiste in ogni opera del Cor-
tonese; infatti una scrosciante macchina (li Corpi,
assai ben composta del resto, si snoda a sinistra
dalla sollevata figura muliebre sino al fanciullo
che lega colla voluta de] suo corpo inginocchiato
le accavallate linee della parte sinistra colle ele-
ganti e cupe verticali della destra. Qua e là fio-
riscono in ispontanea imitazione, tipi di testarda,
infantilità domenichiana resi in pasta più acreata
i suoi personaggi in pose di distratta lentezza;
ed ecco la volta celeste disfarsi a strie sottili,
preziose di tonalità soffocate; le chiome degli
alberi smarrire ogni apparenza di forma per con-
vertirsi in tenui etichette verde-macero, applicate
leggermente contro il chiaro dello sfondo; e i
corpi umani, infine, disporsi in un pigro emiciclo,
chiuso a destra e a sinistra da due gruppi eccessi-
vamente equivalenti.
Dove son più lo spirito, il frizzo barocco così
previsti e facili del Cortona, del Romanelli, del
Bottalla? Oh Dio! perfino i cammelli che nel
quadro di Raffaellino ergevano la testa con qualche
parvenza di arricciolata fierezza, qui si stampano
musoni sull'opaco cielo; e non son più che sommari
abbozzi di fine cera marroni ina.
14
per lanterna magica) nel prossimo « tableau » con
l'angelo e Ismaele, ricamato di luci bianche. ( )r ecco
che il seducente Randellino, prossimo alla consun-
zione per amore, e lo scontrosissimo Pietro, malin-
conico ogni giorno più, si accingono anch'essi ad ab-
bozzare sfondi di ciclo su cui si placchino teste di
dromedari indispensabili, già da tempo acclimatate
perfino alle calure atmosferiche di Rubens.
Ma quanto più del compagno è memore, l'ap-
passionato genovese, degli insegnamenti del
e blanditi di tremule luci opache. In mezzo, nel-
l'abbraccio centrale, uno dei fratelli sbandiera
con ostentazione la brillante pastosa corazza che
così spesso, nelle opere migliori del Berrettini,
porta in trionfo, in un capriccioso «bouquet»
barocco, la sostanziosa crema del colore.
Invece Pietro Testa (fig. 3), assestando l'ordi-
namento della sua tela, dimentica ben presto
i brillanti esempi della scuola cortonesca e, già
assorto in fini delibazioni di colore, abbandona
Fig. 5 — P. Testa: Galatea. Gali. civ. di Lucca. — (Fatto app. per L'Arte).
maestro! (fig. 2). Le nubi si scartocciano a contorni
barocchi, le fronde tendono a far sentire la molte-
plice vibratilità del loro spessore compatto; e
fra di esse una testa di cavallo fa il « generoso
destriere » squassando gli ondeggiamenti serpen-
tini del crine. I gruppi umani si annodano con
molto movimento e con quella tendenza alla mac-
china decorativa che esiste in ogni opera del Cor-
tonese; infatti una scrosciante macchina (li Corpi,
assai ben composta del resto, si snoda a sinistra
dalla sollevata figura muliebre sino al fanciullo
che lega colla voluta de] suo corpo inginocchiato
le accavallate linee della parte sinistra colle ele-
ganti e cupe verticali della destra. Qua e là fio-
riscono in ispontanea imitazione, tipi di testarda,
infantilità domenichiana resi in pasta più acreata
i suoi personaggi in pose di distratta lentezza;
ed ecco la volta celeste disfarsi a strie sottili,
preziose di tonalità soffocate; le chiome degli
alberi smarrire ogni apparenza di forma per con-
vertirsi in tenui etichette verde-macero, applicate
leggermente contro il chiaro dello sfondo; e i
corpi umani, infine, disporsi in un pigro emiciclo,
chiuso a destra e a sinistra da due gruppi eccessi-
vamente equivalenti.
Dove son più lo spirito, il frizzo barocco così
previsti e facili del Cortona, del Romanelli, del
Bottalla? Oh Dio! perfino i cammelli che nel
quadro di Raffaellino ergevano la testa con qualche
parvenza di arricciolata fierezza, qui si stampano
musoni sull'opaco cielo; e non son più che sommari
abbozzi di fine cera marroni ina.