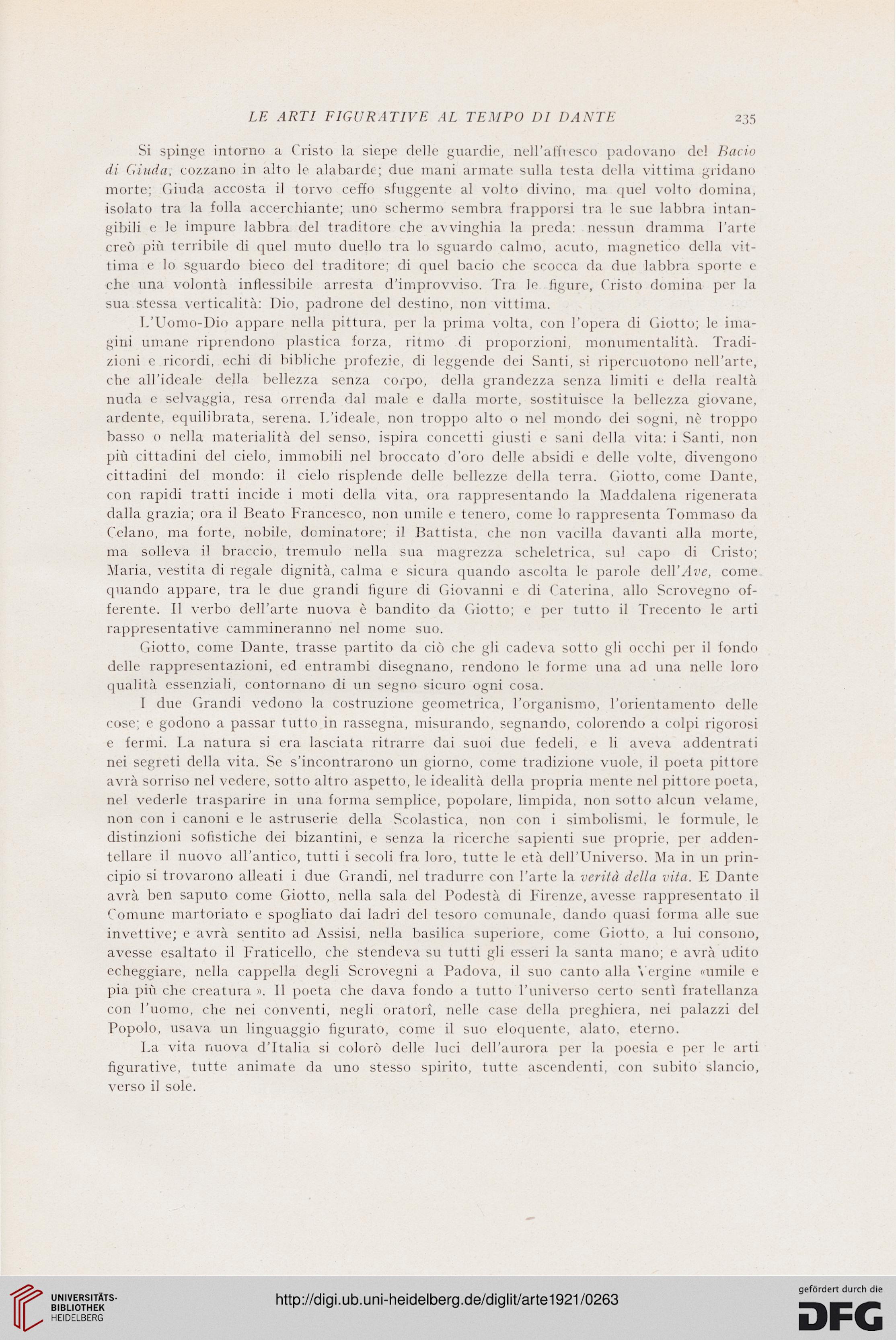LE ARTI FIGURATIVE AL TEMPO ni DANTE
235
Si spinge intorno a Cristo la siepe delle guardie, nell'affresco padovano del lincio
dì (linda, cozzano in alto le alabarde; duo mani armale sulla testa della vittima gridano
morti1: Giuda accosta il torvo ceffo sfuggente al volto divino, ma quel volto domina,
isolato tra la folla accerchiante; uno schermo sembra frapporsi tra le sue labbra intan-
gibili e le impure labbra del traditore che avvinghia la preda: nessun dramma l'arte
creò più terribile di quel muto duello tra lo sguardo calmo, acuto, magnetico della vit-
tima e lo sguardo bieco del traditore; di quel bacio che scocca da due labbra sporte e
clic una volontà inflessibile arresta d'improvviso. Ti a le figure, ( risto domina per la
sua stessa verticalità: Dio, padrone del destino, non vittima.
I.'Uomo-Dio appare nella pittura, per la prima volta, con l'opera di Giotto; le ima-
gini umane ripiendono plastica forza, ritmo di proporzioni, monumentalità. Tradi-
zioni e ricordi, echi di bibliche profezie, di leggende dei Santi, si ripercuotono nell'arte,
che all'ideale della bellezza senza corpo, della grandezza senza limiti e della realtà
nuda e selvaggia, resa orrenda dal male e dalla morte, sostituisce la bellezza giovane,
ardente, equilibrata, serena. L'ideale, non troppo alto o nel mondo dei sogni, nè troppo
basso o nella materialità del senso, ispira concetti giusti e sani della vita: i Santi, non
più cittadini del cielo, immobili nel broccato d'oro delle absidi e delle volte, divengono
cittadini del mondo: il cielo risplende delle bellezze della terra, Giotto, come Dante,
con rapidi tratti incide i moti della vita, ora rappresentando la Maddalena rigenerata
dalla grazia; ora il Beato Francesco, non umile e tenero, come lo rappresenta Tommaso da
Celano, ma forte, nobile, dominatore; il Battista, che non vacilla davanti alla morte,
ma solleva il braccio, tremulo nella sua magrezza scheletrica, su! capo di ('risto;
Maria, vestita di regale dignità, calma e sicura quando ascolta le parole dell' Ave, come
(piando appare, tra le due grandi figure di Giovanni e di Caterina, allo Scrovegno of-
ferente. Il verbo dell'arte nuova è bandito da Ciotto; e per tutto il Trecento le arti
rappresentative cammineranno nel nome suo.
Ciotto, come Dante, trasse partito da ciò che gli cadeva sotto gli occhi per il fondo
delle rappresentazioni, ed entrambi disegnano, rendono le forme una ad una nelle loro
qualità essenziali, contornano di un segno sicuro ogni cosa.
I due Grandi vedono la costruzione geometrica, l'organismo, l'orientamento delle
cose; e godono a passar tutto in rassegna, misurando, segnando, colorendo a colpi rigorosi
e fermi. La natura si era lasciata ritrarre dai suoi due fedeli, e li aveva addentrati
nei segreti della vita. Se s'incontrarono un giorno, come tradizione vuole, il poeta pittore
avrà sorriso nel vedere, sotto altro aspetto, le idealità della propria niente nel pittore poeta,
nel vederle trasparire in una forma semplice, popolare, limpida, non sotto alcun velame,
non con i canoni e le astruserie della Scolastica, non con i simbolismi, le formule, le
distinzioni sofìstiche dei bizantini, e senza la ricerche sapienti sue proprie, per adden-
tellare il nuovo all'antico, tutti i secoli fra loro, tutte le età dell'Universo. Ma in un prin-
cipio si trovarono alleati i due Grandi, nel tradurre con l'arte la verità della vita. E Dante
avrà ben saputo come Giotto, nella sala del Podestà di Firenze, avesse rappresentato il
Comune martoriato e spogliato dai ladri del tesoro comunale, dando quasi forma alle sue
invettive; e avrà sentito ad Assisi, nella basilica superiore, c ome Ciotto, a lui consono,
avesse esaltato il Fraticello, che stendeva su tutti gli esseri la santa mano; e avrà udito
echeggiare, nella cappella degli Scrovegni a Padova, il suo canto alla Vergine «umile e
pia più che creatura ». 11 poeta che dava fondo a tutto l'universo certo sentì fratellanza
con l'uomo, che nei conventi, negli oratori, nelle case della preghiera, nei palazzi del
Popolo, usava un linguaggio figurato, come il suo eloquente, alato, eterno.
La vita nuova d'Italia si colorò delle luci dell'aurora per la poesia e per le arti
figurative, tutte animate da uno stesso spirito, tutte ascendenti, con subito slancio,
verso il sole.
235
Si spinge intorno a Cristo la siepe delle guardie, nell'affresco padovano del lincio
dì (linda, cozzano in alto le alabarde; duo mani armale sulla testa della vittima gridano
morti1: Giuda accosta il torvo ceffo sfuggente al volto divino, ma quel volto domina,
isolato tra la folla accerchiante; uno schermo sembra frapporsi tra le sue labbra intan-
gibili e le impure labbra del traditore che avvinghia la preda: nessun dramma l'arte
creò più terribile di quel muto duello tra lo sguardo calmo, acuto, magnetico della vit-
tima e lo sguardo bieco del traditore; di quel bacio che scocca da due labbra sporte e
clic una volontà inflessibile arresta d'improvviso. Ti a le figure, ( risto domina per la
sua stessa verticalità: Dio, padrone del destino, non vittima.
I.'Uomo-Dio appare nella pittura, per la prima volta, con l'opera di Giotto; le ima-
gini umane ripiendono plastica forza, ritmo di proporzioni, monumentalità. Tradi-
zioni e ricordi, echi di bibliche profezie, di leggende dei Santi, si ripercuotono nell'arte,
che all'ideale della bellezza senza corpo, della grandezza senza limiti e della realtà
nuda e selvaggia, resa orrenda dal male e dalla morte, sostituisce la bellezza giovane,
ardente, equilibrata, serena. L'ideale, non troppo alto o nel mondo dei sogni, nè troppo
basso o nella materialità del senso, ispira concetti giusti e sani della vita: i Santi, non
più cittadini del cielo, immobili nel broccato d'oro delle absidi e delle volte, divengono
cittadini del mondo: il cielo risplende delle bellezze della terra, Giotto, come Dante,
con rapidi tratti incide i moti della vita, ora rappresentando la Maddalena rigenerata
dalla grazia; ora il Beato Francesco, non umile e tenero, come lo rappresenta Tommaso da
Celano, ma forte, nobile, dominatore; il Battista, che non vacilla davanti alla morte,
ma solleva il braccio, tremulo nella sua magrezza scheletrica, su! capo di ('risto;
Maria, vestita di regale dignità, calma e sicura quando ascolta le parole dell' Ave, come
(piando appare, tra le due grandi figure di Giovanni e di Caterina, allo Scrovegno of-
ferente. Il verbo dell'arte nuova è bandito da Ciotto; e per tutto il Trecento le arti
rappresentative cammineranno nel nome suo.
Ciotto, come Dante, trasse partito da ciò che gli cadeva sotto gli occhi per il fondo
delle rappresentazioni, ed entrambi disegnano, rendono le forme una ad una nelle loro
qualità essenziali, contornano di un segno sicuro ogni cosa.
I due Grandi vedono la costruzione geometrica, l'organismo, l'orientamento delle
cose; e godono a passar tutto in rassegna, misurando, segnando, colorendo a colpi rigorosi
e fermi. La natura si era lasciata ritrarre dai suoi due fedeli, e li aveva addentrati
nei segreti della vita. Se s'incontrarono un giorno, come tradizione vuole, il poeta pittore
avrà sorriso nel vedere, sotto altro aspetto, le idealità della propria niente nel pittore poeta,
nel vederle trasparire in una forma semplice, popolare, limpida, non sotto alcun velame,
non con i canoni e le astruserie della Scolastica, non con i simbolismi, le formule, le
distinzioni sofìstiche dei bizantini, e senza la ricerche sapienti sue proprie, per adden-
tellare il nuovo all'antico, tutti i secoli fra loro, tutte le età dell'Universo. Ma in un prin-
cipio si trovarono alleati i due Grandi, nel tradurre con l'arte la verità della vita. E Dante
avrà ben saputo come Giotto, nella sala del Podestà di Firenze, avesse rappresentato il
Comune martoriato e spogliato dai ladri del tesoro comunale, dando quasi forma alle sue
invettive; e avrà sentito ad Assisi, nella basilica superiore, c ome Ciotto, a lui consono,
avesse esaltato il Fraticello, che stendeva su tutti gli esseri la santa mano; e avrà udito
echeggiare, nella cappella degli Scrovegni a Padova, il suo canto alla Vergine «umile e
pia più che creatura ». 11 poeta che dava fondo a tutto l'universo certo sentì fratellanza
con l'uomo, che nei conventi, negli oratori, nelle case della preghiera, nei palazzi del
Popolo, usava un linguaggio figurato, come il suo eloquente, alato, eterno.
La vita nuova d'Italia si colorò delle luci dell'aurora per la poesia e per le arti
figurative, tutte animate da uno stesso spirito, tutte ascendenti, con subito slancio,
verso il sole.