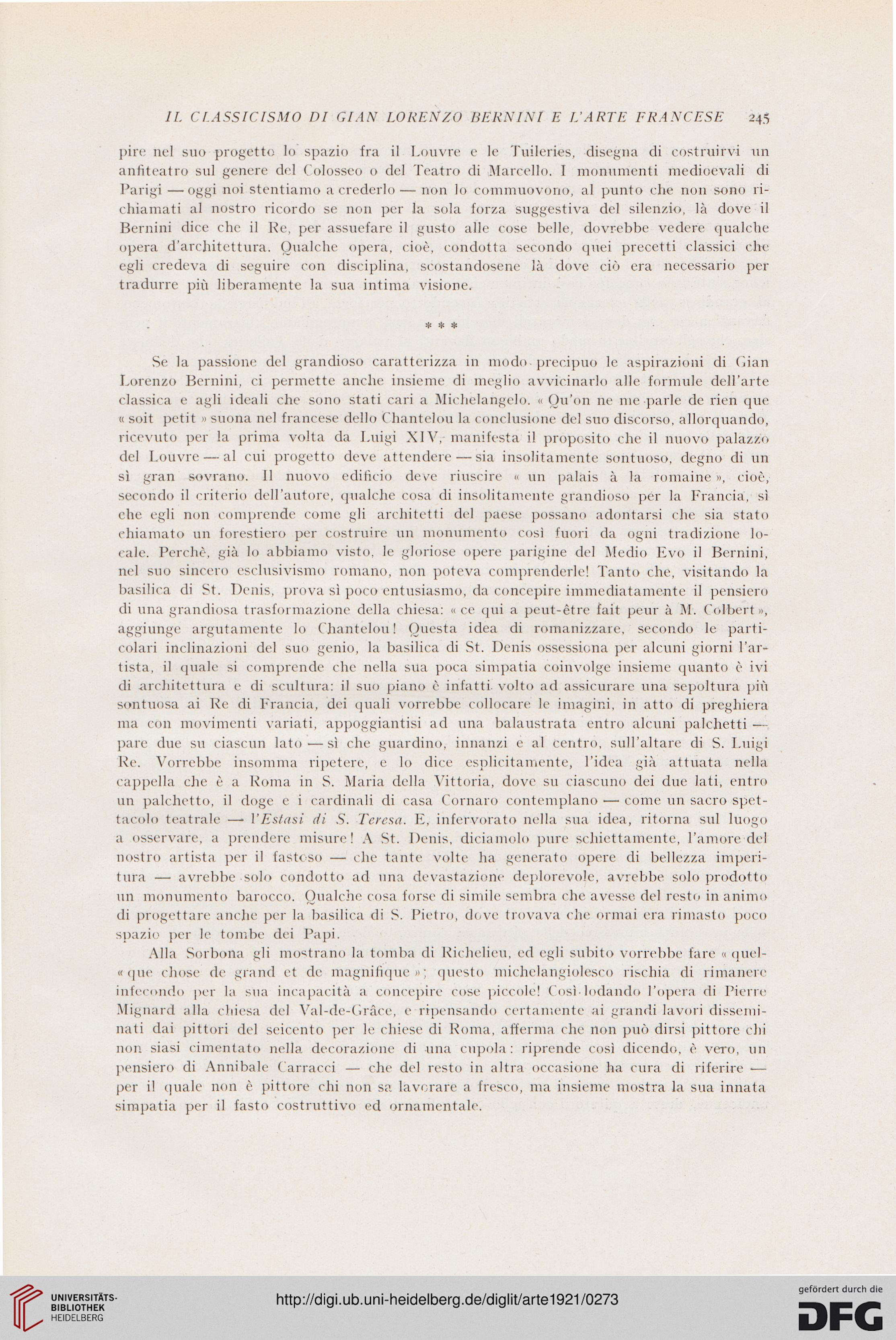//. CLASSICISMO DI GIAN LORENZO BERNINI E L'ARTE FRANCESE J45
pire nel suo progetto lo spazio fra il Louvre e le Tuileries, disegna di costruirvi un
anfiteatro sul genere del Colosseo 0 del Teatro di Marcello. I monumenti medioevali di
Parigi —oggi noi stentiamo a crederlo — non lo commuovono, al punto die non sono ri-
chiamati al nostro ricordo se non per la sola forza Suggestiva del silenzio, là dove il
Bernini ilice che il Re, per assuefare il gusto alle cose belle, dovrebbe vedere qualche
opera d'architettura. Qualche opera, cioè, condotta secondo quei precetti classici che
egli credeva di seguire con disciplina, scostandosene là dove ci1'» era necessario per
tradurre più liberamente la sua intima visione.
* * *
Se la passione del grandioso caratterizza in modo precipuo le aspirazioni di Gian
Lorenzo Bernini, ci permette anche insieme di meglio avvicinarlo alle formule dell'arte
classica e agli ideali che sono stati cari a Michelangelo, t Qu'on ne me parie de rien quo
« soit petit » suona nel francese dello Chantelou la conclusione del suo discorso, allorquando,
ricevuto per la prima volta da Luigi XIV; manifesta il proposito che il nuovo palazzo
del Louvre — al cui progetto deve attendere — sia insolitamente sontuoso, degno di un
sì gran sovrano. Il nuovo edificio dece riuscire « un palais à la romaine », cioè,
secondo il criterio dell'autore, qualche cosa di insolitamente grandioso pér la Francia, sì
che egli non comprende come gli architetti del paese possano adontarsi che sia stato
chiamato un forestiero per costruire un monumento cosi fuori da ogni tradizione lo-
cale. Perchè, già lo abbiamo visto, le gloriose opere parigine del Medio Evo il Bernini,
nel suo sincero esclusivismo romano, non poteva comprenderle! Tanto che, visitando la
basilica di St. Denis, prova sì poco entusiasmo, da concepire immediatamente il pensiero
di una grandiosa trasformazione della chiesa: «ce qui a peut-étre fait peur à M. Colbert >,
aggiunge argutamente lo ChantelouI Questa idea di romanizzale, secondo le parti-
colari inclinazioni del suo genio, la basilica di St. Denis ossessiona per alcuni giorni l'ar-
tica, il «piale si comprende che nella sua poca simpatia coinvolge insieme quanto è ivi
di architettura e di scultura: il suo piano è infatti volto ad assicurare una sepoltura più
sontuosa ai Re di Francia, dei quali vorrebbe collocare le imagini, in atto di preghiera
ma con movimenti variati, appoggiatisi ad una balaustrata entro alcuni palchetti —
pare due su ciascun lato—sì che guardino, innanzi e al centro, sull'altare di S. Luigi
Re. Vorrebbe insomma ripetere, e lo dice esplicitamente, l'idea già attuata nella
cappella che è a Roma in S. Maria della Vittoria, dove su ciascuno dei due lati, entro
un palchetto, il doge e i cardinali di casa Cornalo contemplano — come un saero spet-
tacolo teatrale —■ l'Estasi di S. Teresa. E, infervorato nella sua idea, ritorna sul luogo
a osservare, a prendere misure! A St. Denis, diciamolo pure schiettamente, l'amore del
nostro artista per il fastoso — che tante volte ha generato opere di bellezza imperi-
tura — avrebbe solo condotto ad una devastazione deplorevole, avrebbe solo prodotto
un monumento barocco. Qualche i osa forse di simile sembra che avesse del resto inanimo
di progettare anche per la basilica di S. Pietro, dove trovava che ormai era rimasto poco
spazio per le tombe dei l'api.
Alla Sorbona gli mostrano la tomba di Richelieu, ed egli subito vorrebbe fare « quel-
« <pie chose de grand et de magnifìque questo michelangiolesco rischia di rimanere
infecondo per la sua incapacità a concepire cosi' piccole! (Osi lodando l'opera di l'iene
Mignard alla chiesa del Val-de-Gràce, e ripensando certamente ai grandi lavori dissemi-
nati dai pittori del seicento per le chiese di Roma, afferma che non può dirsi pittore olii
non. siasi cimentato nella decorazione di una cupola: riprende così dicendo, è vero, un
pensiero di Annibale Carracci — elio del resto in altra occasione ha cura di riferire >—
per il (piale non è [littore chi non sa lavorare a fresco, ma insieme mostra la sua innata
simpatia per il fasto costruttivo ed ornamentale.
pire nel suo progetto lo spazio fra il Louvre e le Tuileries, disegna di costruirvi un
anfiteatro sul genere del Colosseo 0 del Teatro di Marcello. I monumenti medioevali di
Parigi —oggi noi stentiamo a crederlo — non lo commuovono, al punto die non sono ri-
chiamati al nostro ricordo se non per la sola forza Suggestiva del silenzio, là dove il
Bernini ilice che il Re, per assuefare il gusto alle cose belle, dovrebbe vedere qualche
opera d'architettura. Qualche opera, cioè, condotta secondo quei precetti classici che
egli credeva di seguire con disciplina, scostandosene là dove ci1'» era necessario per
tradurre più liberamente la sua intima visione.
* * *
Se la passione del grandioso caratterizza in modo precipuo le aspirazioni di Gian
Lorenzo Bernini, ci permette anche insieme di meglio avvicinarlo alle formule dell'arte
classica e agli ideali che sono stati cari a Michelangelo, t Qu'on ne me parie de rien quo
« soit petit » suona nel francese dello Chantelou la conclusione del suo discorso, allorquando,
ricevuto per la prima volta da Luigi XIV; manifesta il proposito che il nuovo palazzo
del Louvre — al cui progetto deve attendere — sia insolitamente sontuoso, degno di un
sì gran sovrano. Il nuovo edificio dece riuscire « un palais à la romaine », cioè,
secondo il criterio dell'autore, qualche cosa di insolitamente grandioso pér la Francia, sì
che egli non comprende come gli architetti del paese possano adontarsi che sia stato
chiamato un forestiero per costruire un monumento cosi fuori da ogni tradizione lo-
cale. Perchè, già lo abbiamo visto, le gloriose opere parigine del Medio Evo il Bernini,
nel suo sincero esclusivismo romano, non poteva comprenderle! Tanto che, visitando la
basilica di St. Denis, prova sì poco entusiasmo, da concepire immediatamente il pensiero
di una grandiosa trasformazione della chiesa: «ce qui a peut-étre fait peur à M. Colbert >,
aggiunge argutamente lo ChantelouI Questa idea di romanizzale, secondo le parti-
colari inclinazioni del suo genio, la basilica di St. Denis ossessiona per alcuni giorni l'ar-
tica, il «piale si comprende che nella sua poca simpatia coinvolge insieme quanto è ivi
di architettura e di scultura: il suo piano è infatti volto ad assicurare una sepoltura più
sontuosa ai Re di Francia, dei quali vorrebbe collocare le imagini, in atto di preghiera
ma con movimenti variati, appoggiatisi ad una balaustrata entro alcuni palchetti —
pare due su ciascun lato—sì che guardino, innanzi e al centro, sull'altare di S. Luigi
Re. Vorrebbe insomma ripetere, e lo dice esplicitamente, l'idea già attuata nella
cappella che è a Roma in S. Maria della Vittoria, dove su ciascuno dei due lati, entro
un palchetto, il doge e i cardinali di casa Cornalo contemplano — come un saero spet-
tacolo teatrale —■ l'Estasi di S. Teresa. E, infervorato nella sua idea, ritorna sul luogo
a osservare, a prendere misure! A St. Denis, diciamolo pure schiettamente, l'amore del
nostro artista per il fastoso — che tante volte ha generato opere di bellezza imperi-
tura — avrebbe solo condotto ad una devastazione deplorevole, avrebbe solo prodotto
un monumento barocco. Qualche i osa forse di simile sembra che avesse del resto inanimo
di progettare anche per la basilica di S. Pietro, dove trovava che ormai era rimasto poco
spazio per le tombe dei l'api.
Alla Sorbona gli mostrano la tomba di Richelieu, ed egli subito vorrebbe fare « quel-
« <pie chose de grand et de magnifìque questo michelangiolesco rischia di rimanere
infecondo per la sua incapacità a concepire cosi' piccole! (Osi lodando l'opera di l'iene
Mignard alla chiesa del Val-de-Gràce, e ripensando certamente ai grandi lavori dissemi-
nati dai pittori del seicento per le chiese di Roma, afferma che non può dirsi pittore olii
non. siasi cimentato nella decorazione di una cupola: riprende così dicendo, è vero, un
pensiero di Annibale Carracci — elio del resto in altra occasione ha cura di riferire >—
per il (piale non è [littore chi non sa lavorare a fresco, ma insieme mostra la sua innata
simpatia per il fasto costruttivo ed ornamentale.