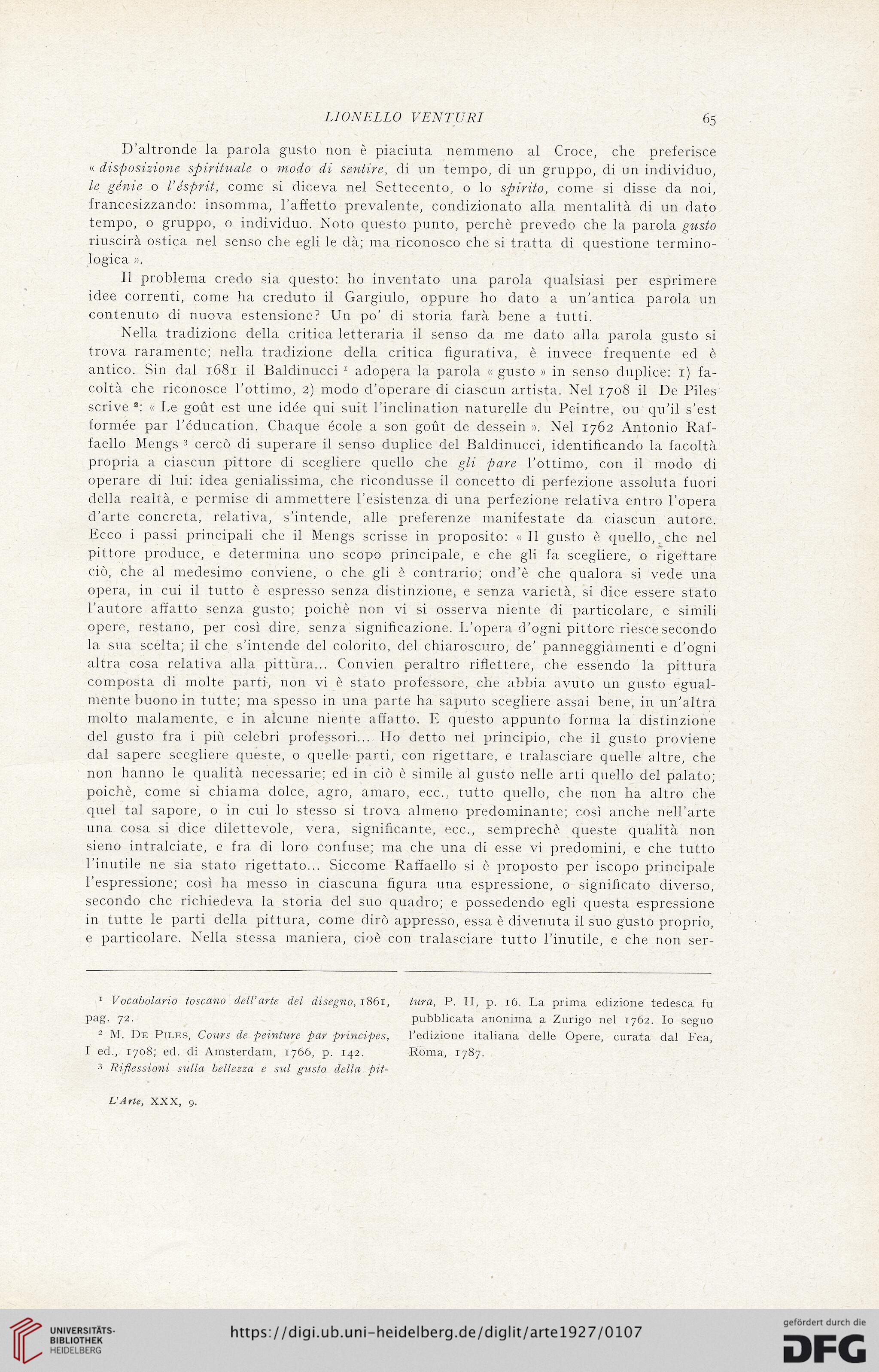LIONELLO VENTURI
65
D’altronde la parola gusto non è piaciuta nemmeno al Croce, che preferisce
« disposizione spirituale o modo di sentire, di un tempo, di un gruppo, di un individuo,
le génie o l’ésprit, come si diceva nel Settecento, o lo spirito, come si disse da noi,
francesizzando: insomma, l’affetto prevalente, condizionato alla mentalità di un dato
tempo, o gruppo, o individuo. Noto questo punto, perchè prevedo che la parola gusto
riuscirà ostica nel senso che egli le dà; ma riconosco che si tratta di questione termino-
logica ».
Il problema credo sia questo: ho inventato una parola qualsiasi per esprimere
idee correnti, come ha creduto il Gargiulo, oppure ho dato a un’antica parola un
contenuto di nuova estensione? Un po’ di storia farà bene a tutti.
Nella tradizione della critica letteraria il senso da me dato alla parola gusto si
trova raramente; nella tradizione della critica figurativa, è invece frequente ed è
antico. Sin dal 1681 il Baldinucci 1 adopera la parola « gusto » in senso duplice: 1) fa-
coltà che riconosce l’ottimo, 2) modo d’operare di ciascun artista. Nel 1708 il De Piles
scrive 2: « Le gout est une idée qui suit l’inclination naturelle du Peintre, ou qu’il s’est
formée par l’éducation. Chaque école a son goùt de dessein ». Nel 1762 Antonio Raf-
faello Mengs 3 cercò di superare il senso duplice del Baldinucci, identificando la facoltà
propria a ciascun pittore di scegliere quello che gli pare l’ottimo, con il modo di
operare di lui: idea genialissima, che ricondusse il concetto di perfezione assoluta fuori
della realtà, e permise di ammettere l’esistenza di una perfezione relativa entro l’opera
d’arte concreta, relativa, s’intende, alle preferenze manifestate da ciascun autore.
Ecco i passi principali che il Mengs scrisse in proposito: «Il gusto è quello, che nel
pittore produce, e determina uno scopo principale, e che gli fa scegliere, o rigettare
ciò, che al medesimo conviene, o che gli è contrario; ond’è che qualora si vede una
opera, in cui il tutto è espresso senza distinzione, e senza varietà, si dice essere stato
l’autore affatto senza gusto; poiché non vi si osserva niente di particolare, e simili
opere, restano, per così dire, senza significazione. L’opera d’ogni pittore riesce secondo
la sua scelta; il che s’intende del colorito, del chiaroscuro, de’ panneggiamenti e d’ogni
altra cosa relativa alla pittura... Convien peraltro riflettere, che essendo la pittura
composta di molte parti, non vi è, stato professore, che abbia avuto un gusto egual-
mente buono in tutte; ma spesso in una parte ha saputo scegliere assai bene, in un’altra
molto malamente, e in alcune niente affatto. E questo appunto forma la distinzione
del gusto fra i più celebri professori... Ho detto nel principio, che il gusto proviene
dal sapere scegliere queste, o quelle parti, con rigettare, e tralasciare quelle altre, che
non hanno le qualità necessarie; ed in ciò è simile al gusto nelle arti quello del palato;
poiché, come si chiama dolce, agro, amaro, ecc., tutto quello, che non ha altro che
quel tal sapore, o in cui lo stesso si trova almeno predominante; così anche nell’arte
una cosa si dice dilettevole, vera, significante, ecc., semprechè queste qualità non
sieno intralciate, e fra. di loro confuse; ma che una di esse vi predomini, e che tutto
l’inutile ne sia stato rigettato... Siccome Raffaello si è proposto per iscopo principale
l’espressione; così ha messo in ciascuna figura una espressione, o significato diverso,
secondo che richiedeva la storia del suo quadro; e possedendo egli questa espressione
in tutte le parti della pittura, come dirò appresso, essa è divenuta il suo gusto proprio,
e particolare. Nella stessa maniera, cioè con tralasciare tutto l’inutile, e che non ser-
1 Vocabolario toscano dell' arte del disegno, 1861,
pag. 72.
2 M. De Piles, Cours de peinture par principes,
I ed., 1708; ed. di Amsterdam, 1766, p. 142.
3 Riflessioni sulla bellezza e sul gusto della , pit-
tura, P. II, p. 16. La prima edizione tedesca fu
pubblicata anonima a Zurigo nel .1762. Io seguo
l’edizione italiana delle Opere, curata dal Fea,
Roma, 1787.
L’Arte, XXX, 9.
65
D’altronde la parola gusto non è piaciuta nemmeno al Croce, che preferisce
« disposizione spirituale o modo di sentire, di un tempo, di un gruppo, di un individuo,
le génie o l’ésprit, come si diceva nel Settecento, o lo spirito, come si disse da noi,
francesizzando: insomma, l’affetto prevalente, condizionato alla mentalità di un dato
tempo, o gruppo, o individuo. Noto questo punto, perchè prevedo che la parola gusto
riuscirà ostica nel senso che egli le dà; ma riconosco che si tratta di questione termino-
logica ».
Il problema credo sia questo: ho inventato una parola qualsiasi per esprimere
idee correnti, come ha creduto il Gargiulo, oppure ho dato a un’antica parola un
contenuto di nuova estensione? Un po’ di storia farà bene a tutti.
Nella tradizione della critica letteraria il senso da me dato alla parola gusto si
trova raramente; nella tradizione della critica figurativa, è invece frequente ed è
antico. Sin dal 1681 il Baldinucci 1 adopera la parola « gusto » in senso duplice: 1) fa-
coltà che riconosce l’ottimo, 2) modo d’operare di ciascun artista. Nel 1708 il De Piles
scrive 2: « Le gout est une idée qui suit l’inclination naturelle du Peintre, ou qu’il s’est
formée par l’éducation. Chaque école a son goùt de dessein ». Nel 1762 Antonio Raf-
faello Mengs 3 cercò di superare il senso duplice del Baldinucci, identificando la facoltà
propria a ciascun pittore di scegliere quello che gli pare l’ottimo, con il modo di
operare di lui: idea genialissima, che ricondusse il concetto di perfezione assoluta fuori
della realtà, e permise di ammettere l’esistenza di una perfezione relativa entro l’opera
d’arte concreta, relativa, s’intende, alle preferenze manifestate da ciascun autore.
Ecco i passi principali che il Mengs scrisse in proposito: «Il gusto è quello, che nel
pittore produce, e determina uno scopo principale, e che gli fa scegliere, o rigettare
ciò, che al medesimo conviene, o che gli è contrario; ond’è che qualora si vede una
opera, in cui il tutto è espresso senza distinzione, e senza varietà, si dice essere stato
l’autore affatto senza gusto; poiché non vi si osserva niente di particolare, e simili
opere, restano, per così dire, senza significazione. L’opera d’ogni pittore riesce secondo
la sua scelta; il che s’intende del colorito, del chiaroscuro, de’ panneggiamenti e d’ogni
altra cosa relativa alla pittura... Convien peraltro riflettere, che essendo la pittura
composta di molte parti, non vi è, stato professore, che abbia avuto un gusto egual-
mente buono in tutte; ma spesso in una parte ha saputo scegliere assai bene, in un’altra
molto malamente, e in alcune niente affatto. E questo appunto forma la distinzione
del gusto fra i più celebri professori... Ho detto nel principio, che il gusto proviene
dal sapere scegliere queste, o quelle parti, con rigettare, e tralasciare quelle altre, che
non hanno le qualità necessarie; ed in ciò è simile al gusto nelle arti quello del palato;
poiché, come si chiama dolce, agro, amaro, ecc., tutto quello, che non ha altro che
quel tal sapore, o in cui lo stesso si trova almeno predominante; così anche nell’arte
una cosa si dice dilettevole, vera, significante, ecc., semprechè queste qualità non
sieno intralciate, e fra. di loro confuse; ma che una di esse vi predomini, e che tutto
l’inutile ne sia stato rigettato... Siccome Raffaello si è proposto per iscopo principale
l’espressione; così ha messo in ciascuna figura una espressione, o significato diverso,
secondo che richiedeva la storia del suo quadro; e possedendo egli questa espressione
in tutte le parti della pittura, come dirò appresso, essa è divenuta il suo gusto proprio,
e particolare. Nella stessa maniera, cioè con tralasciare tutto l’inutile, e che non ser-
1 Vocabolario toscano dell' arte del disegno, 1861,
pag. 72.
2 M. De Piles, Cours de peinture par principes,
I ed., 1708; ed. di Amsterdam, 1766, p. 142.
3 Riflessioni sulla bellezza e sul gusto della , pit-
tura, P. II, p. 16. La prima edizione tedesca fu
pubblicata anonima a Zurigo nel .1762. Io seguo
l’edizione italiana delle Opere, curata dal Fea,
Roma, 1787.
L’Arte, XXX, 9.